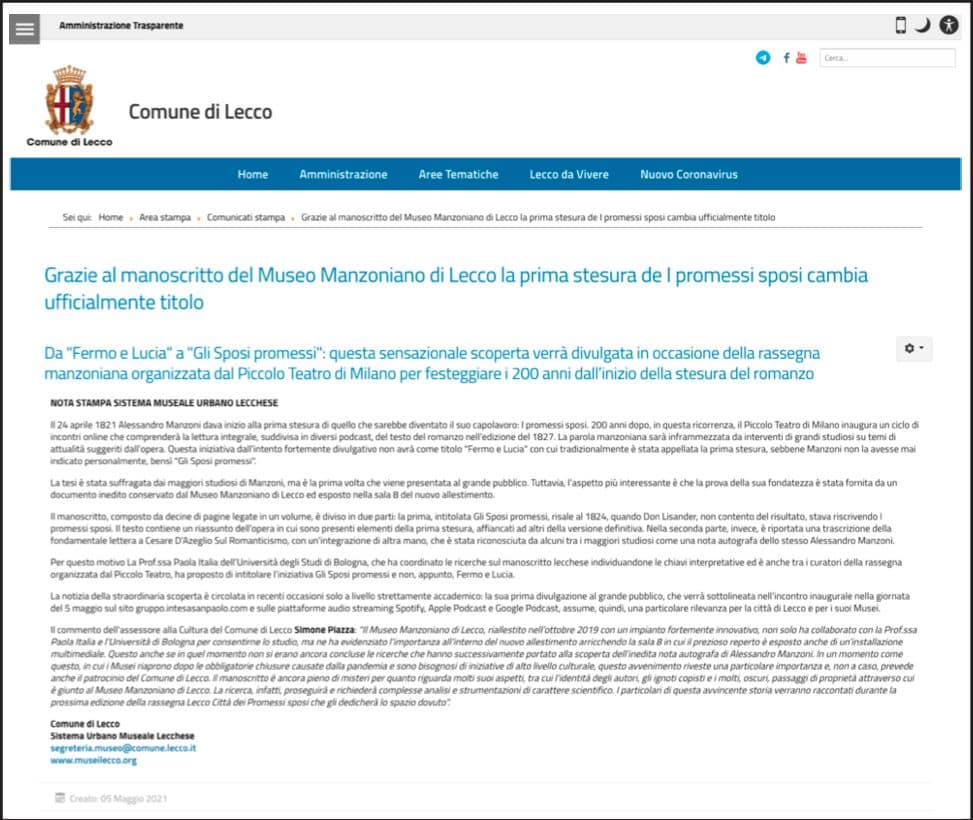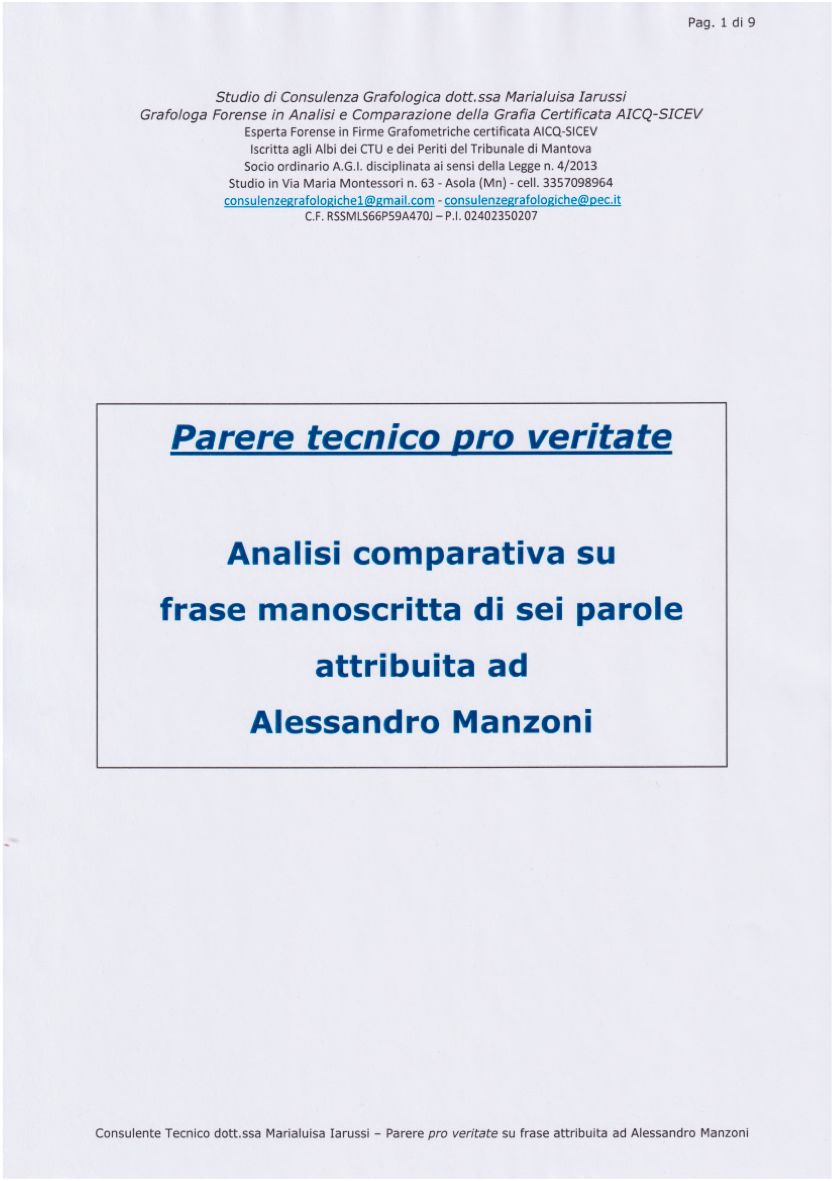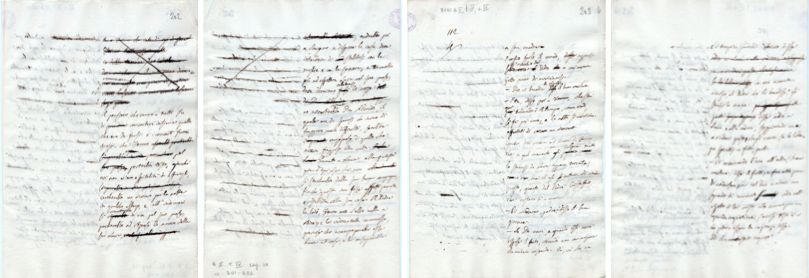Milano, venerdì 28 gennaio 2022.
Riceviamo e pubblichiamo.
A riscontro della Nota che il lettore trova presentata più sotto, il Prof. Angelo Stella, Presidente del Centro Nazionale Studi Manzoniani, ha voluto cortesemente trasmetterci il suo orientamento sulle questioni da noi sollevate.
«La ringrazio delle sue osservazioni. Credo che studiose e studiosi le prenderanno in considerazione, e che si potrà arrivare, su aspetti ancora giustamente dibattuti, a conclusioni serenamente condivise.
Con i migliori auguri, Angelo Stella».
Ringraziamo il Presidente Prof. Stella per la sua saggia e lungimirante presa di posizione; la consideriamo condivisa da tutto il Comitato Scientifico del Centro Nazionale Studi Manzoniani augurandoci sia anche prodroma a una revisione dell’intera questione sollevata dal nostro Centro Studi.
Milano, martedì 18 gennaio 2022.
Con quanto segue esponiamo riflessioni esplicitamente critiche sul come è stato recentemente presentato al pubblico il manoscritto “Gli Sposi promessi”, conservato presso il Museo Manzoniano di Lecco.
Quelle istanze accademiche che lo hanno recentemente proposto come elemento portante di una “rivoluzione” nella critica manzonista (nonché i responsabili culturali e museali della città di Lecco, che se ne sono fatti ingenui mallevadori), hanno sdoganato una nuova fattispecie di comunicazione “culturale”, tutta basata sulla sciatteria documentale ancorché proposta da figure di indubbia esperienza e qualità intellettuale: un pessimo esempio per tutti e un ceffone a piena mano alla cultura di ispirazione manzoniana.
Amichevolmente, suggeriamo ai diversi attori in campo di ricominciare da capo, ma questa volta con ben altre metodologie e con la competenza che hanno già mostrato in altre occasioni!
Attenzione!
A consentirne una più agevole identificazione, in questa nostra Nota, il manoscritto conservato presso il Museo Manzoniano di Lecco, sarà da noi indicato come «Manoscritto Lecco 170», dal numero di ingresso al Museo stesso, segnato sul risguardo Zr alla copertina posteriore.
FILOLOGIA MANZONISTA
ALLO SBANDO?
A proposito del «Manoscritto Lecco 170» conservato presso il Museo Manzoniano di Lecco.

6 PAROLE
dette autografe di Manzoni con un ameno “fidatevi di noi”.
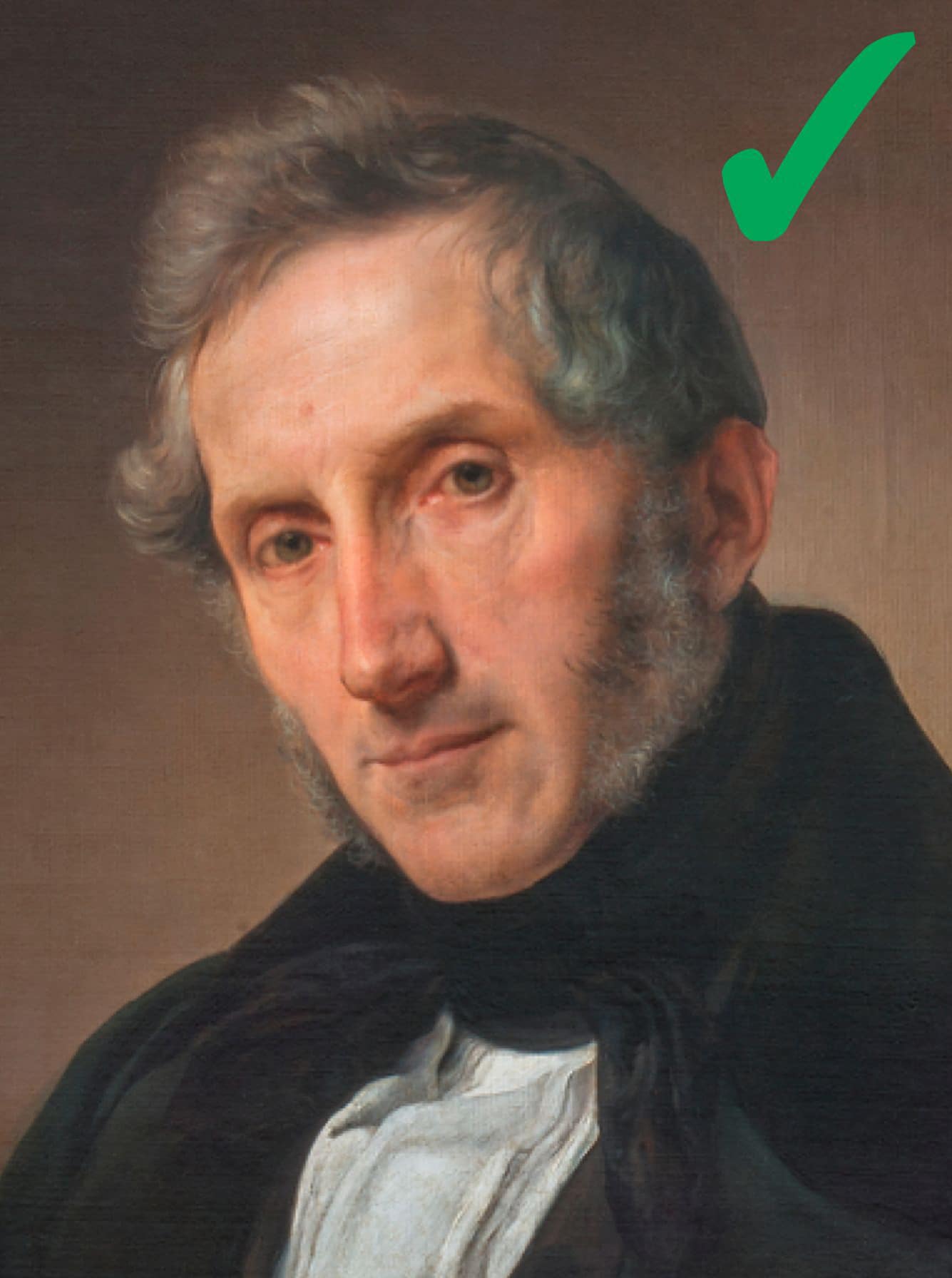
Valutate invece come apocrife dal
“PARERE PRO VERITATE”
della perizia grafologica da noi predisposta.
UN INCREDIBILE SILENZIO
su una più che probabile manipolazione dell’intero documento tra il 1964 e il 1988.
203 ERRORI
nella “trascrizione diplomatica” del «Manoscritto Lecco 170».
23 VISTOSE DIFFORMITÀ
di trama rispetto alla “Prima Minuta” di A. Manzoni.
Così una filologia distratta e pasticciona
si autocondanna all’impotenza e ridicolizza Lecco città di Manzoni e dei Promessi Sposi!
Chiediamo l’immediata riapertura dell’indagine conoscitiva sul «Manoscritto Lecco 170», garantita dal controllo pubblico.
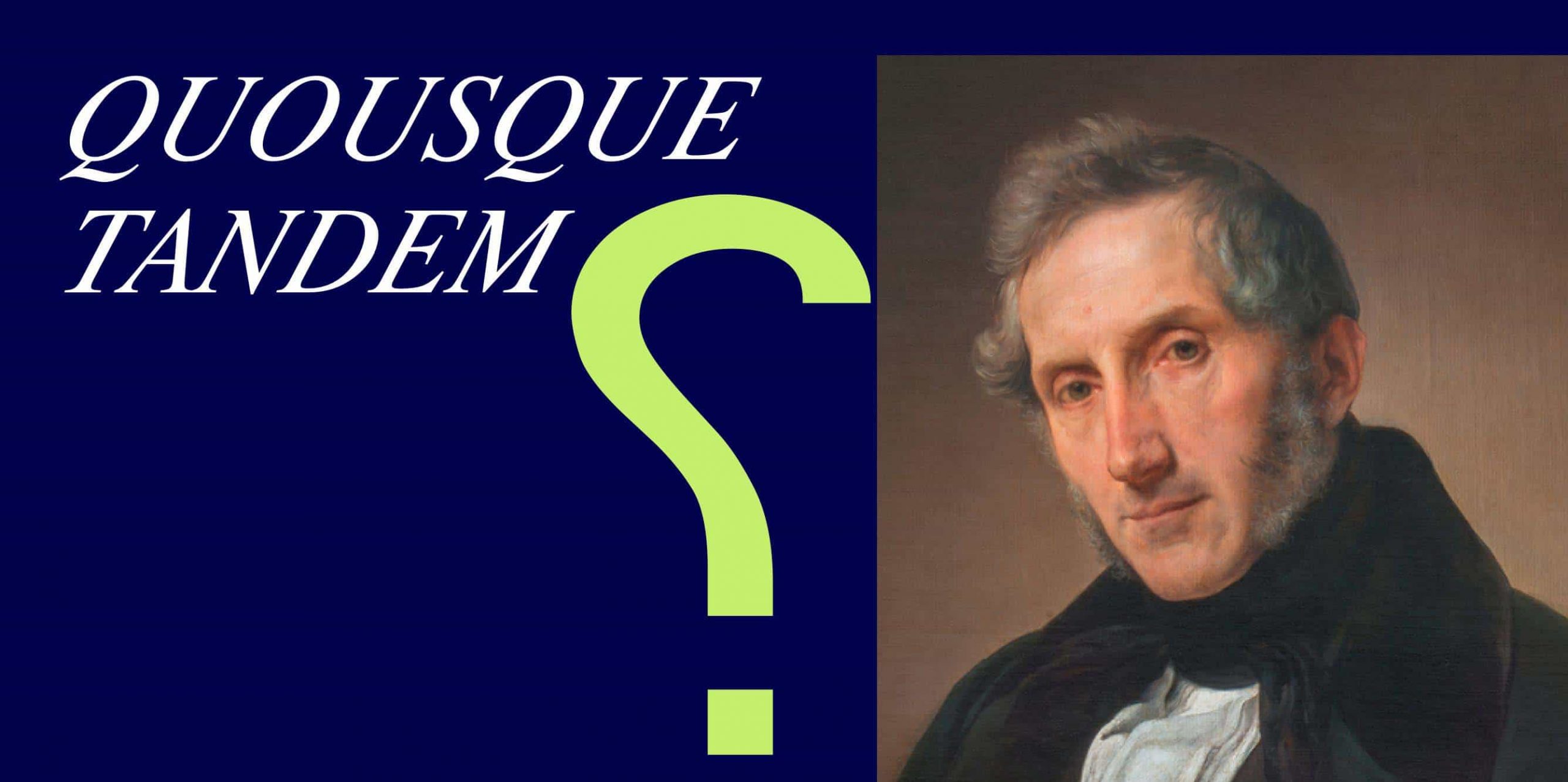
Il 5 maggio scorso, con l’entusiastica collaborazione dei mezzi di informazione locali e nazionali, è stata pubblicizzata la lettura integrale su Internet (con il titolo “Gli Sposi promessi”) della “Prima Minuta” del romanzo di Alessandro Manzoni, già pubblicata con il medesimo titolo da Giuseppe Lesca nel 1916 ma più conosciuta come “Fermo e Lucia”, titolo adottato nel 1953 da Ghisalberti e Chiari, confermato da Salvatore Silvano Nigro (2003) e, in ultimo, da Barbara Colli, Paola Italia e Giulia Raboni (2006).
A garantire la scientificità dell’iniziativa “Gli Sposi promessi su Internet”, le Professoresse Paola Italia e Giulia Raboni, note filologhe manzoniste, cui si sono affiancati accademici manzonisti di mezza Italia, tra cui lo stesso Nigro.
Le ragioni del mutamento di titolo (da “Fermo e Lucia” a “Gli Sposi promessi”) starebbero nel manoscritto di 116 pagine, acquistato dal Comune di Lecco sul mercato antiquario nel 1989 e conservato oggi presso il Museo Manzoniano della città.
La prima delle tre sezioni di cui è composto il documento (40 pagine) è titolata “Gli Sposi promessi / Storia milanese epilogata nel 1824 / Sopra la prima composizione rifatta con molte variazioni” (d’ora in poi la chiameremo l’Epilogo “Gli Sposi promessi”).
A evitare malintesi anche grotteschi, chiariamo subito che il manoscritto è stato redatto da ignoti, in data ignota (il 1824 che vi si legge sul frontespizio può essere stato apposto in qualunque momento, tra il 1824 e i successivi 130 anni).
Parliamo di “malintesi grotteschi” a ragione veduta: l’ANSA (l’Agenzia giornalistica cui si rifanno praticamente tutte le testate del nostro Paese) ha infatti presentato il testo dell’Epilogo “Gli Sposi promessi” come se fosse stato pensato e scritto da Manzoni (vedi l’articolo del 10 maggio):
(ANSA) – LECCO, 10 MAG — “Correva l’anno 1628, quando due giovani persone d’una terra presso Lecco, di bassa condizione, dovevano all’indomani presentarsi al parroco Don Abbondio per la celebrazione del loro matrimonio”.
Era questo l’incipit della prima stesura, datata 24 aprile 1821, del romanzo di Alessandro Manzoni “I promessi sposi”.
Va da sé che si tratta di un grossolano abbaglio preso dall’ANSA: quello è l’inizio del manoscritto redatto da ignoti in data ignota.
Come ben noto, la “Prima Minuta” di Manzoni comincia invece in tutt’altro modo: «Quel ramo del lago di Como d’onde esce l’Adda e che giace fra due catene non interrotte di monti, ecc.»
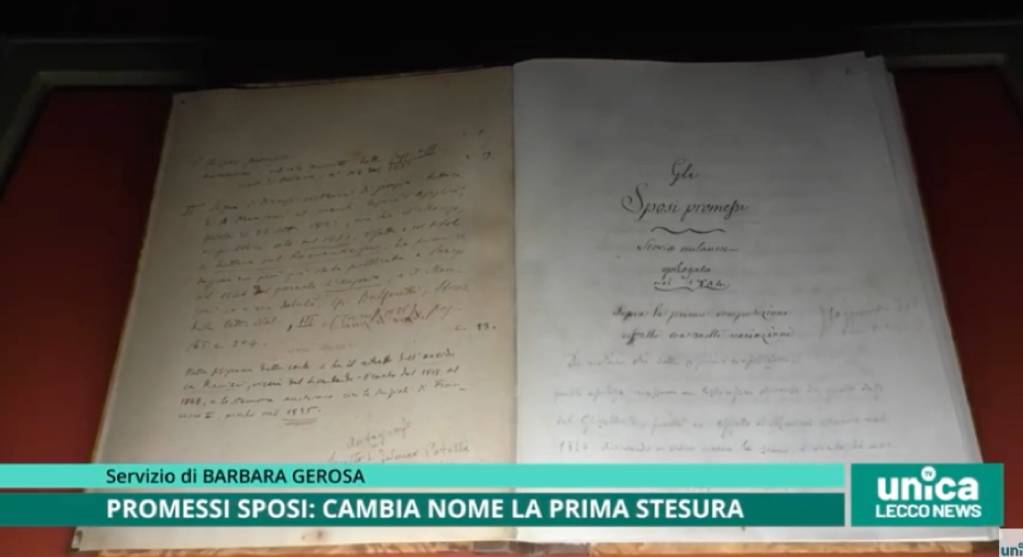

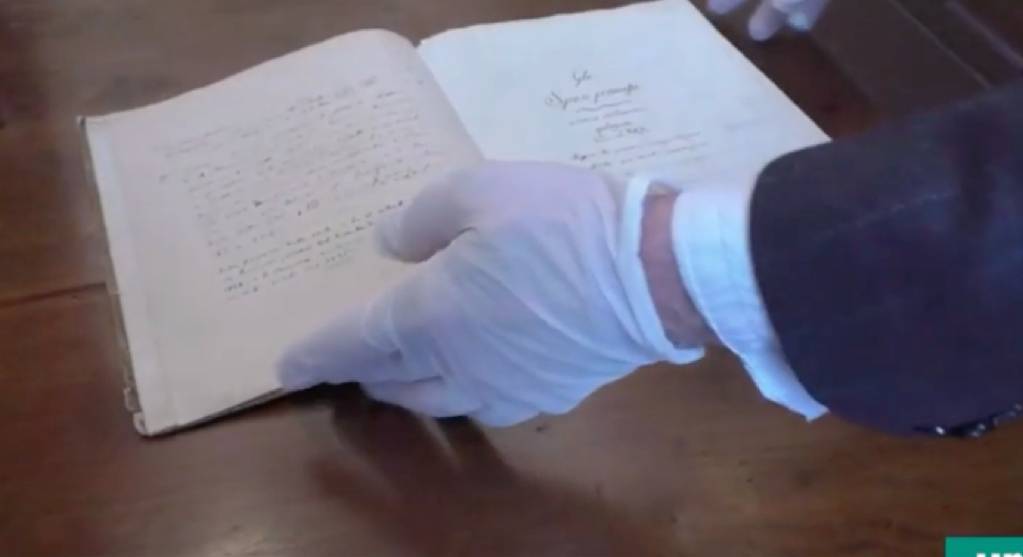
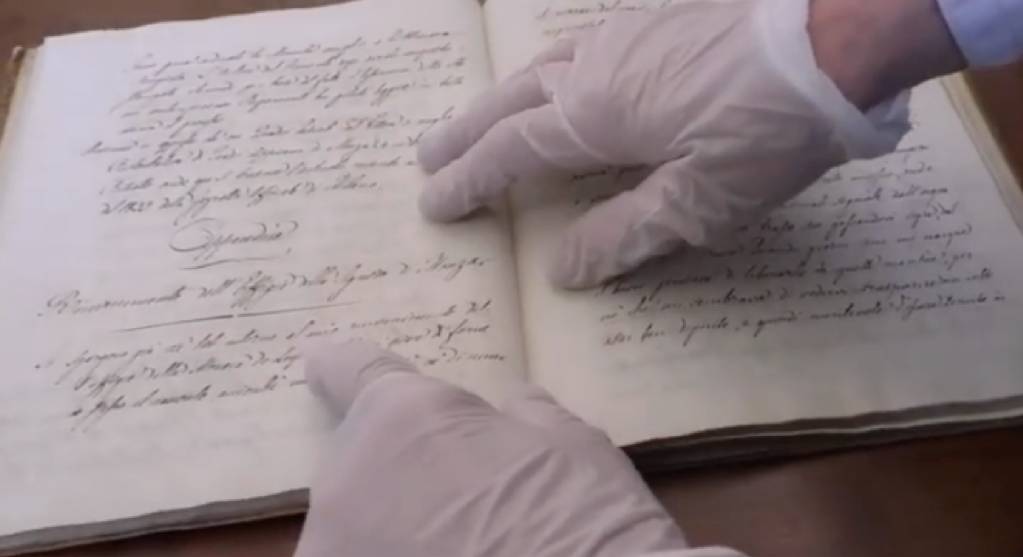
Qui sopra alcune delle pochissime immagini date al pubblico del manoscritto conservato al Museo Manzoniano di Lecco.
Ma torniamo a noi.
È la manina di Manzoni?
Nella terza sezione del manoscritto (ripetiamo, di mano ignota e occupata dalla copia di una copia della convenzionalmente denominata “Lettera sul Romanticismo”, scritta da Manzoni a d’Azeglio padre nel 1823) vi è una frasetta anodina di sei parole
« di trovare, che quelle opinioni vi — »
che, sulla base della loro dimestichezza con la grafia dello scrittore, Paola Italia e Giulia Raboni affermano vergata da Don Lisander.
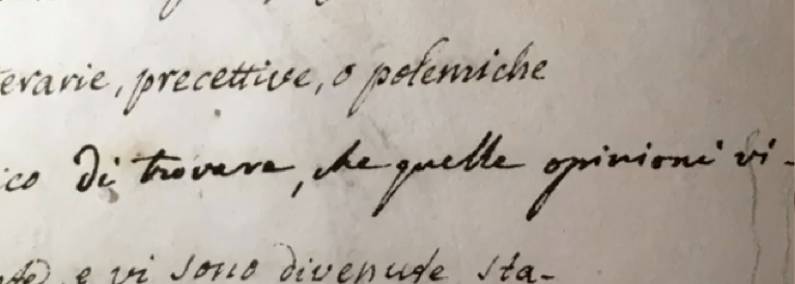
Il quale Manzoni, quindi (secondo le Professoresse), avrebbe avuto ben presente anche l’Epilogo “Gli Sposi promessi”, posto poche pagine prima di quella su cui egli avrebbe vergato quelle sei parole.
Il quale “Epilogo” sarebbe stato ideato (a dire delle Accademiche) da figura appartenente alla cerchia dei suoi più stretti amici, collaboratori, parenti.
Manzoni lo avrebbe anzi sentitamente apprezzato — e anche ispirato — come memoria della “Prima Minuta” del suo romanzo, da conservare per i posteri.
E infatti l’Epilogo (sono sempre le Professoresse ad argomentare) è una riduzione, anzi un Compendio, fedele della “Prima Minuta” di Manzoni come era prima che Manzoni ci mettesse le mani per farlo diventare il testo che poi pubblicò con il titolo “I Promessi Sposi” nel 1827.
Nell‘Epilogo ci sono solo alcune discrepanze onomastiche, dovute anche ad abitudini scrittorie del copista, sicuramente di cultura lombarda; da qui gli scempiamenti “Abondio”, “paroco”, ecc.
È quello il titolo originario del romanzo?
Di più: “Gli Sposi promessi” (è sempre il pensiero delle Prof.) sarebbe stato il primo vero e originario titolo dato da Manzoni al proprio romanzo fin dall’inizio del suo lavoro (aprile 1821), mutato poi in “I Promessi Sposi” solo nell’estate del 1825.
Da tutto ciò (continuano le Professoresse) dobbiamo trarre che a quella “Prima Minuta” Manzoni era molto più legato di quanto si sia fino a ora pensato.
È la “Prima Minuta” il vero romanzo?
E in effetti (è sempre il loro pensiero) quella “Prima Minuta” è molto “più romanzesca”, “più avventurosa”, “più europea” de “I Promessi Sposi” del 1827 o del 1840.
Quella “Prima Minuta” (sono sempre Italia/Raboni ad argomentare, in questo in piena sintonia con il Prof. Nigro) è un romanzo a sé: un “noir” splendidamente gotico (con tutta quella vicenda terribilmente realistica della Signora monaca) che i lettori di oggi — in particolare i più giovani — trovano certo più affascinante di quello che gli studenti dell’Italia post-risorgimentale sono costretti da ben oltre un secolo a leggere di malavoglia a scuola; un testo francamente un po’ troppo baciapile e finanche palloso con tutti quei riferimenti alla Provvidenza, ecc. ecc.
Ci sono serie basi scientifiche?
La solidità di questo argomentare delle Professoresse non è stato da loro affidato solo ai diversi momenti pubblici in cui hanno avuto modo di presentare l’iniziativa (Conversazione on-line Italia / Raboni / Nigro presso la Braidense di Milano del 5 maggio 2021; intervista di Paola Italia a “La Provincia di Lecco” del 6 maggio; intervista della stessa a Lecco FM nella stessa giornata).
Il loro pensiero è stato espresso in termini prettamente accademici in due studi curati da Paola Italia e pubblicati (2018 / 2019) dal prestigioso Centro Nazionale Studi Manzoniani, punto di riferimento per l’Italia e il Mondo per chiunque voglia avere un quadro scientificamente fondato della vita e dell’opera di Don Lisander.
I due studi della Professoressa Italia (“Gli Sposi promessi — Storia milanese epilogata nel 1824” / “Un nuovo testimone della Lettera sul Romanticismo”) condensano in oltre 60 pagine sia la “diplomatica” dell’intero «Manoscritto Lecco 170» (ossia la sua più scrupolosa e attendibile trascrizione, a servire chi non può consultare direttamente il documento) sia una serie di riflessioni critiche della Professoressa Italia, Ordinaria di Filologia alla Università di Bologna.
Bene! Quindi, tutto a posto e sotto controllo?
Mica tanto!
Sapendo esattamente il significato delle parole, non possiamo che anticipare:
CHE RIDICOLO PASTICCIO!
Infatti, quando il 5 maggio abbiamo letto (sulla stampa locale lariana e su quella nazionale) le diecine di articoli entusiastici di elogio per l’iniziativa “Gli Sposi promessi su Internet” e per la “scoperta” della professoressa Paola Italia (la frase detta autografa di Manzoni), con tanto di titoli su una “rivoluzione nella storia della letteratura italiana”, ci siamo detti: caspiterina! Bisogna che cerchiamo di aggiornarci a queste strabilianti novità!
Tanto più che avevamo perfettamente presente quel «Manoscritto Lecco 170», avendolo visto esposto al Museo Manzoniano di Lecco ma senza che nessuno — almeno fino al dicembre 2016 — vi avesse annesso una qualche importanza.
E quindi abbiamo deciso di occuparci del tema cercando di farci una nostra idea sulla ipotesi critica proposta dalle Professoresse Italia e Raboni.
Naturalmente cominciando con l’analizzare i due studi dedicati dalla Professoressa Paola Italia al documento.
Nel giro di un paio di mesi, consultate anche le riprese fotografiche del «Manoscritto Lecco 170» presso i computer del Museo Manzoniano di Lecco (grazie, Direttore Rossetto, per la cortese accoglienza), ci siamo fatti l’idea che tutto quel movimento di idee, di ipotesi; tutta quella “rivoluzione”, nata il 5 maggio 2021 all’insegna de “Gli Sposi promessi su Internet”, aveva basi fragiline e che era opportuno fare qualche segnalazione ai macchinisti.
Infatti, per quanto riguarda l’apparato scientifico, approntato da Paola Italia e sodali a sostegno della loro iniziativa:
Abbiamo rilevato ben 203 errori nella trascrizione “diplomatica” del manoscritto.
Sulla base di una perizia grafologica forense da noi commissionata, siamo giunti alla conclusione che quella frasetta di sei parole NON È AUTOGRAFA di Manzoni.
Abbiamo registrato un grottesco silenzio su una più che probabile manipolazione della stessa struttura del «Manoscritto Lecco 170».
Su questa base, riteniamo che il lavoro critico fin qui proposto VALGA praticamente NULLA e che l’indagine sulla natura del «Manoscritto Lecco 170» debba essere rivista ex-novo, con ben altri criteri.
Per quanto riguarda la natura del «Manoscritto Lecco 170», non avendo potuto analizzarne l’originale, non siamo in grado di avanzare ipotesi fondate, né sulla sua paternità né sulla sua datazione.
Sulla base di una analisi esclusivamente testuale:
Abbiamo constatato che in ben 23 situazioni narrative l’Epilogo “Gli Sposi promessi”, contenuto nel «Manoscritto Lecco 170», è strutturalmente difforme dalla “Prima Minuta” di A. Manzoni e su molti temi in netta contrapposizione con il suo mondo etico.
Per il momento ne ricaviamo che Manzoni mai avrebbe potuto apprezzare né tantomeno sponsorizzare o favorire un documento che (epilogo, riassunto, sintesi, compendio che sia) falsasse la sua prima composizione su tanti punti tanto rilevanti non solo per l’impianto narrativo ma soprattutto per i contenuti etico-spirituali.
L’ipotesi contraria di Paola Italia è francamente solo fantastica (stiamo sul leggero quanto a verbalizzazione del nostro pensiero).
In generale ci sembra che il documento custodito a Lecco sia solo una trovatina pseudo-documentale di nessun valore, realizzata a uso e consumo di collezionisti di “memorie manzoniane” — ma di bocca buona.
Nonostante ciò, precisiamo che, sulla base della documentazione a oggi disponibile, nulla può autorizzarci a definire eventualmente un “falso” il documento conservato al Museo Manzoniano di Lecco.
In esso non vi è infatti neppure una parola, o un segno, tesi a indicarvi un qualche coinvolgimento diretto di Manzoni o una sua qualsivoglia attenzione.
È invece grazie alla attribuzione alla mano di Manzoni di quella frasetta — garantita senza riserve da ben note accademiche, e sulla scorta anche di richiamate sofisticate analisi strumentali — che si è aperta per quell’anonimo documento una nuova stagione di valorizzazione anche pecuniaria.
Le Prof. non se ne rendono sicuramente conto ma è grazie alla loro autorevole certificazione che ora quel documento potrebbe essere considerato un vero e proprio falso: suggeriamo maggiore prudenza!
Agli argomenti appena accennati dedichiamo due distinti interventi.
In questa Prima Nota — quella che il lettore trova esposta qui di seguito — mettiamo in luce:
a / La inconsistenza scientifica della “trascrizione diplomatica” dell’Epilogo “Gli Sposi promessi”, prima sezione (40 pagine) del “Manoscritto Lecco 170”, proposta dalla Professoressa Paola Italia e viziata da inscusabili cecità e dilettantesca superficialità.
b / La vacuità dell’attribuzione “a occhio” della supposta autografia manzoniana delle sei parole alla carta 47r.
c / La nullità della dichiarata coerenza di trama tra l’Epilogo “Gli Sposi Promessi” e “Prima Minuta” di Manzoni.
Chiediamo quindi che da parte delle Autorità culturali della città di Lecco, in primo luogo del suo Assessorato alla Cultura e del Museo Manzoniano di Lecco si avvii una indagine ex novo del «Manoscritto Lecco 170» che coinvolga sia il mondo accademico sia i centri autonomi di ricerca legati al mondo manzoniano (tra questi naturalmente il nostro Centro Studi Abate Stoppani), mettendo prima di tutto a disposizione del pubblico almeno una rappresentazione ad alta definizione dell’insieme del «Manoscritto Lecco 170».
Nella Seconda Nota (che pubblicheremo quanto prima) discuteremo sulle differenze sostanziali — quindi di carattere etico, prima ancora che artistico e linguistico — che distinguono la “Prima Minuta” (mai resa nota da Manzoni) dal romanzo “I Promessi Sposi”, da Don Lisander pubblicato nel 1827 e poi nel 1840.
1. La cronaca più recente: maggio-ottobre 2021.
Ci pare che il modo migliore per avviare questa nostra Nota sia collegarci alla cronaca lecchese, nel cuore di quello che Manzoni scrisse essere “il più bel paese del mondo”.
1.1/ Le affermazioni inequivocabili di Paola Italia.
Nel quadro del Festival “Lecco, città dei Promessi Sposi, 2021”, sabato 16 ottobre si è svolto a Villa Manzoni l’incontro (prendiamo dal programma ufficiale):
«TEA TIME IN VILLA / Salotto letterario / Vero o falso? Come determiniamo l’autenticità di un manoscritto / Il compendio manzoniano di Lecco svelato al pubblico / Incontro con Paola Italia / (Università degli studi di Bologna)».
L’incontro, coordinato da Mauro Rossetto (Direttore del Museo Manzoniano di Lecco) oltre che della programmata presenza di Paola Italia, ha goduto in via straordinaria della partecipazione di Gianluigi Daccò, ex Direttore del medesimo Museo.
L’incontro è stato a suo modo memorabile, anche perché vario nei toni.
Sul fronte accademico, la Professoressa Paola Italia, circa l’annunciato argomento “Come determiniamo l’autenticità di un manoscritto / Il compendio manzoniano di Lecco svelato al pubblico” non ha detto purtroppo nulla di nuovo.
Sulla da lei affermata autografia manzoniana, si è infatti limitata a riproporre le argomentazioni generiche già esposte in altre presentazioni a voce e in documenti da lei pubblicati; ha inoltre parlato di un progetto universitario (in fase di definizione) relativo alla individuazione dei falsi letterari.
Tutto interessante certo! ma frustrante per quei presenti che, come noi, pensavano che, a dimostrare non essere il «Manoscritto Lecco 170» una volgare patacca, la Prof. ci avrebbe fatto dono dei risultati delle analisi strumentali relative al manoscritto stesso cui ella aveva fatto riferimento nella intervista rilasciata il 6 maggio 2021 alla emittente lariana Lecco FM.

In quella occasione (minutaggio 6:44) Paola Italia era stata estremamente esplicita (evidenziazioni nostre):
«Successivamente, proprio perché ho voluto studiare con più attenzione questo manoscritto, recandomi due anni fa al Museo Manzoniano [luglio 2019, ndr], e studiandolo anche con l’ausilio di tecniche di riproduzione digitale, imaging, di spettrografia, si è potuto capire che la riga era stata integrata proprio da Manzoni.»

Come può comprendere chiunque, in quella intervista Paola Italia aveva per così dire svelato il segreto: a lei era venuta una intuizione legata alla sua sensibilità ma è dall’alta tecnologia che le era venuta la certezza: sì! quella frase è della mano di Manzoni; lo hanno confermato le tecniche di riproduzione digitale, di imaging, la spettrografia cui il manoscritto conservato al Museo di Lecco è stato da lei sottoposto.
Queste affermazioni di Paola Italia alla emittente lariana il 6 maggio 2021 ci avevano veramente colpito.
Anche perché quanto da lei lì detto differiva di molto rispetto al come, solo il giorno prima, essa stessa, in due distinte comunicazioni, aveva ricordato la sua “scoperta”.
1.2/ Dal tempio della documentazione manzoniana.
La Professoressa Paola Italia, parlando alla Braidense di Milano il 5 maggio 2021, in pubblica conversazione attraverso Internet con Giulia Raboni e Silvano Nigro, a proposito del «Manoscritto Lecco 170», così infatti si era espressa:
«Dove si trova? Si trova a Lecco, alla Villa il Caleotto […].
Ecco, questo manoscritto era stato acquistato alla fine degli anni ’80 ma non era stato studiato e sembrava poco interessante.
L’ho studiato io alcuni anni fa e ho scoperto che la prima parte aveva un riassunto, quindi “storia milanese epilogata”.
[…]
Infatti noi troviamo nel manoscritto di Lecco che questa mezza riga vuota è stata completata da una grafia per noi inconfondibile perché è la grafia di Manzoni.
Questo ha dato ovviamente al manoscritto non solo una grande importanza ma ha gettato una nuova luce sull’idea che Manzoni aveva della sua prima minuta.»
Quindi … il 5 maggio, presentando su Internet in anteprima assoluta la propria “scoperta” (e discutendone la genesi con due campioni della filologia manzonista italiana, i Professori Raboni e Nigro), Paola Italia — forse per non annoiare i colleghi — non aveva ritenuto opportuno parlare di “tecniche di riproduzione digitale, imaging, di spettrografia” e altre pallosità, preferendo enfatizzare il momento della sua lunga esperienza e familiarità con l’opera di Manzoni.
1.3/ Romanzo lariano.
Sulla medesima linea narrativa la Professoressa si era mantenuta in una intervista rilasciata a “La provincia di Lecco”, apparsa lo stesso 5 maggio:
«Una felice intuizione della docente Paola Italia — «Ma quella è la scrittura di Manzoni», mi sono detta. […]
Paola Italia ricorda bene l’estate del 2019, quando costretta a ritornare a Lecco per una pagina mancante tra le copie digitali del manoscritto, ha scoperto qualcosa che non si attendeva di trovare. Avevo lavorato per sei anni sulle riscritture di Manzoni, ci passavo intere giornate e la sua grafia la conosco meglio della mia. Per noi filologi è come ritrovare un volto noto.»

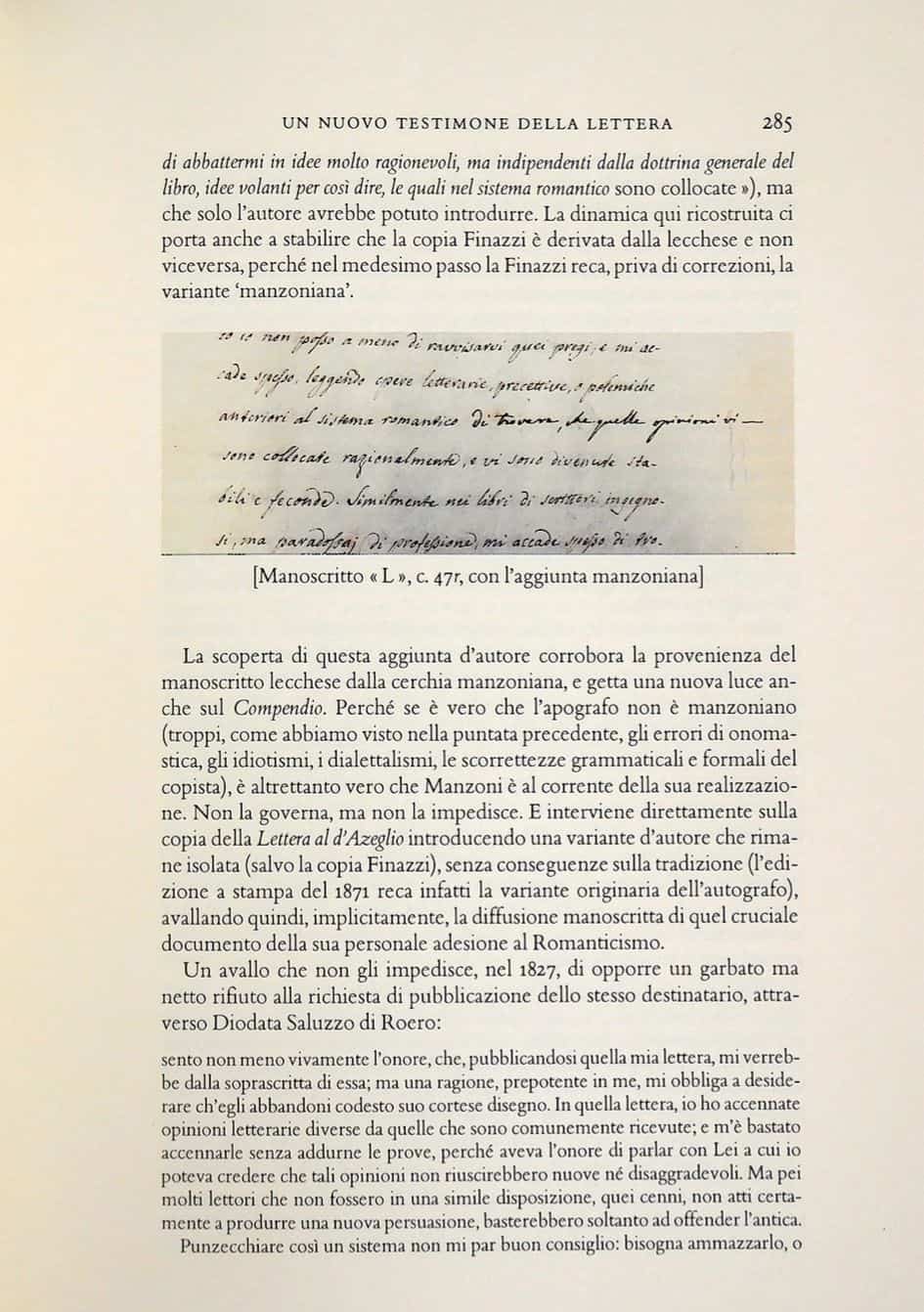
Anche in questo caso, quindi, Paola Italia aveva preferito ignorare i grigi laboratori e le fredde macchine ricordando invece l’emozione di trovare, proprio lì a Lecco, nella casa di Manzoni, una pagina del manoscritto che le mancava e — proprio in quella pagina — di avere immediatamente riconosciuto la grafia del grande romanziere; quasi come se Don Lisander la stesse a guardare da qualche parte dei cieli e la avesse guidata paternamente alla scoperta di una sua ancora inedita traccia terrena.
Una narrazione certo toccante (anche se inquietante per tanti aspetti — la Prof. si è infatti accorta che alle sue copie del manoscritto mancava una pagina dopo ben 27 mesi di studio) ma decisamente lontana da quel richiamo perentorio alle tecnologie d’avanguardia ricordate a Lecco FM il 6 maggio, il giorno successivo a questa intervista rilasciata a “La provincia di Lecco”.
D’altra parte, anche il lettore più attento, nello studio pubblicato da Paola Italia nel novembre 2019 (“Un nuovo testimone della Lettera sul Romanticismo” — quello con il quale è stata ufficializzata la “scoperta” dell’autografia manzoniana) non riesce a trovare neppure una mezza parola su nessunissima tecnologia né di “riproduzione digitale” né di “imaging”, né di “spettrografia”.
Il problema è che noi, sapendo che, proprio nell’autunno del 2019 (mentre studiava il manoscritto contenente “Gli Sposi promessi” e la “Lettera sul romanticismo”), Paola Italia era impegnata anche nello studio del manoscritto de “L’infinito” di Leopardi (e questo proprio con quelle mirabolanti tecnologie di ultima generazione — le Università di Roma, Bologna e Napoli ne hanno promosso interessanti convegni/ seminari con la partecipazione anche della nostra Professoressa), eravamo convinti che il 16 ottobre a Lecco, Paola Italia ci svelasse i risultati delle analisi di cui ci aveva parlato il 6 maggio 2021.
E invece no! Pensate che delusione!
Ci siamo quindi dovuti convincere — certo a malincuore — che i casi erano due:
— o nell’intervista del 6 maggio Paola Italia aveva lavorato di fantasia, trasferendo sul manoscritto “Gli Sposi promessi” relativo a Manzoni, quanto da lei effettivamente fatto — ma su Leopardi! (e quindi la Prof. risulterebbe per questa vicenda purtroppo del tutto inaffidabile, cosa che ci sembra francamente neppure pensabile); oppure …
— oppure il «Manoscritto Lecco 170» è stato effettivamente analizzato con le nuove tecnologie e ne sono usciti elementi di un certo interesse — ma per una qualche ragione i risultati vengono tenuti nel cassetto.
In entrambi i casi, ne verrebbe una situazione veramente spiacevole (e per la scienza e per la pubblica fede) ma comunque facilissimamente sanabile: è sufficiente che la Professoressa Paola Italia — o i suoi sodali in questa operazione (in primis ovviamente i responsabili museali di Lecco e l’Assessora alla Cultura della città) — rendano pubblici (suggeriamo sul sito istituzionale del Comune di Lecco) i risultati delle analisi che la Prof. afferma di avere svolto sul «Manoscritto Lecco 170» «con l’ausilio di tecniche di riproduzione digitale, imaging, di spettrografia.»
Dal momento che le analisi con apparecchiature sofisticate non vengono condotte di nascosto nei sottoscala ma sono il momento chiave di una articolata trafila, costituita prima di tutto dalle decisioni delle competenti autorità lecchesi, discusse e prese ufficialmente; poi dai permessi accordati dalla Soprintendenza; poi dai quesiti formulati dalla Professoressa Italia ai responsabili delle indagini; poi da una bella relazione tecnico-scientifica formulata dall’organismo competente — il tutto accompagnato da una non piccola raccolta di documenti formali, protocolli, ecc. ecc. …
… dato tutto ciò, se le analisi sono state eseguite, la documentazione di certo non manca e perché non possa sorgere il più piccolo dubbio sulla veridicità di quanto viene proposto al pubblico (che è il vero proprietario del «Manoscritto Lecco 170») basta mostrarla.
Per il momento, in fiduciosa attesa, noi rimaniamo a ciò che è oggi pubblicamente noto.
Ossia che su quel documento, presentato il 5 maggio 2021 come architrave di una “rivoluzione” nella critica manzoniana, non si è ancora mosso un dito per analizzarne penne, grafie, cancellature, carta, inchiostri, metodi di confezione e legatoria — il preliminare abc in caso di documenti di dubbia provenienza.
E che, per assegnare a Manzoni la autografia di quella frasetta di sei anodine parolette, ci si è basati non sulla spettrografia ma sull’occhio delle professoresse (vedremo più sotto, non particolarmente acuto).

Tornando alla conferenza di Lecco del 16 ottobre 2021, sul fronte dell’intrattenimento ludico, ha invece provveduto l’ex Direttore del Museo Manzoniano, il Dottor Gianluigi Daccò che nel 1989 aveva proposto l’acquisto del manoscritto in questione da parte del Comune di Lecco.
Presentato da Rossetto come suo indimenticabile Maestro, a inizio conferenza l’ex Direttore, smentendo il suo allievo e sbugiardando cavallerescamente la Professoressa seduta proprio di fronte a lui, ha rivendicato a sé l’avere per primo attribuito a Manzoni l’autografia di quella famosa frasetta; e questo già nel lontano 1988 (Ndr: quando Paola Italia era ancora lontana anche dalla laurea).
Dalla trascrizione fedele dell’intervento da noi registrato il 16/10/21:
«Una grossa libreria [di Milano, ndr] che anni prima ci aveva fornito il manoscritto della autobiografia di Bovara (di cui avevo riconosciuto immediatamente la grafia perché stavo lavorando su sue carte in quel periodo), nel 1988 — stiamo parlando di 33 anni fa — mi aveva fatto presente di avere a disposizione il manoscritto di tema manzoniano di cui parliamo oggi.
C’erano note di due famosi collezionisti e studiosi manzoniani, cioè Bulferetti e Patetta; quindi era già abbastanza evidente che ci trovavamo di fronte a qualcosa di significativo.
.
Ma c’era poi evidentissima una correzione, apportata nella seconda parte del manoscritto direttamente da Manzoni: anche la grafia di Manzoni è abbastanza inconfondibile.
.
Consultato il Centro Nazionale Studi Manzoniani, con cui collaboravamo, mi è sembrato molto interessante proporre l’acquisto di questo manoscritto, di cui però non avevo assolutamente capito l’importanza.
Semplicemente a noi andava bene da un punto di vista didattico-espositivo perché provava una cosa: provava che nel 1824, in alcuni ambiti milanesi, del romanzo di Manzoni circolavano forme riassuntive della prima redazione, quella del Fermo e Lucia (i personaggi vi comparivano con i medesimi nomi).
.L’acquisizione è avvenuta quindi in questo modo.
L’importanza del manoscritto è emersa invece dagli studi della Professoressa Paola Italia e la cosa mi ha reso particolarmente felice: mi aspettavo che fosse una cosa importante ma certamente non di questo livello.»
La dichiarazione di Daccò è stata accolta con il dovuto rispetto all’ex ruolo e all’età — ma anche con stupore e meraviglia.
Con le sue parole il Dottor Daccò ha infatti detto chiaro e tondo che la comunità scientifica, il pubblico tutto e gli organi di informazione sono stati vittime di quella che, stando alle sue parole, dobbiamo ritenere una vera e propria burla ideologica (chiamiamola così!) condotta, attraverso molteplici quadri comunicativi, dalle Professoresse Italia e Raboni, cui avrebbero tenuto il sacco parecchie Istituzioni e funzionari pubblici, tra cui il Dottor Rossetto e l’Assessora alla Cultura Piazza.
E si sa che il Dottor Daccò — come il Bruto di Shakespeare — è un uomo d’onore e, quindi, di quanto egli dice ci si può veramente fidare.
Del resto, a questa mirabile rivelazione dell’ex-Direttore, i suoi due co-relatori, la Professoressa Paola Italia e il Dottor Rossetto, da lui implicitamente indicati come colpevolmente dimentichi di un per lui ben noto dato storico, non hanno mosso un pelo, dando così tacitamente avallo a questo chiarimento (Rossetto si fissava la punta delle scarpe; la Professoressa Italia aveva quel sorriso a mezz’asta che le donne sensibili sfoderano quando si sentono imbarazzate per le sciocchezze che sono eventualmente costrette a sentire).
D’altra parte, se il Dottor Daccò/ uomo d’onore avesse in questa occasione straparlato, i due studiosi lo avrebbero certo autorevolmente smentito — va là Gianluigi, cascia no di bal!
Non lo hanno fatto, forse per soggezione (per Rossetto, Daccò è un super Maestro; per Paola Italia, in quanto museologo naturalizzato lecchese, una categoria protetta a livello nazionale).
Forse diranno qualcosa in altro momento. Non sappiamo. Vedremo.
1.4/ Per la verità ci sarebbe una qualche cosina da considerare …
Dopo essere stato acquistato nel 1989, il manoscritto di cui parliamo è infatti rimasto nei cassetti del Museo per almeno due decenni e ci sembra che nessuno — tanto meno il suo Direttore di allora, Gianluigi Daccò — ne abbia mai parlato in alcuna occasione (accettiamo volentieri eventuali smentite — documentate grazie!).
È certo che nell’opuscolo a stampa di presentazione del Museo, edito nel 2008 proprio con la firma del medesimo Gianluigi Daccò, non se ne fa alcuna menzione.
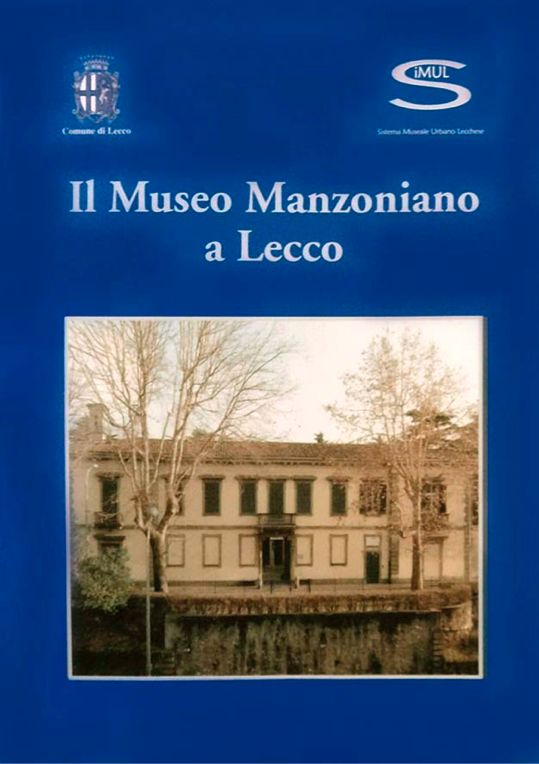
Ma, a un certo punto, il manoscritto di cui ci occupiamo è stato esposto al pubblico in una abbastanza squallida stanzetta del Museo, insieme a pubblicazioni a stampa del romanzo di Manzoni.
Quando?
Ce lo potrà dire — se lo vorrà — l’uomo d’onore stesso o il suo riconoscentissimo allievo Rossetto ma, in attesa, noi ipotizziamo dopo il 2012.
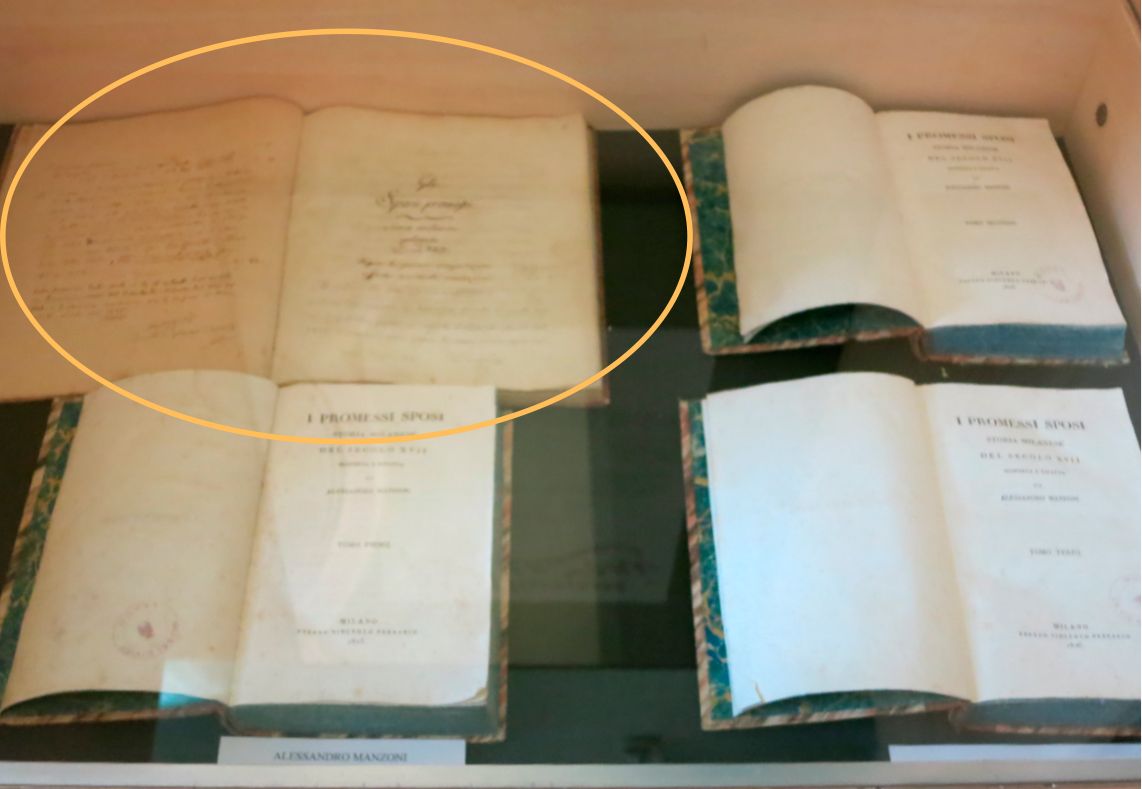
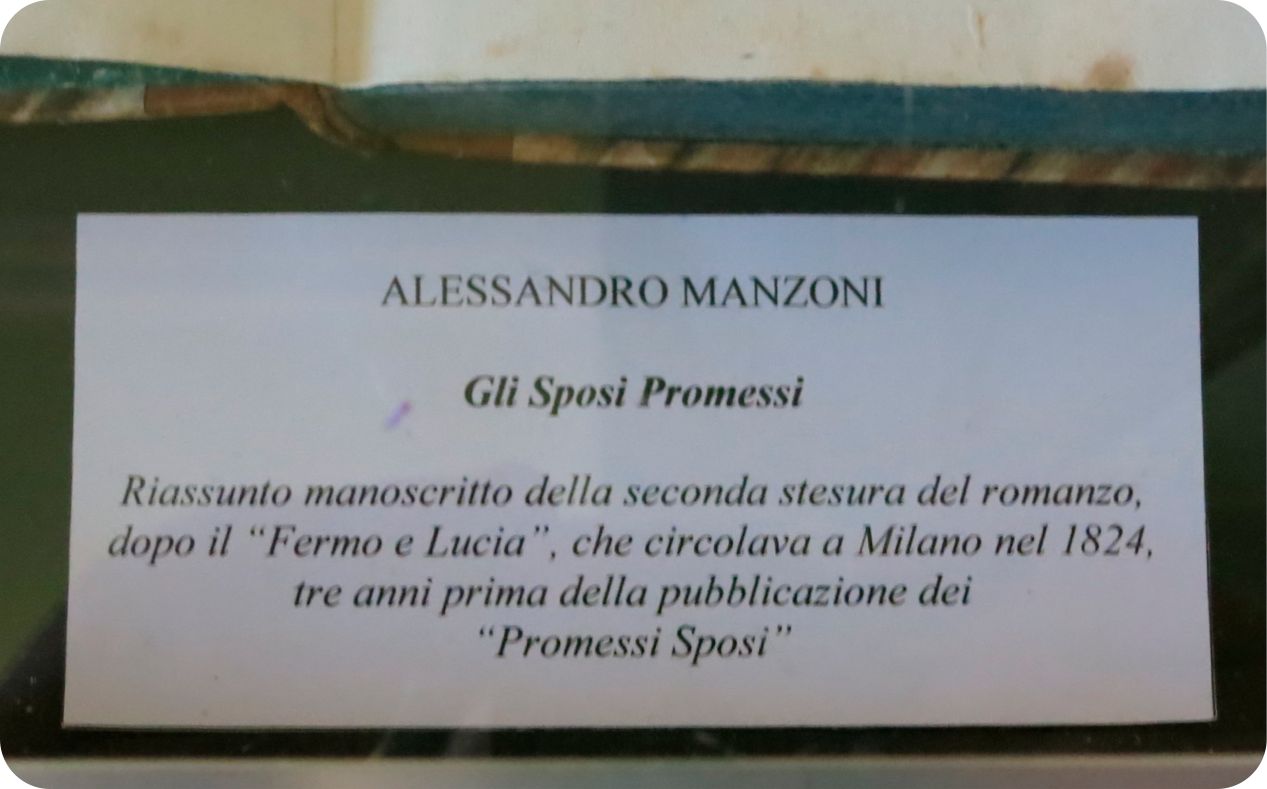
“Gli Sposi promessi”
Giuseppe Lesca
Edizioni Perrella
Napoli, 1916.
Nel corso della conferenza di Lecco del 16 ottobre 2021 la Professoressa Italia ha ripetuto un errore di datazione in cui era incorsa già nel 2018, nel suo studio dedicato al manoscritto in questione “Storia milanese epilogata nel 1824”, p. 144:
«Se si aggiunge poi che la versione integrale del Fermo e Lucia (con titolo Gli sposi promessi) viene resa nota solo a partire dall’edizione Lesca del 1921».
Evidentemente nessuno dei suoi colleghi le ha fatto presente questo svarione.
Giuseppe Lesca pubblicò la prima edizione critica della “prima minuta” nel 1916, avendone datato la Presentazione al 1915.
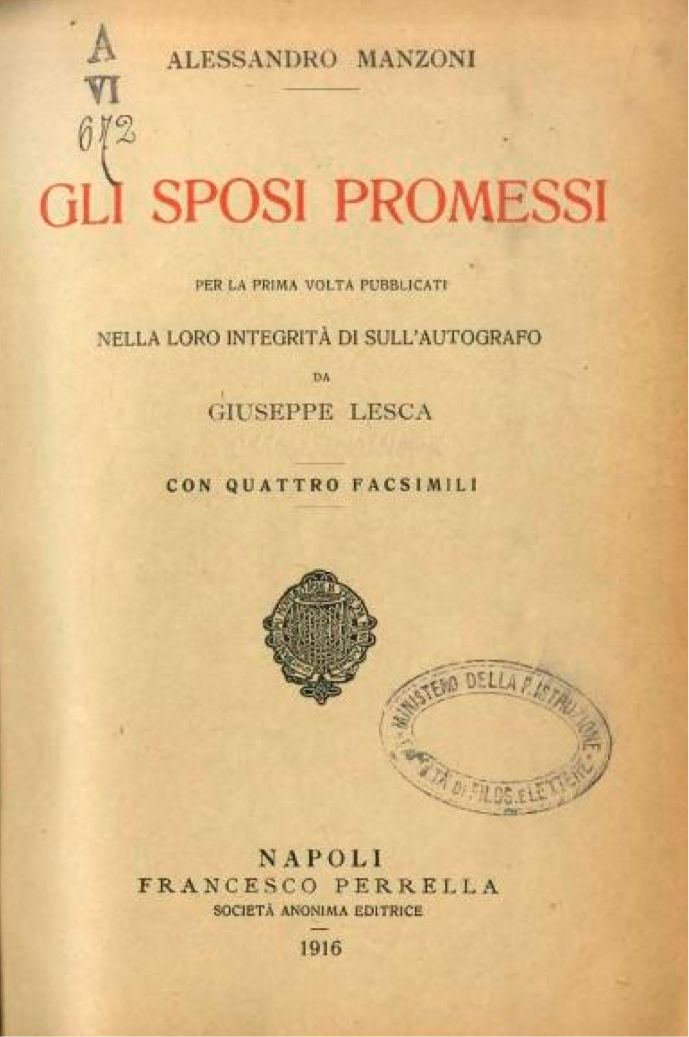
In quell’anno venne infatti pubblicato, a cura di Barbara Colli e Giulia Raboni, l’edizione critica «Gli Sposi Promessi — Seconda minuta (1823-1827)» in cui viene presentato il nuovo testo di Manzoni prima che egli giungesse alla definitiva versione, pubblicata nel 1827 con il titolo “I Promessi Sposi”.
Non è improbabile che, in quel 2012, l’ex Direttore si sia sentito stimolato da quel titolo “Gli Sposi promessi”, usato per la “prima minuta” da Lesca nel 1916 (1916, Professoressa Italia) e riesumato dopo quasi un secolo da Colli e Raboni ma per ciò che esse hanno chiamato “seconda minuta”.
Comunque sia, il volumetto era esposto, senza alcuna evidenziazione, al Museo Manzoniano di Lecco il 1 dicembre del 2016, quando vennero da noi scattate le foto poste appena qui sopra.
A parte la posizione decisamente infelice data al manoscritto nella bacheca (risultava quasi impossibile leggere alcunché delle due pagine in vista), può essere istruttivo (pensando anche agli uomini d’onore) considerare l’etichetta con cui il manoscritto stesso veniva presentato:
«Alessandro Manzoni / Gli Sposi Promessi / Riassunto manoscritto della seconda stesura del romanzo, dopo il “Fermo e Lucia”, che circolava a Milano nel 1824, tre anni prima della pubblicazione dei “Promessi Sposi”».
Curioso vero?
Nel 2016, al Museo Manzoniano di Lecco, il manoscritto veniva presentato — con tanto di etichetta — come un riassunto «della “SECONDA stesura del romanzo, dopo il Fermo e Lucia”».
Cioè proprio il contrario di quanto, da qualche tempo, viene sostenuto da Paola Italia, dal Museo Manzoniano di Lecco e, dal 16 ottobre 2021, dallo stesso Gianluigi Daccò, estensore di quella etichetta, oggi anche da lui contraddetta.
Straordinario!
Evidentemente, allora — ma temiamo anche oggi — né il Direttore del Museo Gianluigi Daccò, né il suo riconoscente allievo Mauro Rossetto avevano confrontato le 40 paginette dell’Epilogo del “Manoscritto Lecco 170” con la Prima e la Seconda e le definitive stesure del romanzo di Manzoni.
Abbiamo l’impressione che a questo punto il lettore sia piuttosto sconfortato: ma allora tutti questi manzonian-manzonisti parlano a vanvera; raccontano balle, si contraddicono l’uno con l’altro e contraddicono se stessi con la facilità con cui respirano!
Ma di chi ci si può fidare? Ma allora, questo manoscritto che cosa è veramente?
Comprendiamo e condividiamo lo sconforto.
Come almeno parziale rimedio, al lettore suggeriamo di continuare a leggere la Nota che segue per avere non l’ennesima rivelazione divina ma quanto meno un quadro esaustivo della cosa, in modo da farsi una propria idea.
Caro Lettore, sta per finire la ricreazione … ma abbiamo ancora un paio di chicche.
1.5/ Su “Prima Minuta” e “Promessi Sposi” marasma manzonista del Comune e del Sistema Museale di Lecco.
Come già anticipato, il 5 maggio 2021, facendo riferimento ai 200 anni dalla stesura delle sue prime righe manoscritte, da Piccolo Teatro di Milano, Intesa Sanpaolo, Comune di Lecco, è stata data notizia che la “Prima Minuta” del romanzo di Alessandro Manzoni sarebbe stata letta per la prima volta su Internet — “integralmente” e “con l’aggiunta della Storia della Colonna Infame” — in 37 puntate (5 maggio-30 giugno 2021) con il nuovissimo titolo “Gli Sposi promessi”, officianti le Professoresse Paola Italia e Giulia Raboni.
Condividevano (e condividono) il progetto delle due Prof. gli “amici e colleghi” del Centro Nazionale Studi Manzoniani (Mario Barenghi, Maria De Las Nueves Muñiz Muñiz, Donatella Martinelli, Silvano Nigro, Mauro Novelli, Angelo Stella).
Sono però ovviamente della partita anche i Professori di varie Università che hanno introdotto la lettura sul Web di ogni singolo capitolo della “Prima Minuta”: Simone Albonico (Univ. de Lausanne) e Silvia De Laude (Univ. di Ginevra); Maurizio Ferraris (Univ. di Torino); Silvia Contarini (Univ. di Udine); Mauro Novelli e Giuseppe Polimeni (Univ. di Milano); Pierantonio Frare (Univ. Cattolica di Milano); Giuseppe Antonelli, Mariarosa Bricchi e Giorgio Panizza (Univ. di Pavia); Margherita Centenari e Carmela Marranchino (Univ. di Parma); Francesco Sberlati (Univ. di Bologna); Daniela Brogi (Univ. di Siena).
All’iniziativa hanno dato il loro entusiastico Patrocinio il Comune e il Museo Manzoniano di Lecco.
In questo quadro, con cui si può essere più o meno d’accordo (noi non lo siamo per nulla) ma che almeno è abbastanza chiaro, si colloca lo sbalorditivo Comunicato del 5 maggio 2021, a firma “Comune di Lecco” e “Sistema Urbano Museale Lecchese“ (qui leggi l’integrale).
Codeste strutture istituzionali lecchesi, che dovrebbero essere i più gelosi custodi della memoria di Manzoni, a proposito della lettura su Internet della “Prima Minuta” di Manzoni hanno così scritto (evidenziazioni nostre):
«Il 24 aprile 1821 Alessandro Manzoni dava inizio alla prima stesura di quello che sarebbe diventato il suo capolavoro: “I promessi sposi”.
200 anni dopo, in questa ricorrenza, il Piccolo Teatro di Milano inaugura un ciclo di incontri online che comprenderà la lettura integrale, suddivisa in diversi podcast, del testo del romanzo nell’edizione del 1827.»
Il 7 maggio questo geniale brano è stato riproposto pari pari anche nel settimanale news del Sindaco Gattinoni.
Formidabile: a partire dal 5 maggio 2021, anche con il Patrocinio del Comune di Lecco, è stata orchestrata una mobilitazione nazionale tutta incentrata sulla lettura integrale su Internet della “Prima Minuta”, notoriamente stesa (e mai resa nota) da Manzoni nel 1821-23 e…
… e il Comune di Lecco confonde questa “Prima Minuta” con “I Promessi Sposi”, pubblicati da Manzoni nel 1827!
Che il Sindaco Gattinoni non voglia perdere tempo su Manzoni non stupisce più di tanto.
Ma che il Direttore del Museo Manzoniano e l’Assessore alla Cultura della “Lecco, città dei Promessi Sposi”, non siano ancora riusciti a cogliere la differenza tra la “Prima Minuta” del romanzo (stesa da Manzoni nel 1821-23) e il suo testo definitivo del 1827 è cosa veramente mirabile.
Si comprende come in questo clima di beata incompetenza, possano continuare a trovare impunemente spazio pubblico le balle dei già ricordati uomini più o meno d’onore e le “scoperte” dell’accademia.
1.6 / L’Assessorato alla Fantasia.
A completamento di questa sezione, stesa anche all’insegna del sorriso, non possiamo non citare il contributo dell’Assessora Piazza, presentato nel già citato comunicato 5-05-2021 con un titolo veramente curioso (evidenziazioni nostre):
«Il commento dell’assessore [sic! ndr] alla Cultura del Comune di Lecco Simone [sic! ndr] Piazza»
.
«Il Museo Manzoniano di Lecco, riallestito nell’ottobre 2019 con un impianto fortemente innovativo, non solo ha collaborato con la Prof.ssa Paola Italia e l’Università di Bologna per consentirne lo studio, ma ne ha evidenziato l’importanza all’interno del nuovo allestimento arricchendo la sala 8 in cui il prezioso reperto è esposto anche di un’installazione multimediale. Questo anche se in quel momento non si erano ancora concluse le ricerche che hanno successivamente portato alla scoperta dell’inedita nota autografa di Alessandro Manzoni.»
L’Assessora, cioè, afferma impavidamente che la da lei detta “installazione multimediale” è stata pensata in funzione e a valorizzazione del «Manoscritto Lecco 170», “scoperto” dalla Professoressa Paola Italia.
Che bello!
Peccato non sia vero nulla: è tutta fantasia!
Il corto proiettato nella “installazione multimediale” (si tratta di un banalissimo proiettore) è infatti «l’opera di videomapping di Igor Imhoff, nella sala 8 dedicata alla Storia della Colonna Infame», così come indicato nel Comunicato del Comune del 15 luglio 2020.
E in effetti, al contrario di quanto vuole dare a intendere l’Assessora Piazza, il filmato di Imhoff non fa nessunissimo riferimento al manoscritto “Gli Sposi promessi” (nel quale, per altro, la vicenda di Mora e Piazza è solo accennata) ma esclusivamente al tema del processo della “Colonna Infame”.
Quousque tandem Simone?
Finita la ricreazione, possiamo ora passare alle cose serie (si fa per dire) illustrando il disastro della “diplomatica” del «Manoscritto Lecco 170», offertoci dalla Professoressa Paola Italia.
2. Una “diplomatica” da dimenticare.
Prima di entrare nel merito, una piccola digressione su Federico Patetta e Domenico Bulferetti, i due studiosi di cui il «Manoscritto Lecco 170», prima di essere acquisito dal Comune di Lecco, fu di proprietà, o comunque da cui fu compulsato e annotato.
Due intellettuali che, diversi quanto a formazione e orientamento esistenziale, ebbero in comune la passione e la competenza nella ricerca storica e archivistica nonché nella analisi filologica dei documenti relativi ai loro campi di azione culturale.
Nei due studi dedicati da Paola Italia al «Manoscritto Lecco 170» si è fatto di queste due figure un accenno solo incidentale. Una notazione troppo rapida soprattutto nei confronti di Bulferetti che, oltre a essere stato importantissimo per la cultura della Varese contemporanea, si è distinto soprattutto come appassionato manzonista / manzoniano.
Ne diciamo quindi qualche cosa noi, pur se solo limitandoci a cenni sulle competenze filologiche dei due studiosi, cominciando da Patetta, primo per vicenda biografica e primo come annotatore del manoscritto di cui ci stiamo occupando.
2.1/ Patetta, raffinato filologo, raccoglitore di manoscritti d’ogni epoca.
Federico Patetta (1867-1945), dal 1892 al 1933 ordinario di storia del diritto italiano nelle università di Macerata, Siena, Modena, Pisa, Torino e Roma nonché socio nazionale dei Lincei (1928) e Accademico d’Italia (1933), fu una delle figure di spicco della cultura giuridica italiana nella prima metà del ’900 con numerosissime celebri pubblicazioni e interventi sulla storia del diritto dall’antichità ai tempi nostri.
Di lui ricordiamo la raccolta lasciata alla Biblioteca apostolica Vaticana (oltre 30.000 pezzi con documenti medievali di ogni genere e codici membranacei, alcuni dei quali testimonianze uniche per il diritto e per la letteratura) nonché le 100.000 opere (moltissime rare e di gran pregio, da lui acquisite in decenni di instancabile ricerca bibliografica) che formarono nell’immediato dopoguerra (e forma tuttora) la base della Biblioteca a lui intestata presso l’Università di Torino.
Formatosi nella sistematica esplorazione di codici e manoscritti delle fonti del diritto romano, canonico e germanico, Patetta si caratterizzò sempre per la passione e la competenza nello studio dei documenti originali anche alle aree della creazione artistica e letteraria, per le quali pure dimostrò una marcata sensibilità: un umanista a tutto tondo quindi, intenditore non solo di pandette.
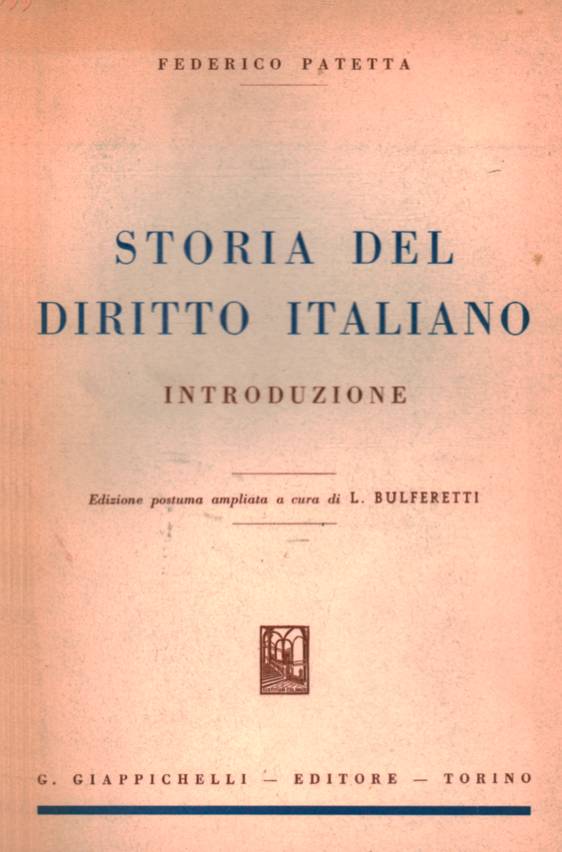
Pur non avendoci lasciato nulla di specifico su Manzoni (ci sembra, ma saremmo felicissimi di essere smentiti da migliori conoscitori della sua opera), Patetta se ne occupò con competenza nei suoi tanti studi sui primi decenni dell’Ottocento italiano, proprio quelli in cui si formò il nostro poeta-romanziere (solo a titolo esemplificativo ricordiamo: “Lettere di Massimo d’Azeglio a Federigo Sclopis”, 1923; “La rivoluzione piemontese del 1821 giudicata da Giacomo Giovanetti”, 1924; “La congiura torinese del 1814 per la rinascita dell’Impero romano e per l’offerta del trono a Napoleone”, 1937; “Pellegrino Rossi e Vincenzo Monti”, sempre del 1937).
Dello studioso, è opportuno ricordare anche la spiccata e nota acribia nella consultazione dei manoscritti, che ci autorizza a ritenere del tutto attendibile l’indice da lui redatto sul piatto della prima di copertina del «Manoscritto Lecco 170» di cui diremo più sotto — ne anticipiamo che siamo pronti a scommettere i gioielli di famiglia circa la precisione di Patetta nell’indicare i numeri di carta delle tre Sezioni componenti il fascicolo!
2.2/ Domenico Bulferetti: competente conoscitore dei manoscritti di Manzoni, portatore di una visione non conformista della sua opera.
Se per Patetta si può parlare di un interesse lato per Manzoni, nel caso di Bulferetti (1884-1969) è invece obbligo l’annoverarlo tra i più interessanti e originali manzonisti del secolo scorso, non ultimo per le sue posizioni politico-ideologiche di cristiano-sociale che gli costarono l’emarginazione anche professionale nel Ventennio fascista (fu radiato dall’insegnamento nelle scuole pubbliche).
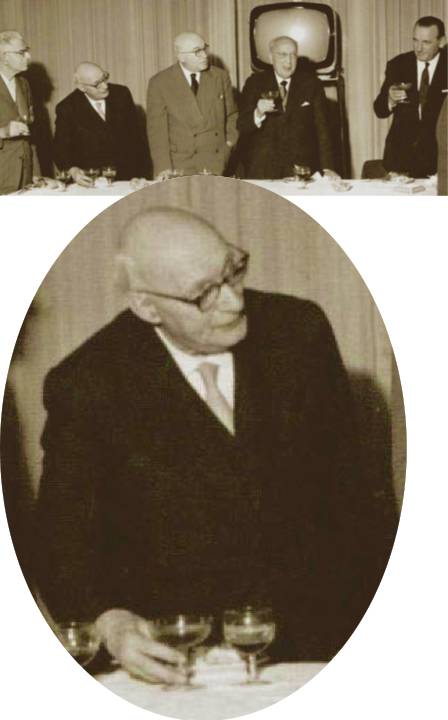
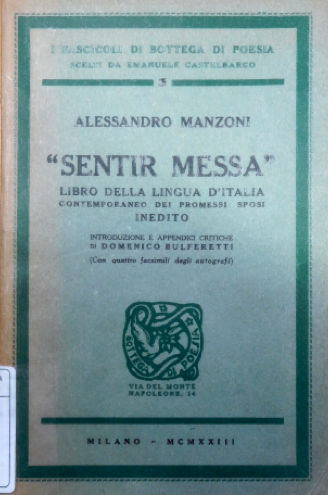
Messosi in luce fin da adolescente per l’interesse e la sensibilità per la creazione letteraria (solo come curiosità, in una accademia scolastica dimostrò di conoscere a memoria l’intera Divina Commedia) e allievo di G. Pascoli alla Normale di Pisa, a Bologna si laureò con ricerche sul Poliziano.
Vicino a Toniolo e a T. Gallarati Scotti, fu seguace di Romolo Murri e con Guido Zadei fu nel 1909 tra i più attivi zanardelliani (il medesimo filone cui tre decenni prima aveva guardato con interesse l’Abate Stoppani), in polemica con il movimento cattolico ufficiale bresciano.
Insegnante di scuola superiore a Varese, con l’imprenditore e assessore Luigi Zanzi, creò il privato Liceo Classico Cairoli, poi statizzato nel 1935. Fu parte attiva della Resistenza (nella foto, del 1960, è al compleanno di Lanciotto Gigli assieme ad altri attivi antifascisti del territorio di Varese).
Amico personale e idealmente vicino a Benedetto Croce, si dedicò intensamente a Foscolo, a Parini e, soprattutto, a Manzoni.
In numerosi articoli (molti nel 1927), mise in luce le trasformazioni — non solo linguistiche e narrative ma soprattutto etiche — del romanzo di Manzoni, dalla “Prima Minuta” del 1821-23 al “I Promessi Sposi” nelle due edizioni del 1827 e del 1840.
Di questo processo di trasmutazione del romanzo egli mirava a mettere in luce la decisiva influenza esercitata su Manzoni da Rosmini già a partire dal 1823 (su questo argomento torneremo in modo diffuso nella già anticipata Nota n. 2).
Grazie alla liberalità di Matilde Shiff Giorgini (nipote abiatica di Manzoni) Bulferetti ebbe accesso a manoscritti di Manzoni dedicati a riflessioni sulla lingua da un punto di vista anche filosofico; li integrò con altri manoscritti rinvenuti alla Braidense di Milano e pubblicò il tutto nel 1924 con il titolo “Sentir Messa”.
In Bulferetti abbiamo quindi un appassionato competente di Manzoni con in più una buona dimestichezza con i suoi manoscritti; il che deve farci guardare con attenzione alle sue pur lapidarie note tracciate sul «Manoscritto Lecco 170» di cui ci occupiamo, al momento le uniche conosciute.
All’Archivio Storico di Stato di Varese, dei 240 faldoni che conservano il suo “fondo”, abbiamo infatti consultato i sette nei quali è stata depositata una parte dell’ingente produzione di Domenico Bulferetti dedicata a Manzoni ma senza trovare alcun riferimento al «Manoscritto Lecco 170».
Cogliamo l’occasione non solo per ringraziare i responsabili dell’Archivio per la cordialissima collaborazione ma anche per richiamare l’attenzione degli studiosi su questo formidabile deposito di appunti, scritti, giudizi di uno degli uomini più originali e dinamici del manzonismo del secolo passato, sensibilissimo al legame tra Manzoni e Antonio Rosmini.
Circa eventuali legami tra Federico Patetta e Domenico Bulferetti, Mario Cianfoni (curatore della “Nota archivistica” del primo studio di Paola Italia, “Gli Sposi promessi”, 2018) così ne ha scritto (p. 151): «Il solo documento, conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana che testimonia un contatto tra Patetta e Bulferetti è uno stampato che illustra le conferenze che quest’ultimo tenne in diverse città italiane fino al 1922. È probabile che lo storico della letteratura abbia inviato questo documento a Patetta in segno di amicizia, con l’auspicio forse di veder presente il collega tra gli uditori di future conferenze.»
Da tenere in conto, ma un po’ pochino!
Evidentemente Cianfoni non ha fatto caso a come tra i due studiosi ci fosse un legame, indiretto ma non per questo meno significativo, rappresentato da Luigi Bulferetti (1915-1992).
Questi, figlio di Domenico, si laureò nel 1936 in giurisprudenza all’Università di Torino con Gioele Solari con una tesi su “Il giovane Rosmini” ma fu allievo anche di Federico Patetta, con il quale stabilì un legame di solida amicizia personale.
Dopo il 1945, Luigi Bulferetti, come Direttore del Museo del Risorgimento di Torino, si attivò per garantire un ambiente adatto all’ingente patrimonio bibliografico lasciato da Patetta (ne abbiamo già accennato sopra). Nel 1947 curò l’edizione postuma del “Corso di Storia del Diritto”, un testo fondamentale nella elaborazione storico-giuridica del maestro, scrivendone una bene informata introduzione.
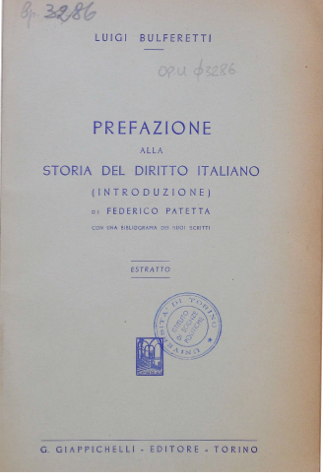
Non ne abbiamo dati documentali ma riteniamo verosimile che Domenico Bulferetti abbia avuto accesso al «Manoscritto Lecco 170» proprio attraverso il proprio figlio Luigi, allievo e amico del suo precedente possessore: per saperne di più sul documento in questione potrebbe quindi risultare utile indirizzare le ricerche anche in quella direzione.
Detto brevemente sui due studiosi di ieri — che in alcun modo mai neppure vagheggiarono di un qualunque legame tra Manzoni e il «Manoscritto Lecco 170» — veniamo a quelli di oggi che invece sembra ne abbiano fatto un articolo di fede.
2.3/ La “diplomatica” di Paola Italia: un interessante caso di studio — ma al negativo.
La “diplomatica” proposta da Paola Italia / Università di Bologna / Centro Nazionale Studi Manzoniani / Comune e Museo Manzoniano di Lecco meriterebbe di essere portata a esempio di come NON si debba procedere in queste operazioni.
Purtroppo, il documento, proposto dalla Professoressa Paola Italia e sodali come base per una “rivoluzione” nella critica manzoniana, si presenta infatti come un raro cumulo di cecità critica e di incapacità trascrittoria.
Su quanto stiamo discutendo, Paola Italia ha pubblicato due studi.
Il primo (febbraio 2018), è titolato «Gli Sposi promessi — Storia milanese epilogata nel 1824»; 32 pagine; a cura di Paola Italia / Università di Bologna; con “Note” (“archivistica” e “all’Appendice”) di Mauro Cianfoni nonché con “Presentazione” di Mauro Rossetto per il Sistema Museale Urbano Lecchese; pubblicato su «Annali Manzoniani» (terza serie, n. 1, 2018, vedi qui il pdf, di pubblico dominio).
Il secondo, pubblicato il 2 dicembre 2019, è titolato «Un nuovo testimone della Lettera sul Romanticismo»; 28 pagine; è della sola Paola Italia / Università di Bologna; pubblicato su «Annali Manzoniani» (terza serie, n. 2, 2019, vedi qui il pdf, di pubblico dominio).
Nelle due pubblicazioni il contributo di Paola Italia si è espresso sia con la “trascrizione diplomatica” dell’intero manoscritto sia con un commento critico a carattere storico-filologico, relativo soprattutto alle Sezioni n. 1 e n. 3 (“Epilogo Gli Sposi promessi” / “Lettera sul Romanticismo”).

“Gli Sposi promessi — Storia milanese epilogata nel 1824”.

“Un nuovo testimone della Lettera sul Romanticismo”.
2.4/ La “trascrizione diplomatica” come specchio di un documento.
Giusto per muoverci con riferimenti condivisi, ricordiamo che per “diplomatica” si intende la descrizione, diciamo così, “fotografica” di un manoscritto, ma attuata attraverso la scrittura.
Leggendo la “diplomatica” di un dato documento, chiunque dovrebbe cioè potere immaginarselo per come è, anche senza vederlo nella sua materialità.
Nella realtà, data la ovvia impossibilità di darne una descrizione perfetta attraverso la parola scritta, la “diplomatica” può risultare veramente utile quando è accompagnata dalla fotografia dell’oggetto stesso.
Attenzione! La “diplomatica” di un documento non ha nulla a che vedere con la veste editoriale che di volta in volta può essere decisa per un dato documento, in funzione del pubblico e dell’occasione.
Purtroppo, in controtendenza con le linee di consultabilità libera e immediata dei manoscritti di Manzoni (già felicemente adottate dalla Biblioteca Braidense di Milano e da altre Istituzioni — una chiara comprensione del ruolo conservatore ma non proprietario del patrimonio collettivo), il Museo Manzoniano di Lecco non mette in linea le immagini dei pur pochi manoscritti affidati dalla collettività alla sua custodia.
Ciò rende impossibile al pubblico verificare se e quanto le informazioni che gli vengono date sui medesimi documenti siano attendibili — siamo convinti che se il «Manoscritto Lecco 170» fosse liberamente disponibile, gli accademici che se ne sono occupati sarebbero stati meno superficiali nel loro operato.
Di questo «Manoscritto Lecco 170», con cui ci si propone di rivoluzionare una importante pagina della critica manzoniana, abbiamo quindi solo la trascrizione “diplomatica” dataci dalla Professoressa Paola Italia.
Il lettore comprenderà perché abbiamo ritenuto opportuno considerarla con attenzione.
Ecco quanto scrive Paola Italia a proposito della trascrizione da lei curata per il «Manoscritto Lecco 170» (Annali Manzoniani, 2018, p. 126, evidenziazione nostra):
«Legenda: nella trascrizione diplomatica del testo vengono utilizzati i seguenti simboli | (cambio carta); <…> parola illeggibile; il testo sottolineato è reso in corsivo; sono state conservate peculiarità di grafia e punteggiatura, a loro luogo segnalate; le penne individuate nel testo: “a” (stesura base), “b” (prima serie di correzioni), “c” (seconda serie di correzioni), sono volta a volta indicate in apparato e discusse nella Nota al testo.»
La Professoressa ci ha così correttamente informato di avere voluto trasmetterci anche i più minuti elementi della grafia e punteggiatura dell’originale, quali i punti, le virgole, gli apostrofi, ecc.
Prima di entrare nel merito di “come” tale buon proponimento sia stato poi effettivamente mantenuto, è opportuno segnalare che la Professoressa Italia ha invece pressoché ignorato elementi di grande importanza.
3. Cinque incredibili casi di “cecità” critica.
Sono da segnalare una serie di “dettagli” ignorati dalla Professoressa Paola Italia, come se la stessa e i suoi sodali in tutta l’operazione fossero caduti preda di una collettiva “cecità”.
Il più evidente di questi pone una ovvia ipoteca sulla natura stessa del «Manoscritto Lecco 170».
3.1/ “Dettaglio ignorato” n. 1.
La numerazione di Patetta non corrisponde a quella del manoscritto.
Dopo essere stato compulsato, prima da Federico Patetta (scomparso nel 1945), e poi da Domenico Bulferetti (scomparso nel 1969), il libretto manoscritto è stato quasi certamente manipolato in un qualche momento dei due decenni che ne hanno preceduto l’acquisizione da parte del Comune di Lecco nel 1988.
Vediamo perché.
A proposito della numerazione delle carte del documento, Paola Italia ha scritto (Annali, 2018, p. 141):
«La numerazione qui utilizzata segue la cartulazione moderna; il documento viene numerato a lapis da p. 1 a 58 in alto a dx.».
Reiterando un suo sistematico errore, Paola Italia ha indicato con “p.” (come “pagina”) ciò che deve invece essere indicato con “c.” (come carta): infatti la numerazione del «Manoscritto Lecco 170» è alle “carte” che compongono il manoscritto e non alle “pagine”.
Ma questo è il meno.
Paola Italia non ci ha infatti segnalato due elementi fondamentali relativi alla numerazione del manoscritto.
Leggiamo sempre dalla “diplomatica” della Prof. Paola Italia (idem, p. 141):
«Di mano del Patetta si legge l’indice del fascicolo, qui sotto trascritto:
I°. Gli sposi promessi. c. 1.
Annotazione e articolo trascritto dalla Gazz. Ufficiale di Milano, n°. 112 del 1833. c. 19.
II°.Sopra di [sic, ndr] diversi sistemi di poesia. Lettera di A. Manzoni al march. Cesare d’Azeglio [ecc.]. c. 23.»
A parte la doppietta di errori di trascrizione al punto IIº (fanno parte della larga famiglia dei 203 errori che abbelliscono questa “diplomatica” — più sotto li elenchiamo con la dovuta completezza), Paola Italia ci racconta che Patetta ha redatto di suo pugno un indice dei contenuti del «Manoscritto Lecco 170», indicando il numero di carta di inizio di ognuna delle sue tre parti, così come segue:
— Sposi promessi, carta 1
— Gazzetta ufficiale, carta 19
— Lettera romanticismo, carta 23.
Perfetto: così è scritto nelle note di Patetta.
Peccato che c’entri poco con la disposizione delle tre parti come la possiamo vedere noi oggi!
Infatti, nel «Manoscritto Lecco 170» abbiamo una realtà diversa:
— è vero che gli “Sposi promessi” cominciano alla carta 1r;
ma è altrettanto vero che
— la “Gazzetta ufficiale” comincia alla carta 21r, anziché 19, come indicato da Patetta;
e che
— la “Lettera sul romanticismo” comincia alla carta 25r, anziché 23.
Ossia, abbiamo uno sfasamento di ben due carte (quattro pagine manoscritte) tra quanto era sotto gli occhi di Patetta e quello che vediamo noi oggi.
Quindi…
quindi i casi sono due:
— o Patetta era preda di sostanze psicoattive mentre redigeva quell’indice …
oppure …
oppure, dopo le sue notazioni qualcuno ha messo le mani sul manoscritto, facendone altra cosa da quanto consultato e annotato dallo scrupoloso studioso.
E infatti …
3.2/ “Dettaglio ignorato” n. 2.
La numerazione delle carte del manoscritto è stata modificata.
Paola Italia ci ha detto che le 58 carte (116 pagine) che formano il «Manoscritto Lecco 170» sono numerate da 1 a 58.
Non ci ha però detto che, almeno a partire dalla carta 6r, il numero [6] è stato sovrascritto a un numero preesistente: sotto il [6] si legge infatti abbastanza distintamente il [5] di una precedente numerazione; la cosa è plateale alla attuale carta 12 dove la seconda cifra della precedente numerazione [11] non è stata neppure sommariamente cancellata.
Il cambio di numerazione a una unità successiva, procede sicuramente fino alla attuale carta 25r (inizio della “Lettera sul romanticismo”) nella quale è invece chiaramente visibile la sostituzione di un precedente [23], quindi con un incremento di due unità (è probabile — ma le tracce sono troppo debolmente visibili nelle fotografie realizzate dal Museo Manzoniano — che questo incremento di due unità sia riscontrabile anche a partire dalla carta [21] con cui inizia la copia dell’articolo di Appiani dalla “Gazzetta Ufficiale”).
Per tutto il resto del manoscritto è comunque visibile, più o meno chiaramente, la cancellazione di una precedente numerazione e la sua sovrascrittura con una nuova, con incremento di due unità.
Sottolineiamo quel nostro “più o meno chiaramente”.
Siamo costretti a non essere categorici quanto vorremmo in quanto abbiamo potuto consultare il documento solo al computer del Museo di Lecco, e per poco tempo, attraverso immagini digitalizzate in modo artigianale, con scatti anche sfuocati, illuminazione mediocre, ecc.
Pur con queste doverose riserve, possiamo però pensare con un ampio margine di legittimità che, in un momento successivo a quello in cui il manoscritto è stato nelle disponibilità di Patetta qualcuno ci ha messo le mani, togliendo, aggiungendo, sostituendo, sovrascrivendo, ecc. ecc.
Quando ciò sarebbe avvenuto?
Data la mancanza di segnalazioni in proposito, ci sembra di potere affermare che, al momento in cui il documento fu nelle disponibilità di Domenico Bulferetti (quindi, sicuramente nell’agosto del 1964, quando egli lo annotò), la numerazione delle carte fosse quale lo aveva visto e annotato Patetta.
Per il “quando” sarebbe avvenuta la manipolazione, stiamo quindi parlando di un “momento” che possiamo ipoteticamente indicare tra il 1969 (scomparsa di Bulferetti) e il 1988, anno di acquisizione del documento da parte del Comune di Lecco sul mercato dell’antiquariato.
Sicuramente Paola Italia, che ha potuto consultare il manoscritto in originale (e che assicura avere utilizzato attrezzature sofisticate per la sua analisi) sarebbe certo stata in grado di leggere anche la traccia di testi cancellati o abrasi e avrebbe potuto dirci qualche cosa di più rispetto alle nostre necessariamente limitate osservazioni.
Ma evidentemente non si è accorta:
a/ della sfasatura nelle pagine a indice di Patetta;
b/ della riscrittura della numerazione sul manoscritto.
Come ognuno può comprendere, la incontrovertibile manipolazione nella numerazione delle carte del manoscritto apre una autostrada all’idea che il manufatto al centro delle nostre attenzioni sia solo una volgarissima patacca, orchestrata da mediocri pataccari, certificata da accademici con la testa altrove e le fette di salame sugli occhi.
Fa infatti specie che la legione di raffinati ed esperti filologi che hanno avuto modo di guardare quanto meno le riproduzioni del manoscritto, non si siano accorti di nulla — ci auguriamo che il lettore sappia apprezzare la sobrietà con cui stiamo presentando queste abnormità critiche, evidenti a chiunque.
3.3/ “Dettaglio ignorato” n. 3.
Il sottotitolo “Storia milanese epilogata”.
Rammendiamo al lettore che il frontespizio della Sezione n. 1 del «Manoscritto Lecco 170» reca queste scritte:
Gli
Sposi promessi
Storia milanese epilogata
Al sottotitolo “Storia milanese epilogata” Paola Italia non ha dedicato neppure una parola; né sul “epilogata” né sul “Storia milanese”.
Perché?
Se, grazie al miracoloso «Manoscritto Lecco 170», secondo Paola Italia, possiamo affermare che lo stesso Manzoni utilizzasse il titolo “Gli Sposi promessi” già per la “Prima Minuta”, allora …
… allora dovremmo allo stesso modo affermare che ciò vale anche per l’espressione “Storia milanese” — e quindi saremmo a DUE rivoluzioni partorite dal «Manoscritto Lecco 170»: titolo e sottotitolo.
Il che apre un problema.
Il sottotitolo “Storia milanese”, fino alla “scoperta” del documento di cui ci occupiamo, era apparso infatti solo ed esclusivamente nella versione a stampa del romanzo, ormai quasi definitivo, iniziata nel luglio 1824 e recante in frontespizio «Gli Sposi promessi / Storia milanese del XVII secolo».
Anche a metà del 1825, a stampa in corso, col mutamento di titolo in “I Promessi Sposi”, il sottotitolo era rimasto invariato.
Quel “Storia milanese” non è invece MAI apparso,
NÉ …
— nella “Prima Minuta” (nelle sue diverse edizioni: Lesca 1916, Ghisalberti 1953, Nigro 2002, Colli/Italia/Raboni 2006);
… e NEPPURE
— nel manoscritto della “Seconda Minuta” (pubblicata nel 2012 da Colli/Raboni).
In quest’ultimo lavoro di Raboni il sottotitolo “Storia milanese” appare solo una volta nella citazione degli Atti della Censura (G. Raboni, Introduzione a «Gli Sposi promessi — Seconda minuta», 2012, p. LXXVIII):
«Nota del luglio ’24 (ASMi, Atti di governo, Studi, parte moderna, cart. 79, n. 1832 del ’24) registrato sotto «MANZONI Alessandro, Gli sposi promessi = Storia milanese del secolo XVII. Admittitur […]».
Ripetiamo la domanda: perché la Professoressa Paola Italia non ha detto UNA parola su questo sottotitolo? Non sarebbe stata anche questa una succulenta “scoperta”?
Ma andiamo avanti.
3.4/ “Dettaglio ignorato” n. 4.
Il “Lazzaretto” dimenticato.
Per quanto riguarda l’onomastica dell’Epilogo “Gli Sposi promessi”, la Professoressa Paola Italia svolge alcune opportune constatazioni sul nome dei vari personaggi che seguono la traccia della “Prima Minuta” tranne un paio di eccezioni (“Ludovico”, che è dell’edizione 1840 de “I Promessi Sposi”; Lucia Mondelli, presente solo in questo testo).
Svolge poi una riflessione circa il nome del pavido don Abbondio, nell’Epilogo indicato sempre come “don Abondio”, con una “b”, distinta dal “Abbondio” di Manzoni, con due “b”.
Di Abbondio/Abondio parliamo poco più sotto.
Qui vogliamo invece segnalare una ulteriore manifestazione della “cecità” già ricordata.
Paola Italia non si è infatti accorta che nell’Epilogo, per le 11 occorrenze in cui compare, viene sempre usato il termine “Lazzaretto” (sempre con iniziale maiuscola e con la “a”).
Manzoni invece, nella “Prima Minuta” (nell’edizione 2006, curata anche da Paola Italia) per 65 occorrenze, utilizza sempre il medesimo termine in due dizioni: per 54 occorrenze “lazzeretto”, per 11 occorrenze “Lazzeretto” (8 di queste concentrate nel Tomo 4, cap. 1, 6d, 6d, 7a,7a, 7b, 7b, 7c, 8c).
Per gli amanti di questi aspetti, completiamo il quadro con le successive edizioni: Ventisettana: 41 “lazzeretto”, 1 “Lazzeretto” (ha l’aria di essere sfuggito per caso alla caccia correttoria); Quarantana: 52 “lazzeretto”, neanche uno con l’iniziale maiuscola.
Il lettore non deve pensare che ci sia venuta la fregola della filologia (per carità!).
Se quella concentrazione statisticamente rilevante di iniziali maiuscole al T. 4, cap. 1, ha un qualche significato nel quadro della stesura del romanzo (c’è sicuramente), ci penseranno gli specialisti a illuminarci.
Per parte nostra, ci siamo qui limitati a riportare un dato di fatto, ignorato dagli estensori della “diplomatica” (ci torniamo sopra più avanti in quanto questa è una delle 23 difformità tra Epilogo e “Prima Minuta” che abbiamo analizzato nella apposita Sezione).
È comunque un elemento che ci è balzato all’occhio anche perché, proprio recentemente, abbiamo riesaminato il breve ma sempre interessante volumetto pubblicato ai primissimi del 1874 dall’Abate Stoppani, dal titolo “I primi anni di A. Manzoni — Spigolature”.
In questa breve ma densa analisi l’Abate, senza occuparsi nello specifico né de “I Promessi Sposi” né tanto meno della “prima minuta” (probabilmente ne sapeva qualcosa, ma nulla più, dall’amico don Natale Ceroli, per dodici anni e fino al 1873 assistente culturale di Manzoni), parlando della figura di Frate Cristoforo, per 4 volte si riferisce al luogo di assistenza agli appestati di Milano come al “Lazzaretto” (con la maiuscola iniziale e la “a”), in aperta dissonanza con Manzoni, la cui opera l’Abate conosceva benissimo e apprezzava ancor di più.
Ci sembra verosimile pensare che l’Abate prendesse il termine dalle cronache che egli andava leggendo per avere idee più precise sulla figura anche storica di Padre Cristoforo — per esempio la cronaca di Pio La Croce, citata dallo stesso Manzoni come sua fonte.
D’altra parte la forma usata da Manzoni è meno precisa rispetto a quella dominante allora e oggi. Il termine usato da Manzoni non è riuscito infatti a imporsi, proprio per il legame evidente e stringente che ha “Lazzaretto” con il nome del noto personaggio del Vangelo.
3.5/ “Dettaglio ignorato” n. 5.
I non visti 40 segni di percontazione.
Decisamente inspiegabile è la cecità sui 40 segni di percontazione [⸮] inseriti dal copista nella “Lettera sul romanticismo”.
Per chi non ne fosse a conoscenza (cosa assolutamente legittima), il segno di percontazione, sporadicamente usato in manoscritti medievali, venne “inventato” a fine del XVI secolo come carattere per la stampa dal tipografo inglese Henry Denham.
Noto agli appassionati della punteggiatura — e apprezzatissimo — ne parla M.B. Parkes nel suo «Pause and Effect — An Introduction to the History of Punctuation in the West», del 1992 (pp. 53-54, 137, traduzione nostra):
«Henry Denham sembra essere stato interessato alla punteggiatura, poiché due dei libri che pubblicò negli anni 1580 contengono un altro nuovo, ma raro segno, il “percontativus”. Questo consiste in un interrogativus, rovesciato a specchio, ed è usato per contrassegnare una “percontatio”, ossia una domanda “retorica”, una domanda che non richiede risposta. […]
Il contrasto tra l’indicazione di Ps. XVIII, 31 con percontativus nel testo di Gilby in caratteri romani e l’indicazione dello stesso verso con interrogativus nel “Monument of matrones” di Bentley stampato da Denham in carattere neretto un anno dopo, suggerisce che l’aspetto del simbolo dipendeva dalla fonte impiegata così come dalla scelta dell’autore.
Ciò considerato, sembrerebbe che il percontativus fosse limitato al suo font romano. Per la maggior parte, gli autori e i compositori del XVI e XVII secolo o omisero di marcare una percontatio, oppure usarono l’interrogativus; ma il percontativus appare di tanto in tanto nel XVII secolo: per esempio, nelle olografie di Robert Herrick e Thomas Middleton.
[…]
Altri esempi di percontativus appaiono in “The logike of the moste excellent philosopher P. Ramus, martyr, Newly translated, and in divers places corrected”(Londra, Thomas Vautrouiller, 1574); e “The paradyse of daynty devises, aptly furnished with sundry pithie and learned inventions” (Londra, Henry Disle, 1576).»
Non volendo infierire oltre, pensiamo che queste poche note siano sufficienti a far comprendere come il punto percontativo, espresso con il simbolo del punto interrogativo messo a specchio, è nato in Inghilterra nella prima maturità dell’arte della stampa ma è poi rapidamente defunto, senza riuscire a imporsi nella comunicazione editoriale corrente.
Da segnalare che a fine ’800 il poeta e scrittore francese Marcel Bernhardt (1868-1942, in arte Alcanter de Brahm) concepì il “point d’ironie” (che può ricordare il nostro punto percontativo) per marcare il tono di scherno e scherzo.
Alcanter lo utilizzò per la stampa del suo romanzo «L’ostensoire des ironies» dove questa innovazione tipografica ci sembra però non abbia portato a grandi risultati.
Il segno di percontazione, comunque, gode di un suo statuto digitale ed è reso con il seguente codice:
Numero Unicode: U+2E2E.
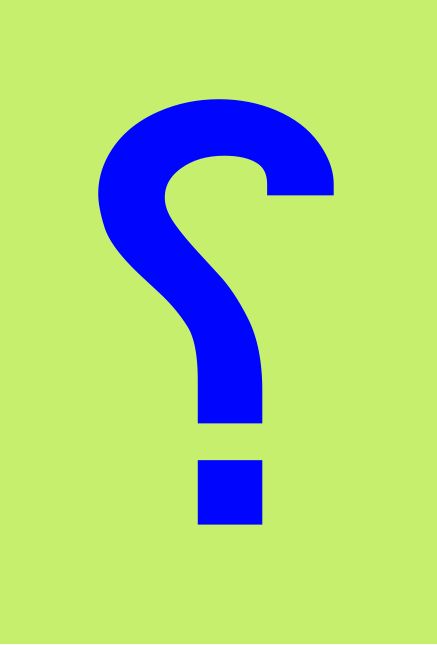

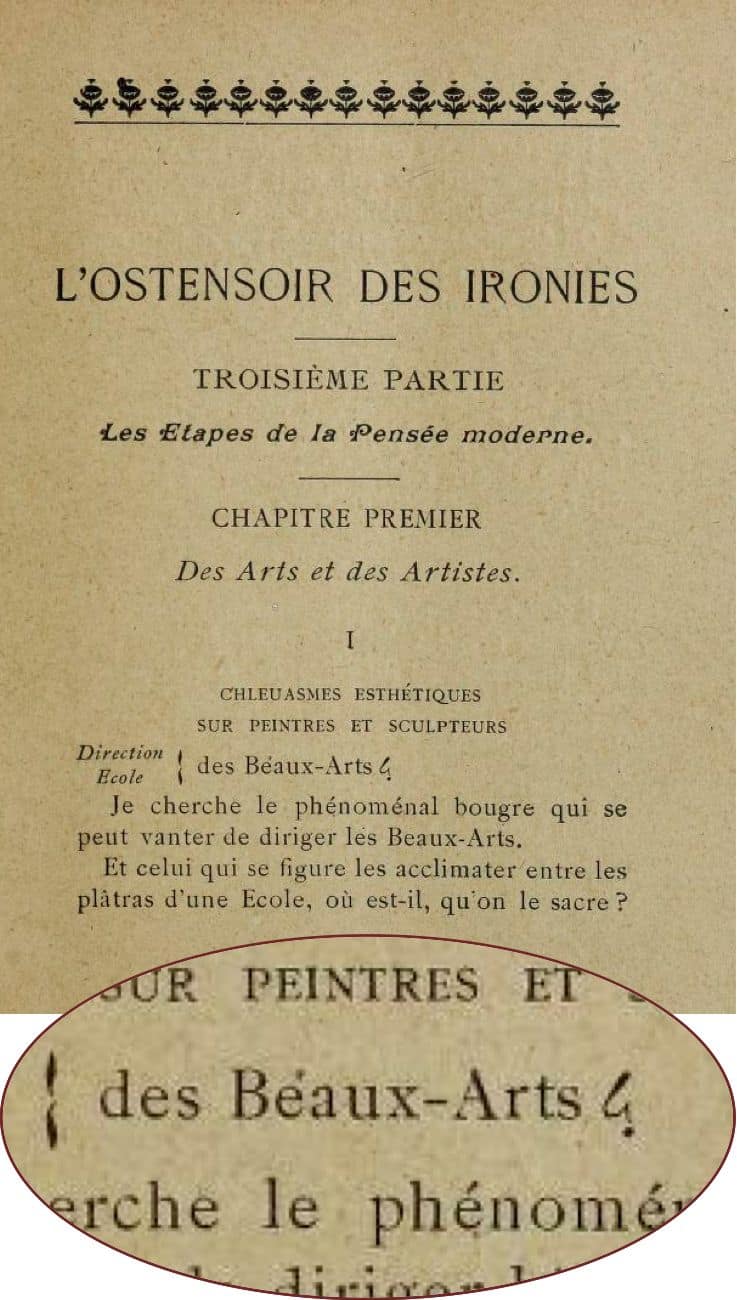
In Italia, a che ci risulti (ma ciò significa poco, bisognerebbe sentire che ne dicono gli amici accademici impegnati negli studi filologici) il punto percontativo non si è mai neppure affacciato ai banconi delle nostre tipografie e tanto meno nelle penne dei nostri scrittori di vario ordine.
Men che mai nella penna di A. Manzoni: non siamo noi gli specialisti dei manoscritti del nostro autore ma ci sembra che egli mai abbia usato quel simbolo.
Da ricordare, comunque, che Manzoni era invece un grande estimatore — e utilizzatore — della domanda retorica, del resto molto usata nella comunicazione religiosa, e da un bel pezzo.
E questo forse spiega quel seminare a piene mani il punto percontativo nel «Manoscritto Lecco 170».
Se (come sempre più ci sembra lecito pensare) quel fascicoletto è stato approntato come piattino per appassionati di ricordi manzoniani, è possibile che l’abbellimento della “Lettera sul Romanticismo” con quei 40 percontativi, sia stato pensato come un ulteriore insaporitore di taglio “ultra manzoniano”.
Comunque sia, siccome quel punto di percontazione è una assoluta rarità nella nostra lingua (forse in questo il «Manoscritto Lecco 170» è un unicum) quei 40 segni di percontazione sono da considerarsi veri e propri marcatori, utilissimi per risalire all’identità dello scrivano o del committente — o per dedurne il carattere eventualmente artefatto dell’intero fascicoletto.
Rimane un mistero (come il quarto di Fatima) il perché di questa legione di percontativi non si siano assolutamente accorti la Prof. Paola Italia e tutti i suoi dottissimi colleghi che hanno (o avrebbero dovuto) dare almeno un occhio alle scansioni del «Manoscritto Lecco 170».
A meno che — invece — se ne siano perfettamente accorti (i nostri Prof. sono tutto tranne che tonti) e abbiano pensato di tenere la cosa al caldo per una prossima straordinaria “rivelazione” — ma certo questa è cosa neppure da pensare!
Dopo questa parentesi dedicata alla “cecità critica”, andiamo avanti, occupandoci però di un’altra patologia.
4. Marasma trascrittorio.
Purtroppo sì!
Sono ben 203 gli errori veri e propri da noi riscontrati nella trascrizione “diplomatica” delle 116 pagine del “Manoscritto Lecco 170”.
Alcuni di questi 203 errori ci erano apparsi con evidenza anche senza avere visionato gli originali: per tutti, un «circostanze indicenti» in luogo di un ovvio «circostanze incidenti»; nella lettera sul romanticismo un divertente “fabulæ” al posto di “tabulæ” e una valanga di accenti acuti (perché, benché, poiché, né) in luogo dell’accento grave, usato nella grafia ottocentesca.
Queste evidenze ci hanno indotto a un riscontro diretto del manoscritto, seppure mediato dalle riprese digitali realizzate dal Museo Manzoniano di Lecco (non un granché ma sufficienti alla bisogna), che abbiamo potuto consultare attraverso le postazioni di lavoro del Museo stesso.
È difficile comprendere come sia possibile una tale massa di errori, forse dovuti ad assistenti distratti.
Sta di fatto, però, che Paola Italia non ha evidentemente proceduto ad alcuna verifica, basandosi incautamente su questa selva di errori anche per avanzare proprie considerazioni critiche e rimanendone quindi essa stessa impaniata.
La Professoressa ha infatti svolto alcune sue riflessioni di carattere filologico su elementi assenti nel manoscritto ma introdotti proprio dalla sua erronea trascrizione.
In altri casi, invece, non ha svolto opportune deduzioni o approfondimenti a causa della mancata segnalazione nella “diplomatica” di evidenti anomalie nel manoscritto.
Dei 203 errori che abbiamo rilevato, il lettore troverà che alcuni sono seriali (per es. virgole che diventano punto e virgola o viceversa, oppure la mancata segnalazione degli interrogativi retorici appena ricordati) ma è purtroppo obbligatorio evidenziarli tutti.
Segnaliamo che altri eventuali errori nella trascrizione possono esserci sfuggiti per le non agevoli condizioni in cui abbiamo svolto la verifica e il decisamente breve tempo di cui abbiamo potuto fruire all’interno di Villa Manzoni, confortati comunque dalla cordiale ospitalità del Direttore Rossetto e dei suoi collaboratori.
Prima di passare al fatto, vorremmo chiarire che non ci diverte mettere in luce gli errori altrui.
In questo caso, però, dal momento che l’analisi accademica sul «Manoscritto Lecco 170» ha necessariamente preso nella dovuta considerazione anche i dettagli linguistici, riteniamo che per potere formulare su di esso una qualsiasi valutazione qualitativa, sia necessario in via preliminare partire con la lavagna pulita, per non prendere cantonate dovute all’imperizia della trascrizione.
Vorremmo dire solo una cosa prima di passare alla penna rossa e blu.
Come è possibile che questo incredibile pasticcio sia stato combinato dalla Professoressa Paola Italia? Ci sembra veramente impossibile.
Preferiremmo di gran lunga che la Professoressa ci dicesse francamente: cari signori, è vero! di questo lavoro mi sono occupata molto alla lontana; ho affidato la cosa ai miei giovani collaboratori dell’Università, non li ho controllati e l’hanno fatta fuori dal vaso.
Chiedo scusa a tutti! Azzeriamo questa brutta pagina!
Ora me ne occuperò io e in un tempo che vi assicuro breve, vi presenterò qualche cosa di serio!
Se la Prof. ci dirà un qualche cosa del genere, faremo finta di nulla e aspetteremo che si riscatti con un bel lavoro su questo benedetto «Manoscritto Lecco 170».
Ma se invece risultasse che il pasticcio è frutto del lavoro diretto della Professoressa Italia, allora ci sarebbe veramente da preoccuparsi!
4.1/ I 203 errori nella “diplomatica” del «Manoscritto Lecco 170».
Prima di darne il lungo elenco, facciamo chiarezza sul come leggerlo, partendo da un esempio preso dal vivo:
[9r] oggetti, entrato] entrato,
In questo caso, stiamo considerando la carta 9 recto; «entrato» della “diplomatica” è segnato in rosso perché gli manca la virgola finale; dopo la parentesi quadra] è indicato in blu il termine del manoscritto «entrato,» — con la virgola.
Ma come? anche se alla diplomatica manca un virgoletta, si considera errore? Sì, è errore.
Altro esempio:
[13v] A questa epoca] quest’epoca
In questo caso consideriamo invece la carta 13 verso; «questa epoca» della “diplomatica” è segnato in rosso perché tra le due parole dovrebbe esserci l’apostrofo; dopo la parentesi quadra] è indicato in blu l’espressione corretta del manoscritto originale «quest’epoca» — con l’apostrofo.
Una unica segnalazione: là dove scriviamo <non segnalato>, intendiamo che: nel manoscritto originale è stato scritto con errore; che il compilatore della “diplomatica” ha corretto l’errore ma senza segnalare la cosa — il che, dal punto di vista della redazione di una “diplomatica”, è ovviamente un errore.
Cominciamo.
«Sposi promessi, storia milanese compendiata».
[40 pagine manoscritte / 17 errori di trascrizione]
1. [1v] <La pagina è bianca — ne manca l’indicazione>
2. [2v] rientri] onde rientri
3. [3v] inclinando] inclinato
4. [3v] dovvrebber] dovrebbero
5. [4r] Abbondio] Abondio
6. [6v] conte] Conte
7. [9r] entrato] entrato,
8. [9v] convento] Convento
9. [10r] quella.] quella <si è aggiunto un punto di fine frase, là dove è evidente essere stato lasciato dal copista uno spazio vuoto da riempire in una seconda fase>
10. [13v] peste.] peste <non segnalato>
11. [13v] questa epoca,] quest’epoca,
12. [15v] sopravvissuta] sopravissuta
13. [16v] à] a’
14. [18r] questi vi fosse] questi fosse
15. [18v] quando] quanto
16. [19r] perché] perchè
17. [21r] indicenti] incidenti
«Appendice — Rinvenimento dell’Effigie della Signora di Monza.
[8 pagine manoscritte / 15 errori di trascrizione]
18. [21r] Appendice] <è indicata come essere parte del manoscritto, il che non è>
19. [21r] Leyva] Leyva,
20. [21r] acciocché] acciocchè
21. [21v] L’autore] L’Autore
22. [21v] Monza] Monza.
23. [22r] avea] aveva
24. [23r] quasi] quasi di
25. [23r] 37] 37.
26. [23r] 25] 25.
27. [23r] quasi pien] quasi di pien
28. [23v] già lungamente] lungamente
29. [23v] intendere,] intendere
30. [24r] essere stato il] essere il
31. [24r] Senza] senza
32. [24r] perché] perchè
«Sopra i diversi sistemi di Poesia»
(Un nuovo testimone della Lettera sul Romanticismo).
[66 pagine manoscritte / 162 errori di trascrizione]
- [25v] <la pagina è bianca; non segnalato>
- [27r] poiché] poichè
- [27r] pensando] pensando,
- [27r] =] =;
- [27v] fatto?] fatto⸮
- [28r] vi intendo] v’intendo
- [29r] &.] &c.
- [29v] su la] sulla
- [30r] studj] studj,
- [30r] sopravvivere] sopravivere
- [31r] pro’] pro
- [31v] personaggi,] personaggi
- [32r] all’adorazione:] all’adorazione;
- [32v] idolatria?] idolatria⸮
- [32v] raccomandarla?] raccomandarla⸮
- [32v] mitologia?] mitologia⸮
- [32v] cose:] cose;
- [33r] distruggere,] distruggere;
- [33r] esprime?] esprime⸮
- [33r] simpatia?] simpatia⸮
- [33r] parla?] parla⸮
- [33r] fare?] fare⸮
- [33r] guerra che,] guerra, che
- [33v] né] nè
- [33v] né] nè
- [34r] l’ignora?] l’ignora⸮
- [34r] dell’ingegno] dell’ingeno <non segnalato>
- [34r] altre,] altre
- [34r] nostro,] nostro;
- [34r] immagini] immagini,
- [34r] gusta] gusta,
- [34r] dell’antichità quegli] dell’antichità, quelli,
- [34r] e che] e
- [34v] adoperato,] adoperato;
- [34v] lettere:] lettere;
- [34v] coloro] coloro,
- [34v] censurarli:] censurarli,
- [35v] dei] de’
- [35v] ciò] ciò,
- [35v] v’era] vi era
- [36r] esempio,] per esempio
- [36r] commedie] comedie
- [36r] sieno] siano
- [36r] lasciare?] lasciare⸮
- [36r] eccellenti] più accellenti
- [36v] modello.] modello,
- [36v] parole, né] parole; nè
- [37r] persuadere fa] persuadere, fa,
- [37r] singolari:] singolari;
- [37r] questione] quistione
- [37v] parole;] parole,
- [37v] hanno;] hanno,
- [37v] sentimenti] sentimenti,
- [38r] una ammirazione] un’ammirazione
- [38r] sé] se
- [39r] foss’anche] fors’anche
- [39r] attenzione,] attenzione
- [39v] ciarlato] parlato
- [39v] dolermi o rallegrarmi] rallegrarmi o dolermi
- [39v] offrirle] offerirle
- [39v] m’ha] mi ha
- [40r] no?] no⸮
- [40v] infatti] in fatti
- [41r] regole?] regole⸮
- [41r] manifesto?] manifesto⸮
- [41r] volere] voler
- [41r] pedanti?] pedanti⸮
- [41r] avvenuto?] avvenuto⸮
- [41v] confusione?] confusione⸮
- [41v] d’ingegno?] d’ingegno⸮
- [41v] bisogno?] bisogno⸮
- [41v] lode?] lode⸮
- [41v] originalità?] originalità⸮
- [42r] scoprirla?] scoprirla⸮
- [42r] bene?] bene⸮
- [42r] perché] perchè
- [42r] del] per
- [42r] detto] detto:
- [42v] m’è] mi è
- [43r] elle] esse
- [43r] né] nè
- [43v] modo.¶] modo. <senza accapo>.
- [43v] pratica?] pratica⸮
- [43v] fatto?] fatto⸮
- [43v] grand’uomo?] grand’uomo⸮
- [43v] poi?] poi⸮
- [43v] essi?] essi⸮
- [43v] Ella?] Ella⸮
- [44v] quegli] quelli
- [45r] obbiezione] obbjezione
- [45v] ch’elle] ch’esse
- [45v] campo;] campo:
- [45v] vecchie?] vecchie⸮
- [46r] mai?] mai⸮
- [46v] nuove?] nuove⸮
- [46v] avvertirle;] avvertirle:
- [46v] sistema?] sistema⸮
- [46v] meritata?] meritata⸮
- [46v] possibile?] possibile⸮
- [46v] scrittori?] scrittori⸮
- [47r] polemiche,] polemiche
- [47r] romantico,] romantico
- [47r] stabili,] stabili
- [47r] strano,] strano;
- [47r] importante,] importante;
- [48r] diffondersi] diffundersi <non segnalato>
- [48r] né] nè
- [48v] invece] in vece
- [48v] vi] si
- [48v] stata] fatta
- [48v] per] a
- [48v] cosa] cosa,
- [48v] l’ingegno umano non] l’ingegno non
- [49r] formole] fomole <non segnalato>
- [49r] sè] se
- [49r] E] Ed
- [49v] della] dalla
- [49v] momento] momento,
- [49v] esiste,] esiste;
- [49v] principi] principj
- [50r] Omettendo [>Ommettendo]] Omettendo
- [50r] precetti] precetti,
- [50v] possano] possono
- [50v] sentita, ma ragionata, ma ricevuta] sentita, ma ricevuta
- [51r] bello,] bello;
- [51r] cose,] cose
- [51r] l’interesse,] l’interesse
- [51r] l’impossibilità] l’impossibilità,
- [51r] storico] storico,
- [51v] meglio,] meglio
- [51v] l’interesse;] l’interesse,
- [52r] vivamente] vivamente,
- [52r] stupirsi] stupirsi,
- [52r] artificio] artifizio
- [52r] incerto] incerto,
- [52r] vocaboli] vocabili <non segnalato / presente in Tommaseo>
- [52r] E] E,
- [52r] di essi] d’essi
- [52v] da ciò che,] da ciò, che
- [52v] quello] quello,
- [53r] generale,] generale;
- [53r] tutti;] tutti,
- [53r] approvato?] approvato⸮
- ]53v] uno] un
- [53v] Basta] Basta,
- [53v] patriotica,] patriotica;
- [54r] sembra] sembra,
- [54r] gli insegnamenti] gl’insegnamenti
- [55v] d’averle] di averle
- [55v] non so] non so,
- [55v] preso] presa
- [56r] fabulæ] tabulæ
- [56r] io?] io⸮
- [56r] parlarne] parlare
- [56r] società alcuno venisse] società veniste
- [56r] chiedere] chiedere,
- [56r] vedrebbe] vedrebbe,
- [56r] intende un non] intende non
- [56r] alcuno;] alcuno,
- [56v] attingere] attignere
- [56v] dell’idea] dell’idea,
- [57v] &.] &c.
- [58r] come Ella] com’Ella
Foglio di risguardo A — Appunti Patetta.
196. [AV] IIº.Sopra di] IIº. Sopra i
È opportuno segnalare che a questi 196 veri e propri errori di trascrizione, vanno aggiunti altri 7 errori (tutti dello stesso tipo, forse dovuti a una distrazione nella formattazione tipografica del testo) relativa alla mancata segnalazione del segno di accapo per le parole di fine pagina:
197. isgomen | tare [5r]
198. Monaste | ro, [6r]
199. di abbon | danza, [9v]
200. e di | cendo [10v]
201. il tu | multo [11v]
202. conteso va | cante [12v]
203. promesso perdo | no [20r]
Al lettore che dovesse considerare viziata da eccessiva acribia il richiamo di questi ultimi errori, segnaliamo che non abbiamo fatto altro che attenerci ai criteri utilizzati dalla attuale filologia d’autore.
Per esempio, dalla stessa Professoressa Paola Italia che nel “Fermo e Lucia”, da lei edito nel 2006 in cordata anche con Giulia Raboni, ha correttamente utilizzato il [-|] quando occorrente:
> i loro contem-|poranei (p. 17)
> ci riman-|gono (p. 141)
> di rispon-|dermi (p. 173)
> raccoglier rim-|brotti. (p. 202)
> antici-|patamente (p. 207).
4.2/ Vittima di fuoco amico?
Si diceva più sopra che la stessa Paola Italia è rimasta vittima della ingenua superficialità con cui è stata condotta questa “trascrizione diplomatica”.
Ne diamo solo qualche esempio, relativo alla terza sezione del manoscritto, occupata dalla lettera di Manzoni a d’Azeglio padre.
UNO/ Là dove (Annali Manzoniani 2019, p. 196, n. 68) analizza nel testo l’uso delle forme elise, Paola Italia indica, tra i vari, come elemento di distinzione tra il “manoscritto di Lecco” [L] e l’autografo [A], anche il «m’ha/mi ha».
Il problema è che la forma “m’ha” in [L] è una invenzione del compilatore della diplomatica: in realtà in [L] si trova “mi ha”, esattamente la forma dell’autografo [A]:«[39v] «Ma la bontà, ch’Ella m’ha] mi ha» (in prima posizione e in rosso, seguito da], l’errore di trascrizione del compilatore).
DUE/ Lo stesso per l’elisa «come Ella/com’Ella».
Anche in questo caso il “come Ella” è invenzione del compilatore e non di [L] che invece reca: «[58r] benevolenza, come Ella] com’Ella».
TRE/ D’altra parte, sempre nella analisi delle forme elise, e sempre per il malaccorto operato del trascrittore, Italia non ha potuto evidenziare altri casi in cui non vi è affatto discordanza tra [L] e [A], perché in [L] è trascritto con errore:
«52r] E per non parlare che d’uno di essi] d’essi»;
«[54r] con gli insegnamenti] gl’insegnamenti»;
«[55v] Dopo d’averle] di averle»;
«[58r] benevolenza, come Ella] com’Ella».
QUATTRO/ Stesso discorso (n. 68, p. 197) circa l’uso di alcune forme dissimilate come «in vece/invece». Ma in [L] abbiamo proprio “in vece” «[47r/48v] per meglio dire, se invece] in vece».
CINQUE/ Altro caso: “principj/principii”.
Italia scrive (“Un nuovo testimone”, p. 197):
«uso sistematico della «j» (caratteristico della prima minuta, poi corretto in “ii”) e spesso già corretto da Manzoni nell’autografo della Lettera: varj / varii, giudizj/giudizii, principj/principii [ma: principi/principii]».
Con quell’ultimo [ma: principi / principii], Italia indica come eccezione un caso in cui, secondo quanto essa ha sotto mano dalla trascrizione diplomatica, in [L] vi sarebbe l’uso di “principi”.
Anche questo però è un falso problema, essendo “principi” una invenzione del compilatore della “diplomatica”. [L] infatti reca “principj”: «[49v] diversità dei principi] principj».
SEI/ Altro caso ancora.
Italia scrive (idem) di «uso sistematico della forma: “questione“, rispetto a “quistione“, tranne nel caso: «il mio modo particolare di vedere in quella quistione».
Qui Paola Italia si riferisce a una occorrenza presente in [28v].
La Prof. non ha potuto accorgersi che il caso, da lei segnalato come unico, ha invece un gemello: in [37r] del manoscritto si trova infatti «che nessun uomo d’ingegno piglierà a trattare la quistione,» (non “questione” come infedelmente trascritto dal compilatore).
SETTE/ E ancora.
Scrive Italia (p. 197): «Solo in pochi casi, imputabili piuttosto a errore, la copia Finazzi [F] discorda dal manoscritto lecchese [L] e dall’autografo [A]: «ciarlato [L e A] / parlato [F]».
Peccato che in [L] sia “parlato” e non “ciarlato”, come riportato dal compilatore: «[39v] anche troppo ciarlato] parlato» — l’errore c’è ma è stato fatto dal gruppo di lavoro della Professoressa, lasciato senza briglie.
OTTO/ Idem: «dolermi o rallegrarmi [L e A] / rallegrarmi o dolermi [F]».
Spiace per Italia ma in [L] non è presente “dolermi o rallegrarmi” ma “rallegrarmi o dolermi”, come in [F]: «[39v] s’io debba dolermi o rallegrarmi] rallegrarmi o dolermi».
4.3 / Un suggerimento alla Prof.
Al lettore che dovesse chiedersi come è possibile una tale massa di errori, rispondiamo che il responsabile della trascrizione del manoscritto nella diplomatica deve avere avuto una bella pensata: prendo il testo della lettera già digitato (su Internet se ne trovano numerosi esemplari) e modifico il già scritto sulla base del riscontro sul manoscritto affidatomi.
In questo modo, con l’idea di semplificarsi il lavoro, ha invece solo imitato Tafazzi, mettendo in difficoltà la sua Prof. (che appare come una ingenua sprovveduta); mettendo fuori pista tutti gli studiosi che si sono basati su quella “diplomatica” per trarne eventualmente delle considerazioni (che si sentono presi per i fondelli); prendendo in giro tutti i lettori che, come noi, hanno pensato di imparare qualche cosa su Manzoni e hanno invece solo imparato che nelle accademie si può eccellere anche in bischeraggine.
Suggeriamo alla Prof. di sottoporre il distratto assistente a una vigorosa lustratio!
In attesa, tocchiamo un altro aspetto di questa disastrata “diplomatica”.
5. Diplomatica deformante.
Abbiamo appena visto come la “diplomatica” offertaci dalla Professoressa Paola Italia è purtroppo affetta da gravi patologie (alcune cose non le vede proprio, altre le vede male) nefaste per una corretta visione critica del «Manoscritto Lecco 170».
È opportuno segnalarne anche un’altra caratteristica, sicuramente più negativa, emersa nella ipotesi formulata dalla Professoressa Italia circa la datazione del manoscritto in esame.
5.1/ Quando è stato composto il Manoscritto?
Abbiamo già segnalato come il 6 maggio 2021, nell’intervista alla emittente Lecco FM, la Professoressa Italia assicurasse gli ascoltatori di avere sottoposto il «Manoscritto Lecco 170» ad analisi strumentali sofisticate (tra queste la “spettrografia”), grazie alle quali aveva potuto attribuire alla mano di Manzoni la famosa frasetta di sei parole, su cui si basa l’intero disegno critico recentemente avviato dalla Professoressa sulla genesi del romanzo di Manzoni.
Diciamo noi che, sulla base delle analisi cui ha fatto riferimento, la Professoressa Paola Italia dovrebbe avere raccolto dati probanti anche sulla datazione del «Manoscritto Lecco 170».
Si sa infatti che la “spettrografia” offre un validissimo aiuto ai ricercatori (e anche agli investigatori e ai giudici) per indicare con buona precisione la datazione degli inchiostri utilizzati per la scrittura di un dato documento.
La Prof. dovrebbe quindi essere in grado di dirci — quantomeno — se il «Manoscritto Lecco 170» è stato approntato nella prima parte dell’Ottocento, oppure un secolo dopo (diciamo così, tanto per dire).
Forse per non annoiare il lettore con grafici, tabelle o altri tecnicismi, la Prof., sulla possibile datazione del «Manoscritto Lecco 170», non ha però né scritto né detto nulla di più di quanto essa stessa aveva già pubblicato ai primi del 2018, nel suo studio «Gli Sposi Promessi», edito dal Centro Nazionale Studi Manzoniani.
Per farci una idea su questo importante aspetto della questione, non possiamo quindi che rifarci a quanto lì scrisse la Professoressa (“Gli Sposi promessi”, p. 143, evidenziazioni nostre):
«La datazione più probabile di tutto il manoscritto è quella indicata dal Bulferetti, che individua il terminus post quem nel 1824, anno del rifacimento “con molte variazioni” della “prima composizione” (che, per l’intero manoscritto, può arretrare al 1823, segnato a penna “b”, accanto al frontespizio della Lettera al d’Azeglio) (47) e il terminus ante quem del supporto cartaceo nel 1835, data della morte di Francesco I, dopo la quale non venne più stampata carta filigranata con le sue iniziali.»
Sulla questione chiave della datazione del «Manoscritto Lecco 170», Paola Italia, quindi, si rifà alla autorità di Domenico Bulferetti, il quale — sono sue parole — la avrebbe indicata tra il 1824 e il 1835.
Curioso vero?
In tutta l’operazione critica lanciata il 5 maggio 2021 dalle Professoresse Italia e Raboni (con il consenso di notissimi accademici manzonian-manzonisti) non è mai stato citato (neppure di sfuggita) il nome di Bulferetti.
Quando però si tratta di prendere una posizione impegnativa, come l’indicare la datazione del «Manoscritto Lecco 170», è proprio al nome di Bulferetti che ci si rifa come a un padre della patria manzonian-manzonista, da tutti stimato e onorato.
Sarebbe una bella soddisfazione per il buon Bulferetti, accuratamente silenziato (in vita e poi) per le sue posizioni eterodosse circa la formazione del romanzo di Manzoni (di tutto ciò ci occuperemo per esteso nella Nota n. 2 che produrremo sul passaggio del romanzo di Manzoni dalla “Prima Minuta” all’edizione del 1827).
Peccato, però, che tutto ciò sia solo una fantasia della professoressa Paola Italia!
Bulferetti, infatti, mai si sognò di indicare alcuna possibile data per il «Manoscritto Lecco 170», come andiamo a indicare qui di seguito.
5.2/ A proposito del “ante quem”: le annotazioni di Domenico Bulferetti.
Sul «Manoscritto Lecco 170» Bulferetti si è limitato a due brevi interventi:
— sul piatto della prima di copertina (utilizzato da Patetta per l’indice delle tre parti del manoscritto e per sue notazioni) con 3-4 sottolineature; le quali sono presentate da Paola Italia come indicazioni di Bulferetti sulla data “entro la quale / ante quem”, il «Manoscritto Lecco 170» sarebbe stato compilato;
— sul frontespizio, dove, a commento della frase «Sopra la prima composizione rifatta con molte variazioni» (posta da un ignoto, in data ignota) ha scritto poche parole; le quali sono a loro volta presentate da Paola Italia come indicazioni di Bulferetti sulla data “dopo la quale / post quem” sarebbe stato compilato il medesimo manoscritto.
Per l’intelligenza del tema “datazione”, di cui stiamo discutendo, può essere quindi utile visualizzare sia il “piatto di copertina” sia il “frontespizio”, collocati nella vetrinetta dedicata al «Manoscritto Lecco 170», Sala 8, Museo Manzoniano di Lecco; da noi fotografati nel 2019.
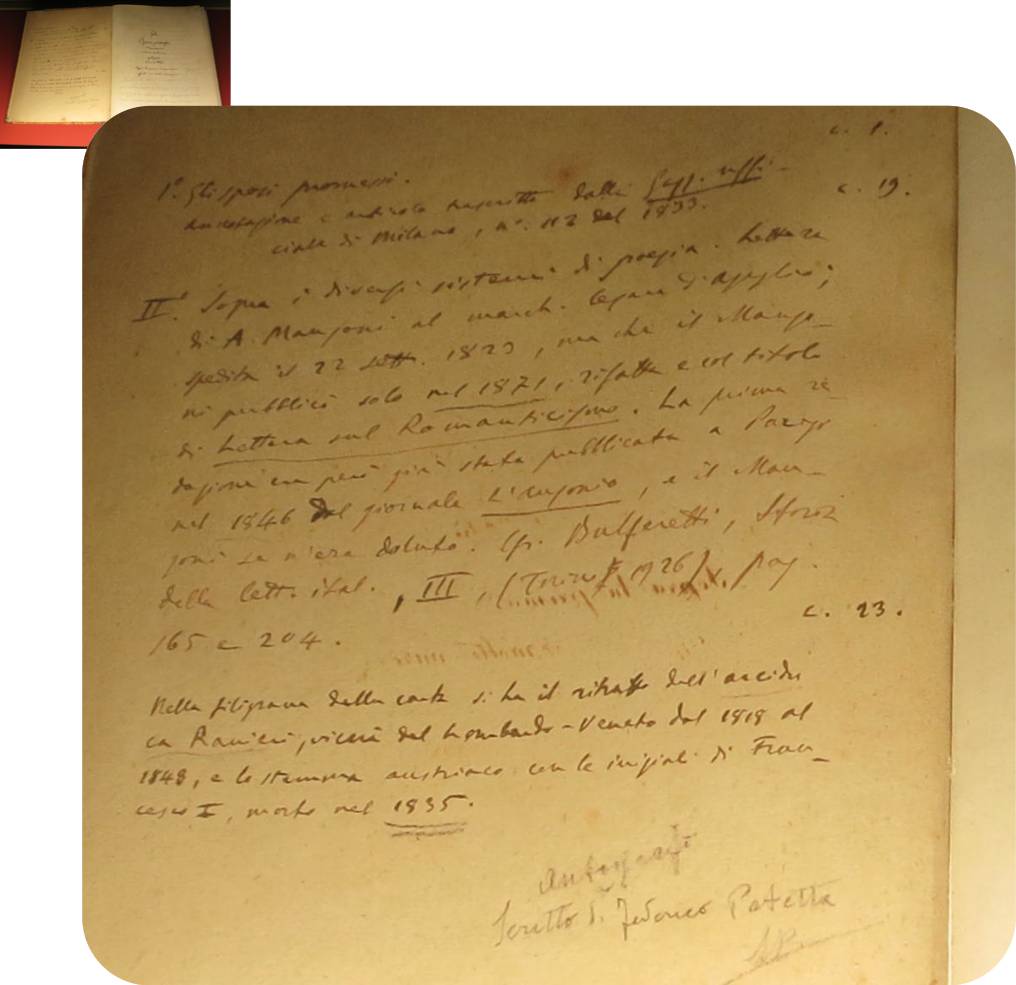
Come ogni lettore può agevolmente constatare, su questa facciata manoscritta da Patetta, sono distinguibili 7 sottolineature:
1 / “Gazz. ufficiale”
2 / “nel 1871”
3 / “Lettera sul Romanticismo”
4 / “1846”
5 / “L’Ausonio”
6 / “arciduca Ranieri”
7 / “1835”
Abbiamo poi una notazione: “Autografo | Scritto di Federico Patetta” cui segue una sigla che Paola Italia indica come “DB” [Domenico Bulferetti].
A noi pare che questa notazione sia di grafia diversa da quella di Domenico Bulferetti e che la sigla debba essere letta come LB (Luigi Bulferetti, il già ricordato figlio di Domenico, probabile tramite tra questi e Patetta) ma la cosa non cambia granché rispetto a nostro tema, cui torniamo immediatamente.
Chiediamo al lettore: nelle 7 sottolineature sopra riportate, è possibile individuare alcunché in base al quale ricavare che secondo Domenico Bulferetti (o chiunque altro) il «Manoscritto Lecco 170» sarebbe stato esemplato tra il 1824 e il 1835?
La risposta è scontata: NULLA.
Qualcuno (tutto autorizza a pensare che sia stato lo stesso Patetta), a due testate giornalistiche (Gazz. Ufficiale / L’Ausonio) e al titolo di una composizione (Lettera sul Romanticismo) ha posto una sottolineatura, come usava (e usa) nei manoscritti per indicarne la lettura come corsivi.
Qualcuno (lo stesso Patetta, Bulferetti, un qualsiasi signor X) ha poi sottolineato “nel 1871” / “1846” / “arciduca Ranieri” / “1835”.
E allora?
Da quando una banalissima sottolineatura con un banalissimo lapis ha assunto il valore di un intero discorso storico-critico di sicura rilevanza?
È questa la nuova frontiera della rinnovata filologia d’autore caldeggiata da Paola Italia e sodali?
Siamo un poco seri, signori dell’Accademia!
E passiamo quindi al “frontespizio”.
5.3/ «Sopra la prima composizione rifatta con molte variazioni».
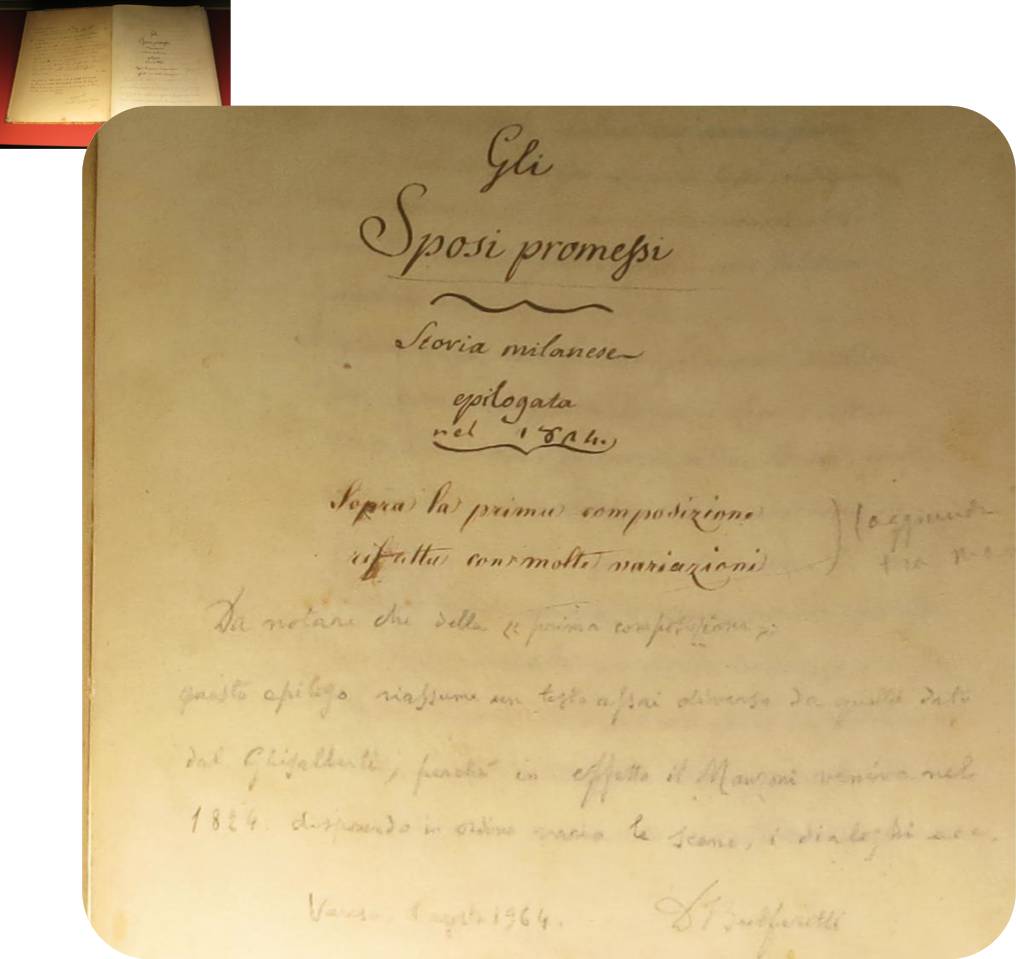
Per chiarezza del lettore, riportiamo il commento di Bulferetti alle due righe «Sopra la prima composizione con molte variazioni» che chiudono titolo e sottotitoli del frontespizio:
«(aggiunta d’altra mano) Da notare che della “prima composizione” questo epilogo riassume un testo assai diverso da quello dato dal Ghisalberti, perché in effetto il Manzoni veniva nel 1824 disponendo in ordine vario le scene, i dialoghi, ecc.
Varese, 1 agosto 1964 | D. Bulferetti»
Queste parole vengono da Paola Italia citate come se con esse Bulferetti si fosse limitato a indicare la data dopo la quale sarebbe stato approntato il «Manoscritto Lecco 170», ossia dopo il 1824.
Il “dopo cui”, in questo caso è ovviamente in sé irrilevante.
Ciò che in questo caso conta è la data “entro cui” sarebbe stato approntato il documento, ossia se quelle 116 pagine manoscritte sono una risibile patacca confezionata magari a metà ’900 e non — come sostenuto da Paola Italia e compagni — entro il 1835.
Sta però di fatto che, con il collegare le parole di Bulferetti alla questione della data, Paola Italia ne ha sterilizzato il senso più interessante (non importa qui se con intenzione o meno).
Il commento di Bulferetti, infatti, è una sconfessione in piena regola dell’assunto base di Paola Italia e sodali, secondo cui l’Epilogo “Gli Sposi promessi” sarebbe un riassunto fedele della “Prima Minuta”, per come era PRIMA che Manzoni ci mettesse le mani per arrivare al testo de “I Promessi Sposi” del 1827.
Bulferetti scrive chiaro e tondo: attenzione! quell’epilogo è stato pensato e composto sul testo della “prima composizione” di Manzoni (quella che conosciamo da oltre un secolo attraverso Lesca, Ghisalberti, Nigro e la stessa Paola Italia) DOPO che Manzoni stesso vi aveva messo le mani, apportandovi molte varianti, a partire dal 1824.
È del tutto chiaro che, anche da solo, quel commento di Bulferetti è sufficiente a destinare al macero tutta l’operazione messa in piedi attorno al quel documento conservato a Lecco (e non è certo un caso che su quel commento non si sia fatta alcuna osservazione da parte degli attuali critici “rivoluzionari”).
Da parte nostra, segnaliamo che l’osservazione di Bulferetti è corretta ma incompleta.
Se Bulferetti fosse andato più in fondo nel suo ragionamento, si sarebbe facilmente accorto come l’Epilogo “Gli Sposi promessi”, non solo non è stato esemplato sulla “prima composizione” di Manzoni, ancora intonsa, ma non ha — in molti elementi narrativi — nulla a che vedere con nessunissima opera di Manzoni (ma di questo ci occupiamo a fondo più avanti in questa Nota).
5.4/ In realtà è la Prof. Paola Italia a caldeggiare l’idea che il «Manoscritto Lecco 170» sia stato realizzato tra il 1824 e il 1835.
Secondo Paola Italia il “prima di” (l’ante quem) della realizzazione del «Manoscritto Lecco 170» è da collocare nel 1835, in funzione del suo supporto cartaceo.
Anche se ha avuto la prudenza di non dirlo in chiaro, il ragionamento di Paola Italia (tutto suo, ancorché messo in bocca a Bulferetti) è questo:
… siccome il “Manoscritto” è su carta filigranata con le iniziali di Francesco I d’Austria …
… siccome questo augusto signore morì il 2 marzo 1835 … allora …
… allora il “Manoscritto” non può essere stato realizzato se non entro il 2 marzo 1835.
Quindi, secondo Paola Italia, con la morte dell’Imperatore Francesco I sarebbero come per magia spariti dalla circolazione tutti i fogli con le sue iniziali in filigrana!
Formidabile!
Ci voleva proprio un Ordinario di Filologia di chiara fama per una deduzione così brillante!
Parlando seriamente, è ovvio che, alla morte di Francesco I, sarà stata interrotta la produzione dei fogli filigranati con le sue iniziali e avviata la produzione di altri fogli con altre filigrane.
Altrettanto ovviamente, più o meno da quel momento, gli uffici governativi avranno utilizzato i fogli di nuova produzione.
Ma le migliaia di fogli messi in circolazione prima della morte dell’augusto sovrano non sono stati certo portati in discarica, pena la fustigazione in piazza — non era certo carta valuta: quantomeno per gli usi privati saranno stati utilizzati fino al loro esaurimento.
O tenuti da parte, con cura e per ogni evenienza, da contabili, amministratori, nostalgici fedeli al ricordo dell’Imperatore, ecc. ecc.
E naturalmente da comunicatori di vario ordine e grado, tra cui onestissimi signori con progetti vari di comunicazione e — altrettanto naturalmente — da disonestissimi falsari, truffatori, ecc. ecc.
Non è difficile né pensarlo né comprenderlo!
Ricordi inoltre il lettore che l’intero «Manoscritto Lecco 170» di 116 pagine è composto da soli 29 fogli: 29 … non 29.000!
Per l’intera operazione era quindi sufficiente una modestissima scorta di fogli con l’effige del defunto Imperatore, un piccolo avanzo di risma.
Comunque sia, libera Paola Italia di esprimere suoi pareri su qualunque materia (ci mancherebbe!) — ma senza alcun diritto di attribuire a terzi (nel caso in questione, al buon Domenico Bulferetti, non in grado di risponderle per le rime) conclusioni storico-critiche senza fondamento.
6. La perizia a “occhio”.
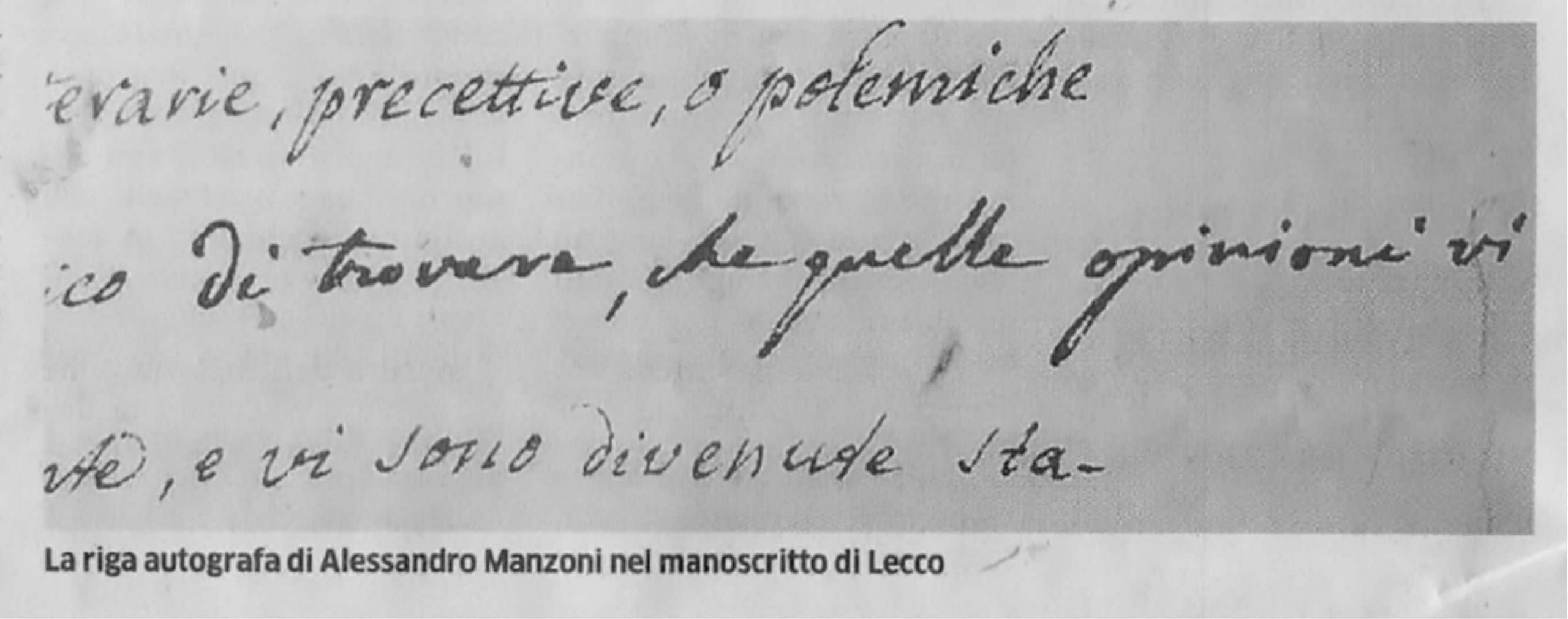
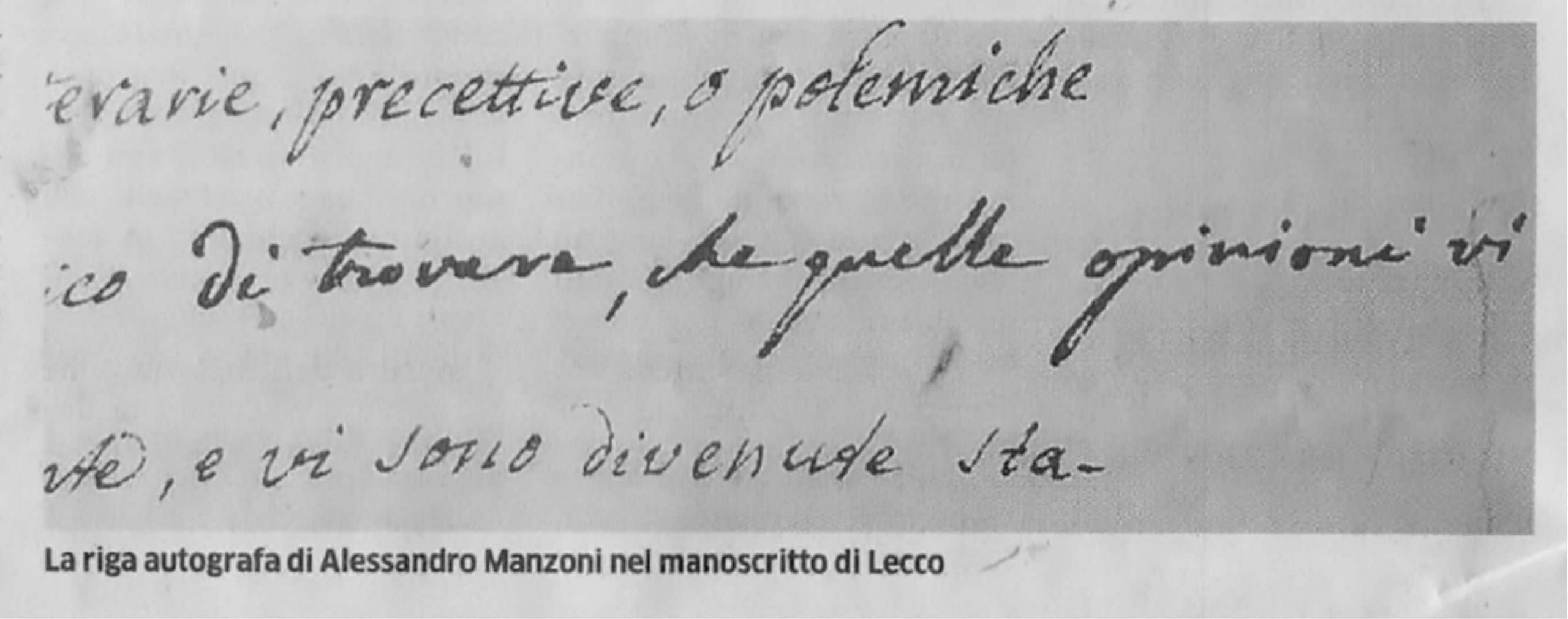
6.1/ Quella righetta di sei parole non è di mano del Manzoni!
Come si vede dall’immagine sopra riportata (è tratta dall’articolo del 5 maggio 2021, dedicato da “La Provincia di Lecco” al «Manoscritto Lecco 170»), la frasetta di sei parole tracciata da mano ignota sulla carta 47r, è presentata come autografa di Manzoni senza se e senza ma.
Il giornale e il giornalista non ne hanno una gran colpa: hanno riferito quanto ha reso pubblico una figura con un ruolo anche formale come la Professoressa Paola Italia, ordinaria di Filologia presso l’Università di Bologna — più di così!
Avrebbero però potuto farsi qualche domandina: è normale che una attribuzione così importante per la nostra cultura venga data esclusivamente “a occhio”?
Il giornale e il giornalista avrebbero potuto considerare che ogni anno in Italia vengono discussi a livello giudiziario oltre 500.000 casi di falsificazione di firme su assegni — solo un segmento dell’universo delle falsificazioni olografe nel quale sono altrettanto bene rappresentati: contraffazione di cambiali, alterazione e falsificazione di firma su lettera o documento, falsa prescrizione medica, modifica di documenti contrattuali, ecc. ecc., basati proprio sulla impossibilità di distinguere “a occhio” questa o quella grafia.
Non a caso, a fronte della troppo bassa attendibilità dei risultati, da oltre 20 anni i Tribunali italiani hanno deciso di non ricorrere più alla tradizionale “perizia calligrafica” basata sulla comparazione puramente esteriore delle grafie (quella, per intenderci, che possono fare esperti di calligrafia per l’appunto, o persone abituate a leggere testi manoscritti, come — per esempio — la Professoressa Paola Italia).
I Tribunali hanno invece deciso di avvalersi di altri criteri di analisi, che utilizzano mezzi e parametri del tutto al di là della capacità dell’occhio umano di “riconoscere” questa o quella grafia.
Gli strumenti utilizzati per questo tipo di analisi della scrittura sono microscopi, misuratori di lunghezze ed ampiezze dei caratteri alfabetici, specifici lucidi a trasparenza per l’esatto calcolo degli indici grafici al decimo di millimetro, apparecchi scanner per la valutazione delle immagini digitalizzate e programmi ad hoc per la messa a confronto degli elementi utili all’individuazione di caratteristiche dominanti (o di eventuali significative contraddizioni) all’interno della scrittura studiata.
Questo approccio al problema ha nettamente migliorato la qualità delle analisi grafologiche forensi, assicurando una attendibilità non assoluta ma vicina al 95% — per un certo tipo di indagine abbastanza accettabile.
Proprio al contrario della Prof. Italia, noi riteniamo che quella frase non sia affatto da attribuire alla mano di Manzoni, per tutta quella ampia e variegata serie di motivi critico-storici che vengono presentati nel corso di questa Nota.
Ne siamo stati così certi fin da subito da esserci assunti l’onere di richiedere una perizia grafologica a una nota e stimatissima “Grafologa Forense in Analisi e Comparazione della Grafia Certificata AICQ-SICEV” perita del Tribunale di Mantova — la dottoressa Marialuisa Iarussi — il cui “Parere pro Veritate” proponiamo poco più sotto — ringraziandola pubblicamente anche per la liberalità con cui, per amore della cultura, ha voluto venire incontro alle modeste risorse del nostro Centro Studi.
Invitiamo quindi il lettore a leggersi con attenzione quel “Parere pro Veritate” della Dottoressa Iarussi la cui conclusione è che “appare poco probabile che quella frase sia autografa di Manzoni”.
Espressa nel linguaggio necessariamente non dogmatico e definitorio degli scienziati seri, quella conclusione dice che la frasetta «di trovare, che quelle opinioni vi» non è di mano di Manzoni.
Suggeriamo però al lettore di leggere quella perizia tecnica da noi commissionata, dopo avere preso visione del come i sostenitori della autografia manzoniana — la professoressa Paola Italia e il suo gruppo di sodali — hanno presentato al pubblico la loro convinzione.
6.2 / In via preliminare dobbiamo porci la domanda: è così immediatamente riconoscibile la grafia del Manzoni?
Risposta: mica tanto: al Museo Manzoniano di Lecco non ci ha pensato proprio nessuno per 30 anni.
E la specialista dei manoscritti di Manzoni, Paola Italia, ce ne ha messi quasi tre.
Perché il lettore possa farsi un’idea basata su dati della realtà e non su fantasie più o meno dilettevoli, è necessario che conosca un poco la storia della “scoperta” della professoressa Paola Italia, i cui primi passi sono stati mossi all’inizio del 2017.
Ne abbiamo una chiara consapevolezza perché nel febbraio di quell’anno avevamo proposto noi al Dottor Rossetto (Direttore del Museo Manzoniano) di studiare insieme il «Manoscritto Lecco 170», ricevendone un cordiale perché no? non seguito da alcunché.
Ce ne siamo resi conto dopo, ma l’amico Rossetto, forse stimolato dalla nostra proposta, si era rivolto altrove.
6.3/ L’ottobre manzoniano del 2017: tra le più allettanti “novità”, il manoscritto “Gli Sposi promessi”.
Tra le iniziative più evidenziate dell’Ottobre manzoniano del 2017 a Lecco, deve infatti ricordarsi una conferenza pubblica che si tenne a Palazzo della Paure giovedì 19 ottobre 2017, relatrice Professoressa Paola Italia, con la presenza anche del Prof. Angelo Stella (Presidente del Centro Nazionale Studi Manzoniani).
Oggetto della conferenza il «Manoscritto Lecco 170», presentato come “misterioso” e “affascinante”: dopo 30 anni di polvere e indifferenza il brutto anatroccolo aveva cominciato a trasfigurarsi in cigno, incantevole — ma non ancora dichiarato specie protetta da Manzoni.
Ricordiamo bene quel 19 ottobre 2017, perché alle 20:30, ora prevista per l’inizio conferenza, due membri della nostra redazione erano presenti a Palazzo delle Paure, perfettamente puntuali.
Aspetta, aspetta … alle 21:15 eravamo in 4 spettatori (sì, quattro! noi due della redazione + una coppia di maturi appassionati di Manzoni), esattamente quanti erano i presentatori e relatori.
Comunque sia, la conferenza ebbe finalmente inizio e venne condotta con competenza da Paola Italia che sviscerò l’analisi da lei fatta del manoscritto sul piano linguistico.
Possiamo assicurare che in quella occasione Paola Italia non parlò neppure di sfuggita di una qualsivoglia riga autografa di Manzoni presente nel manoscritto.
Comunque, da parte di nessuno dei media locali — e comunque da nessuno, in nessun modo — venne data alcuna notizia a commento di quella conferenza dei quattro gatti.
Come già anticipato, qualche mese dopo, ai primi del 2018, Paola Italia pubblicò su Annali Manzoniani il primo studio titolato “Gli Sposi promessi — Storia milanese epilogata nel 1824”.
Nello studio di Paola Italia non si fa alcun riferimento a una qualsivoglia frase autografa di Manzoni.
Non ci risulta che la pubblicazione sia stata in alcun modo ripresa da alcun organo di stampa. Sicuramente non dal Comune di Lecco o dal Sistema Urbano Museale della città.
Dobbiamo presumere che Paola Italia, nel preparare la sua conferenza del 17 ottobre 2017 e nel pubblicarne il relativo studio ai primi del 2018, abbia compulsato con attenzione tutto il manoscritto che consta di 116 pagine scritte con grafie molto ben leggibili: tempo di lettura — anche molto, molto attenta — 80 minuti al massimo.
Domandina: dal momento che (secondo quanto più volte dichiarato da Paola Italia in pubbliche occasioni) la grafia di Manzoni è facilmente riconoscibile da chiunque abbia lavorato sui suoi manoscritti, come mai la Professoressa non ha immediatamente collegato a Manzoni la frasetta «di trovare, che quelle opinioni vi», tra l’altro molto evidente nella carta 47r del «Manoscritto Lecco 170»?
Era distratta? mentre leggeva quel riassuntino relativo al romanzo, di cui lei stessa si è occupata a tempo pieno per sei anni; mentre leggeva copia della famosissima lettera sul romanticismo di Don Lisander al d’Azeglio, la Prof. non pensava a Manzoni?
La domanda, non capziosa ma del tutto legittima, avrebbe potuto esserle rivolta ai primi di maggio 2021 da un qualsiasi giornalista con un minimo di curiosità.
6.4/ Una edificante storia lariana.
La Professoressa Italia, rendendosene forse conto, nel presentare lo scorso 5 maggio la sua “scoperta” circa l’autografia manzoniana sul «Manoscritto Lecco 170» ha pensato bene di risparmiare ai giornalisti la fatica del porre domande fornendo loro una intrigante narrazione, riportata dal già citato articolo de “La Provincia di Lecco” del 5 maggio 2021.
Questo l’inizio di uno dei tre articoli di Bonini dedicati alla presentazione della “scoperta” (evidenziazioni nostre):
«Paola Italia, docente del dipartimento di Filologia classica dell’Università di Bologna ricorda bene l’estate del 2019 quando, costretta a ritornare a Lecco per una pagina mancante tra le copie digitali del manoscritto, ha scoperto qualcosa che non si attendeva di trovare.
“Avevo lavorato per sei anni sulle riscritture di Manzoni, ci passavo intere giornate e la sua grafia la conosco meglio della mia. Per noi filologi è come ritrovare un volto noto. Quella riga autografa sta proprio nel cuore della seconda parte del manoscritto lecchese, la copia della lettera a D’Azeglio”.
Da quel momento Paola Italia avvia un percorso deduttivo degno di un detective. […]»
Rileggiamo l’avvio della frase:
«Paola Italia ricorda bene l’estate del 2019 quando, costretta a ritornare a Lecco per una pagina mancante tra le copie digitali del manoscritto, ha scoperto qualcosa che non si attendeva di trovare.»
Cosa ne recepisce il lettore?
Inevitabilmente che Paola Italia, nell’estate del 2019 (ci sembra 27 mesi dopo avere cominciato a “studiare” il manoscritto in questione) si è improvvisamente accorta di non avere mai avuto la copia digitale di una delle sue 116 pagine (per pura combinazione, proprio quella dove poi troverà la frase da lei attribuita alla mano di Manzoni!).
La Professoressa si precipita a Lecco, trova la pagina mai avuta: in essa riconosce immediatamente la a lei ben nota e inconfondibile grafia di Manzoni!
Ecco svelato al pubblico, attonito ma commosso per la serena conclusione, il percorso di una “scoperta” di grande rilievo critico a partire da una pagina mai avuta/vista ma poi, nella estiva calura lariana, felicemente trovata, sotto lo sguardo benevolo che un grande romanziere può accordare a una sua studiosa, più giovane di duecento anni ma anch’essa ben dotata per l’affabulazione.
La risposta data da Paola Italia attraverso le pagine de “La Provincia di Lecco” del 6 maggio 2021 è infatti da grande romanzo: non ho riconosciuto prima la grafia di Manzoni semplicemente perché mi mancava quella pagina!
Questo siparietto è interessante anche per altri aspetti.
6.5/ Una vicenda piena di misteri.
Primo — Se Paola Italia si è accorta dopo 27 mesi che le mancava la copia digitale di una pagina, perché ha dovuto andare a Lecco per averla? non poteva più comodamente farsela mandare via e-mail dal Direttore del Museo Manzoniano, Dottor Mauro Rossetto?
Oppure si vuole dire che quella pagina non era mai stata fotografata?
Che quindi quella carta 47r è stata fotografata solo nel luglio 2019 a seguito della segnalazione della professoressa Italia?
È così?
Secondo — Sempre il 5 maggio 2021, in un altro articolo di Bonini, riportando un duetto Paola Italia / Simona Piazza (Assessora alla Cultura del Comune di Lecco), si scrive che il manoscritto è stato analizzato con le apparecchiature del Framelab di Ravenna dell’Università degli Studi di Bologna:
«A risultare decisivo sul metodo di lavoro del team di Paola Italia sul manoscritto (un metodo che necessitava di risposte certe sulle varie riscritture, sugli inchiostri e sulle calligrafie) è stato infatti il trattamento di imaging post produzione orchestrato grazie al Framelab di Ravenna.
Il software in questione ha di fatto separato le varie riscritture, recuperando quella che può definirsi come la stratigrafia del manoscritto. Ecco allora che le pagine diventano oggetti a tre dimensioni, comprendendo a pieno anche la sedimentazione delle correzioni nel tempo.
«Era necessario — chiarisce Paola Italia — vedere gli elementi di questo manoscritto per quello che sono, le diverse penne che sono intervenute, le tracce di pecette, ossia delle piccole strisce di carta incollati per riscrivere una parola o una frase».
Ma allora, secondo quanto dice la stessa Italia, dal Framelab di Ravenna è stato analizzato l’intero manoscritto originale.
Sicuramente quindi anche la pagina 47r, perfetto campione per lo sviluppo delle indagini futuristiche del Framelab di Ravenna.
La pagina 47r riporta infatti sia la frasetta da Italia attribuita a Manzoni sia (tre righe più sotto) una di quelle pecette ricordate dalla Prof. (“paradossaj”, ricordata alla nota 31, p.186, del suo studio del 2019).
Quindi Paola Italia, grazie alle apparecchiature del Framelab, ha un’idea abbastanza precisa anche dei rapporti temporali che intercorrono tra le varie parti del «Manoscritto Lecco 170».
Ed è certo in grado di dirci se la frasetta attribuita a Manzoni è stata apposta prima o dopo — e di quanto — rispetto alle già ricordate “pecette”.
E lo stesso può certo dirci per quei numeri di pagina, cancellati e poi diversamente sovrascritti, di cui abbiamo detto più sopra.
Ma questa analisi del Framelab quando è stata condotta?
Prima o dopo che la Professoressa Paola Italia si accorgesse mancarle l’immagine digitale della pagina 47r dove compare la frase di sei parole da lei detta autografa di Manzoni?
Con quali procedure e per rispondere a quali domande? Quali sono i risultati di questa analisi?
Immaginiamo che al Framelab di Ravenna non trasferiscano i risultati delle loro affascinanti analisi al bar dell’Università. Ci sarà una relazione scritta e formalmente protocollata su questi risultati, o no?
Sarebbe bello averne copia — quante cose si potrebbero apprendere da quelle pecette, finalmente parlanti nella loro tridimensionalità!
6.6/ E i colleghi accademici, che ne hanno detto?
Terzo — La Prof. Italia, nel suo studio del 2018 (Annali Manzoniani, p. 141, n. 41), ringrazia i colleghi «che hanno letto il manoscritto e sono stati prodighi di consigli e suggerimenti».
Ma a questi colleghi cosa ha dato da leggere la Prof.?
Ha dato loro solo le prime 40 pagine/immagini (20 carte r/v) relative all’Epilogo “Gli Sposi promessi”, oppure ha dato tutte le pagine/immagini del manoscritto in suo possesso?
E se ha dato loro tutto il manoscritto in sue mani, allora ha dato loro non 116 immagini, ma 115, perché 1 immagine (la 47r) non la aveva mai avuta essa stessa e se la era procurata solo nel luglio del 2019, precipitandosi a Lecco, come da lei narrato il 5 maggio 2021.
Ma di questi suoi colleghi, tutti accademici di chiara fama, nessuno nel leggere il manoscritto nel periodo 2017-2018 si era accorto che mancava una pagina?
Nessuno si è accorto che nella numerazione delle preziose carte c’era un buco? (si passava da 46 a 48). Non bisogna avere una docenza in matematica per rilevare un salto di numerazione in quelle carte, su in alto a destra!
E nessuno si è accorto che la carta 46v (quella che precede la 47r) termina con la frase
Ora noi vi abbiamo costretti ad avvertirle; quando non avessimo fatto altro, questo almeno è qualche cosa di nuovo.
che ha un bel punto finale, di chiusura del discorso.
E che invece la pagina 47v (che segue la 47r – la pagina mai vista da Italia e poi da lei felicemente ritrovata nell’estate del 2019) comincia così:
esempj, e prove di queste osservazioni, se non temessi di troppo trattenerla, e se non pensassi, che, quando Ella le creda degne d’esser verificate, troverà nella sua memoria più abbondante e più opportuna materia, ch’io non saprei somministrarlene.
Non bisogna essere accademici con trent’anni di analisi linguistiche alle spalle per comprendere che tra i due testi manca un qualche cosa!
E invece la professoressa Italia se ne è accorta dopo più di due anni di studio su quelle immagini e i suoi colleghi non se ne sono accorti affatto. Veramente curioso!
Ma tutti questi accademici non sono specialisti della lettura e della comprensione dei testi? Non è per questa loro preziosa esperienza e competenza che sono stimati e pagati?
E quando la Professoressa Paola Italia avrebbe consegnato loro la immagine mancante, la famosa carta 47r?
Nella tarda estate del 2019?
E i suoi esimi colleghi, quando hanno ricevuto (presumiamo per e-mail) quella paginetta, che hanno fatto?
Immaginiamo che le abbiano tutti scritto: carissima Paola, ho ricevuto quella pagina mancante; sai che ti dico: appena l’ho guardata, ho capito a colpo d’occhio che lì c’è una frase scritta proprio da Manzoni; te ne sei accorta anche tu?
È così Professoressa?
6.7/ Il contributo del Direttore del Museo Manzoniano di Lecco.
Sembra più che informato di una coralità di perizie favorevoli alla tesi della autografia manzoniana, Mauro Rossetto, Direttore del Museo Manzoniano di Lecco.
Intervistato il 6 maggio 2021 dalla giornalista Barbara Gerosa per TeleUnica Lecco, così si è espresso, anche sulle perizie, il Direttore Rossetto:

«A un certo punto il copista che ha ricopiato tutto si accorge che, avendolo ricopiato da un altro copista, manca una riga e va da Manzoni, probabilmente, e gli chiede: ma cosa c’era scritto?
A questo punto una mano ignota verga questa parte di testo che manca.
Ma è stato ormai di comune, diciamo parere, verificato tra tutti i maggiori studiosi, che questa scrittura possa essere la scrittura autografa di Manzoni dal momento che tutte le perizie ne hanno dato conferma.»
Interessantissimo! Quindi il Direttore del Museo Manzoniano di Lecco ci assicura esservi non una, non due ma “tante” perizie che asseverano essere di Manzoni quella frasetta.
Non vediamo l’ora di poterle consultare e di avere i nomi degli illustri manzonisti che hanno così espresso il loro prezioso parere.
A meno che Mauro Rossetto non sia uomo d’onore come quel suo Maestro di cui si diceva all’inizio.
Tranquillo, Mauro! Scherziamo naturalmente!
6.8/ La “perizia grafica”, che la Professoressa Italia indica essere in sue mani, può essere vista dal pubblico? o è secretata?
Pur confortati dall’autorevole informazione dataci da Rossetto sulla esistenza di “più perizie”, raccolte tra “tutti i maggiori studiosi”, dobbiamo comunque segnalare che la professoressa Paola Italia ha fatto le cose come si deve.
Nel già citato studio “Un nuovo testimone della lettera sul romanticismo” (Annali Manzoniani, 2019, p. 198), Italia scrive:
«[…] si trova una lacuna che viene integrata successivamente con grafia diversa, […] grafia che, sulla base di una perizia grafica, è possibile identificare con quella manzoniana.»
A parte la modesta scientificità di quella qualificazione “grafica” alla perizia, la Professoressa Italia, quindi, è sempre stata d’accordo con noi sulla inconsistenza di una autografia basata sul “riconoscimento” da parte di un frequentatore anche assiduo dei manoscritti manzoniani (come può essere certo considerata essa stessa).
Conseguentemente, per dare forza alle sue valutazioni critiche, ha pensato bene di avere il conforto di una vera “perizia grafica” — è lei stessa che ce lo dice — la quale testimonierebbe l’autografia manzoniana con riconosciute modalità tecnico-scientifiche.
La Prof. — forse per non annoiare i suoi lettori — non ha scritto a chi e quando ha commissionato la perizia, né quando ne ha avuto la conferma dell’autografia manzoniana.
Ma certamente è stato tra la tarda estate del 2019 e il dicembre di quell’anno, quando pubblicò il suo studio.
Ci fa comunque molto piacere sapere che questa “perizia grafica”, segnalataci dalla Professoressa Italia, esiste; che è un documento di tot pagine, firmato dal tale perito, nella tale data.
Così le perizie saranno due: quella commissionata da Paola Italia e quella commissionata dal nostro Centro Studi — oltre naturalmente tutte quelle segnalate dal Direttore Rossetto.
La nostra noi la abbiamo commissionata il 31 agosto 2021 alla dottoressa Marialuisa Iarussi e nella Sezione posta immediatamente qui sotto ne presentiamo i risultati ai lettori.
Ci farà naturalmente molto piacere di conoscere il nome della figura professionale che ha redatto la perizia per conto di Paola Italia e — ancor di più — di poterla compulsare.
Attendiamo con vero interesse indicazioni sul dove e come reperirla — grazie anticipatamente Professoressa!
Anzi! faccia una cortesia a tutti!
Chieda al Comune di Lecco di caricarla sul sito istituzionale del Municipio!
7. La vera perizia grafologica, da noi richiesta.
Il parere del perito Marialuisa Iarussi:
«Riservandomi l’esame dei manoscritti in originale per l’analisi del tratto e della pressione, per tutto quanto precedentemente illustrato, ritengo probabile che la frase oggetto del quesito non sia stata vergata dal noto scrittore Alessandro Manzoni.»
Trasposta nel linguaggio HTLM per la sua più agevole consultazione su Internet, qui sotto, riportiamo la relazione, redatta il 29 settembre 2021 dalla dottoressa Marialuisa Iarussi, perito del Tribunale di Mantova, incaricata dal nostro Centro Studi di verificare se la frase della carta 47r del «Manoscritto Lecco 170» sia o meno da considerare autografa di A. Manzoni.
7.1 / Parere tecnico pro veritate.
Studio di Consulenza Grafologica dott.ssa Marialuisa Iarussi
Grafologa Forense in Analisi e Comparazione della Grafia Certificata AICQ-SICEV
Esperta Forense in Firme Grafometriche certificata AICQ-SICEV
Iscritta agli Albi dei CTU e dei Periti del Tribunale di Mantova
Socio ordinario A.G.I. disciplinata ai sensi della Legge n. 4/2013
Studio in Via Maria Montessori n. 63 – Asola (Mn) – cell. 3357098964
consulenzegrafologiche1@gmail.com – consulenzegrafologiche@pec.it
C.F. RSSMLS66P59A470J – P.I. 02402350207
Parere tecnico pro veritate.
Analisi comparativa su frase manoscritta di sei parole attribuita ad Alessandro Manzoni.
7.2/ Incarico.
In data 31.08.2021 ho ricevuto dal Centro Studi Abate Stoppani di Milano l’incarico di valutare ed esprimere un parere tecnico pro veritate sulla riconducibilità di una frase composta da sei parole e vergata su un manoscritto conservato presso il Museo di Lecco, alla mano dello scrittore Alessandro Manzoni.
Il Presidente del Centro Studi Abate Stoppani Sig. Fabio Stoppani mi ha inviato una fotografia dalla discreta risoluzione della frase da analizzare, denominata [Q] per comodità espositiva.
Per rispondere al quesito ho esaminato le immagini di buona qualità di numerosi manoscritti, appunti e lettere del noto scrittore Alessandro Manzoni, reperite sul sito della Biblioteca Nazionale Braidense www.alessandromanzoni.org/manoscritti.
— «Appunti autografi sulla servitù di casa Manzoni», privi di titolo e data, (Rif. Manz.Ant.IX.B.1.II/4), denominati K1 nel presente elaborato per comodità espositiva;
— «I promessi sposi, nella prima stesura autografa», (Rif. Manz.B.II), vergata dal 24.04.1821 al 17.9.1823, denominata K2;
— «Lettera n. 596» del 20.02.1841 a Giacomo Beccaria (Rif. bibliografico Manz.B.I.12/3), denominata K3;
— «Lettera n. 1472» del 26.05.1868 a Emilio Broglio (Rif. Manz.B.I.16/9), denominata K4;
— «La Rivoluzione Francese del 1789 e la Rivoluzione Italiana del 1859», documento autografo parziale di prima e seconda stesura, datato 1861 – 1867 (Rif. Manz.B.XI.1c), denominato K5.
7.3/ Premessa metodologica.
L’analisi forense di manoscritture è l’esame scientifico volto a determinare se due o più tracciati siano stati redatti dalla stessa mano. Com’è noto, la traccia grafica rappresenta il comportamento neuromuscolare di un soggetto ed è altamente individualizzante.
L’accertamento tecnico si basa sui seguenti postulati, riconosciuti dalla comunità scientifica:
1. non ci sono due persone che scrivono esattamente nell’identica maniera;
.
2. nessuna persona scrive esattamente nello stesso identico modo due volte e due firme vergate con naturalezza non sono mai esattamente identiche e sovrapponibili;
.3. nella comparazione il valore di ciascuna caratteristica grafica, come prova di identità o di non identità, dipende dalla sua frequenza, complessità, velocità relativa e naturalezza;
.
4. nessuno è in grado di imitare i caratteri della scrittura di un’altra persona mantenendo contemporaneamente la stessa velocità relativa e l’abilità grafica di chi sta cercando di imitare;
.
5. nei casi in cui chi scrive dissimula la propria scrittura abituale o imita la scrittura di un’altra persona, non sempre sarà possibile identificarne l’autore.
Uno scritto o una firma variano a seconda della loro complessità e grado di automazione: una maggiore complessità scrittoria, a prescindere dal grado di leggibilità, rende palesemente difficoltosa l’imitazione.
L’autenticità di una scrittura non si evince dalle forme finali che assume il tracciato ma dai movimenti e dal ritmo con cui la grafia è stata realizzata. Non è la singola lettera somigliante o uguale a determinare l’identità di mano, poiché le uguaglianze formali possono essere oggetto d’imitazione, ma tutto un complesso di elementi tecnici che insieme segnalano la tipicità di una scrittura.
Per quanto suggestive possano essere le somiglianze rilevate tra due grafie, esse non sono sufficienti per dimostrare l’identità, occorre altresì che non esistano differenze qualitative o, se esistono, possano essere spiegate con determinate circostanze di fatto.
La forma è l’elemento più facile da imitare; difficile è la riproduzione della direzione, dei rapporti dimensionali, della continuità scrittoria, della pressione, della velocità, del livello grafico e dei dettagli che sfuggono all’osservatore.
Tali elementi sono preponderanti rispetto ai dati morfologici nel bilancio conclusivo a favore dell’autenticità o dell’apocrifia.
Per garantire scientificità all’accertamento l’esperto in analisi e comparazione di scritture attua un approccio sistematico, organizzato in un preciso protocollo: l’analisi e la determinazione degli elementi distintivi delle grafie in verifica e in comparazione, il successivo raffronto e la classificazione oggettiva dei dati tecnici emersi.
Nel caso in esame ho considerato il modello corsivo italiano del 1800, trattandosi di una grafia apparentemente riferita al noto scrittore (n. 07.03.1785 – m. 22.05.1873) e gli strumenti in uso in quel periodo storico.
Non avendo accesso alla verificanda e alle autografe in originale, non ho potuto esaminare e confrontare la pressione e il tratto (2).
Note:
2) La pressione è il solco più o meno premuto lasciato sul foglio dallo strumento scrittorio.
Non va confusa con il tratto, definito come il segmento che forma la lettera o altro segno, quindi la traccia d’inchiostro sul supporto cartaceo.
7.4/ Breve descrizione e analisi della dicitura in verifica.
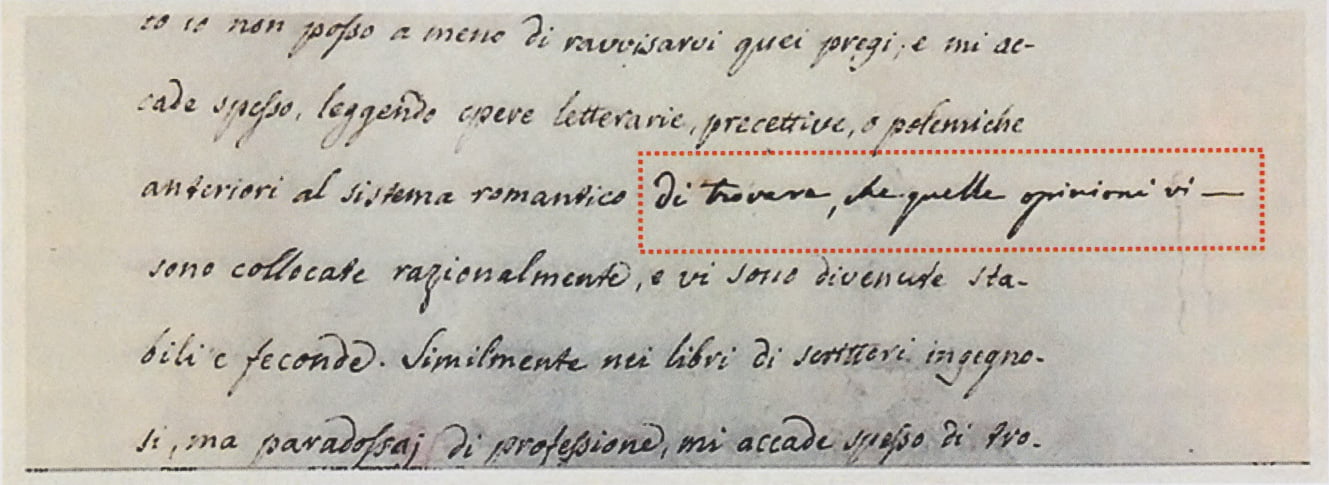
Figura 1: frase in verifica denominata Q, evidenziata in rosso.
[immagine tratta da Annali Manzoniani, II, 2019, p. 285 — ndr]
La frase oggetto del quesito è piccola nel calibro e prolungata in basso (dimensione [3]), aderente all’ipotetica linea di base (direzione [4]), inclinata a destra, con aumento dalla terza parola del grado di inclinazione e con gli assi longitudinali delle lettere “ll” paralleli (inclinazione [5]) e legata con stacchi in “d-i”, “tro-vava” e in “opi-ni-oni” (continuità [6]).
Il bianco tra parole è obliterato dal gramma a fine parola (impostazione [7]).
La forma è semplificata e spoglia. Gli occhielli delle “e” sono ciechi, gli ovali sono anneriti (“a”, “q” e ultima “o”).
La velocità [8] di stesura è posata, il movimento è barré, cioè rigido e controllato e l’inclinazione a destra non è sufficiente per conferire dinamicità al tracciato.
La frase in esame è caratterizzata dai seguenti piccoli segni [9]: la barra della “T” leggermente convessa e il tratto finale ondulato che segue l’ultima lettera.
Il livello grafico è mediamente evoluto.
Note:
3) Dimensione: valuta il corpo centrale di una grafia, privo di aste inferiori e superiori, per stabilire il calibro. Le specie più comuni sono: piccola, molto piccola o micrografia, media, grande, esagerata o molto grande, bassa, stretta, prolungata in alto, prolungata in basso, crescente, decrescente, sobria.
4) Direzione: indica la traiettoria sinistrogira o destrogira del movimento e la tenuta delle righe (rettilinea, ascendente, discendente, concava, convessa, sinuosa, cavalcante e danzante).
5) Inclinazione: piegamento degli assi delle lettere rispetto alla linea di base, tracciata o ipotetica (grafia inclinata, couchèe, verticale, rovesciata, raddrizzata, variabile).
6) Continuità: modalità di collegamento tra le lettere di una parola. La grafia può essere legata, iperlegata, staccata, raggruppata, ritmata, omogenea, fluida, inibita, a diverse andature.
7) Impostazione: indica la distribuzione dello scritto o della firma in una pagina, ordinata, disordinata, rigidamente impostata, tipograficamente impostata, insulare, ariosa, spaziata, bucata, merlata, compatta, intricata, ecc.
8) Velocità: la rapidità o la lentezza del gesto grafico (lenta, posata, accelerata, rapida, movimentata, dinamogenica, precipitata, tumultuosa, calma, lanciata, spontanea, rallentata, trattenuta, risoluta, rilasciata, ineguale).
9) Piccoli segni: particolari grafici vergati involontariamente che sfuggono all’attenzione di chi scrive e di colui che osserva.
7.5/ Breve descrizione e analisi delle manoscritture autografe.
La grafia di Alessandro Manzoni è ben costruita nel corpo centrale e prolungata in alto e in basso (dimensione), inclinata, ordinata, rapida e lanciata (velocità). Il movimento del filo grafico è dinamico.
Le autografe esaminate sono variabili nella direzione sull’ipotetica linea di base (ascendente, concava, rettilinea e morbida), nella continuità grafica (parole legate, raggruppate e staccate) e nella morfografia.
I caratteri sono proteiformi (si osservi ad esempio la “n”, la “t”, la “p”, la “s” e la “g”).
La grafia è ricombinata (forme e legamenti funzionali, agili e ricreati), originale e al contempo mantiene la chiarezza, anche negli scritti vergati di getto.
I grammi finali sono anch’essi caratterizzati da variabilità nella direzione, dimensione e forma (brevi e rettilinei, curvi, ampi e rivolti a destra ma anche a sinistra, in alto e in basso). Le barre delle “t” sono rettilinee, legate basse alla lettera che segue (piccoli segni) e talvolta leggermente concave.
Le manoscritture autografe sono complesse e denotano un livello grafico evoluto.
7.6/ Confronto tra verificanda e comparative.
La frase in verifica e le comparative sono differenti nei dati tecnici di seguito riepilogati.
— Dimensione: la zona media è piccola in Q, media e strutturata nelle Kn. La zona
inferiore è maggiormente prolungata nella frase in verifica rispetto alle autografe.
I rapporti dimensionali sono quindi differenti.
La verificanda è dilatata in orizzontale mentre le autografe sono più compatte (la divergenza è qualitativamente rilevante).
La “d” in verifica ha l’ovale merlato (aperto), nelle comparative è abitualmente chiuso.
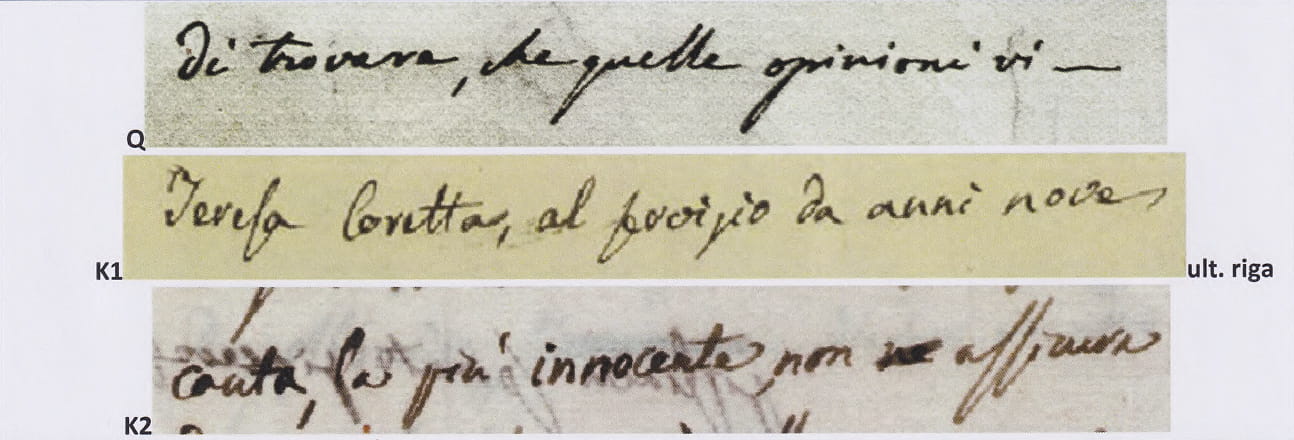
Figura 2: differenza sostanziale nel calibro in zona media, nei rapporti dimensionali e nello sviluppo in orizzontale. Q è “stirata” mentre le K sono compatte e più costruite.
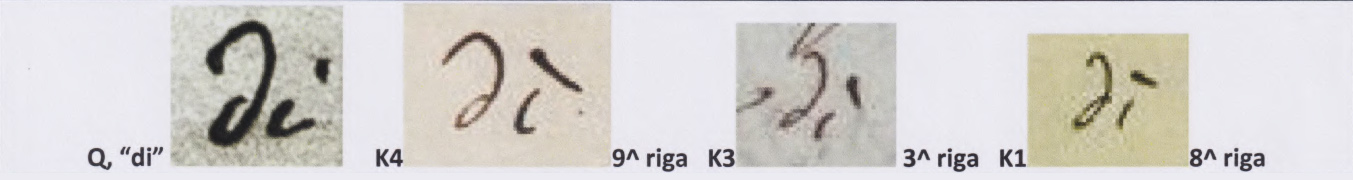
Figura 3: differenza nell’ovale della “d”, merlato in Q, chiuso nelle Kn (dimensione).
— Direzione del grafismo: la frase in esame è rigida e controllata, al contrario, le manoscritture autografe sono caratterizzate da una evidente proiezione verso destra (direzione progressiva), rappresentata in un ampio arco temporale.
— Velocità: Q è posata (lenta per applicazione), le comparative sono rapide e lanciate.
— Movimento: nella verificanda è barrè, al contrario, nelle autografe è dinamico.
— Ritmo: il ritmo grafico in Q è poco evoluto, nelle comparative è vivace e vitale.
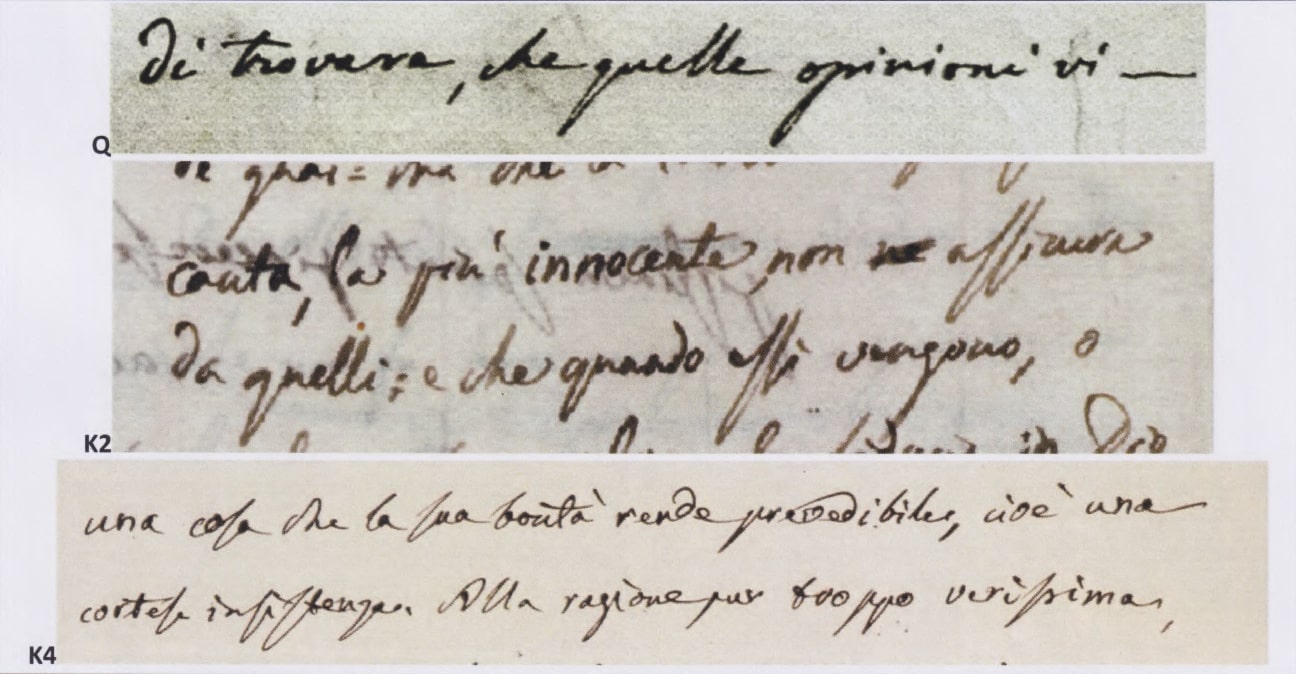
Figura 4: sostanziali differenze nella direzione, nella velocità, nel movimento e nel ritmo.
— Direzione sul rigo: aderente all’ipotetico rigo in Q, più morbida e spesso concava o ascendente nelle comparative.
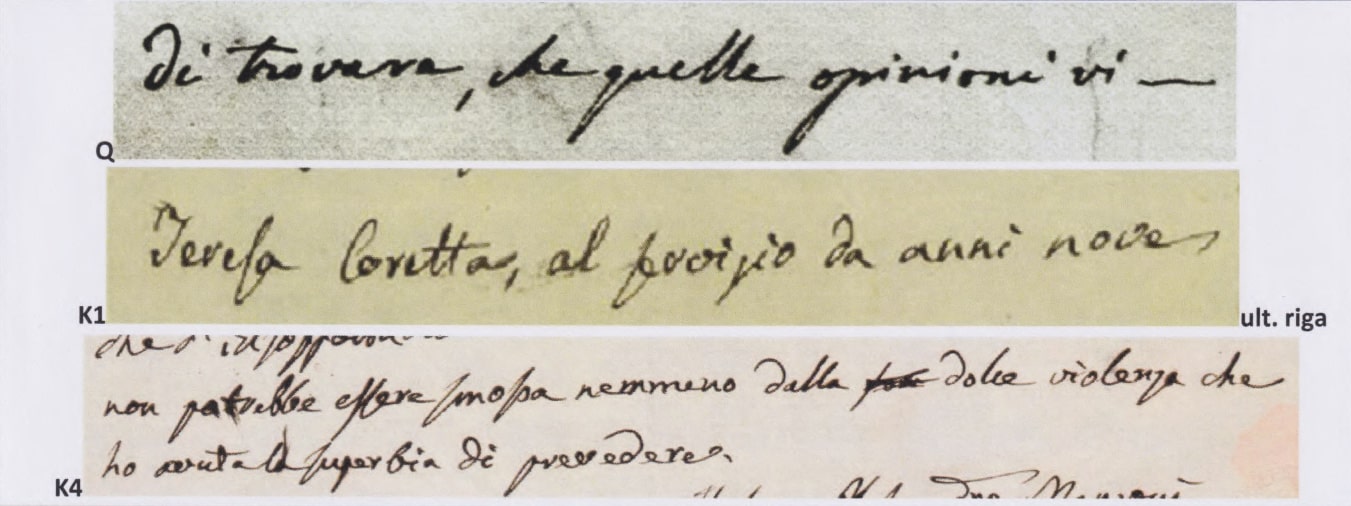
Figura 5: differenza nell’allineamento scritturale, aderente in Q, più morbida, concava e ascendente nelle Kn.
— Forma: Q ha forme semplificate e spoglie, al contrario, le Kn hanno un corpo centrale strutturato e forme ricombinate, originali e variate nei percorsi ideativi.
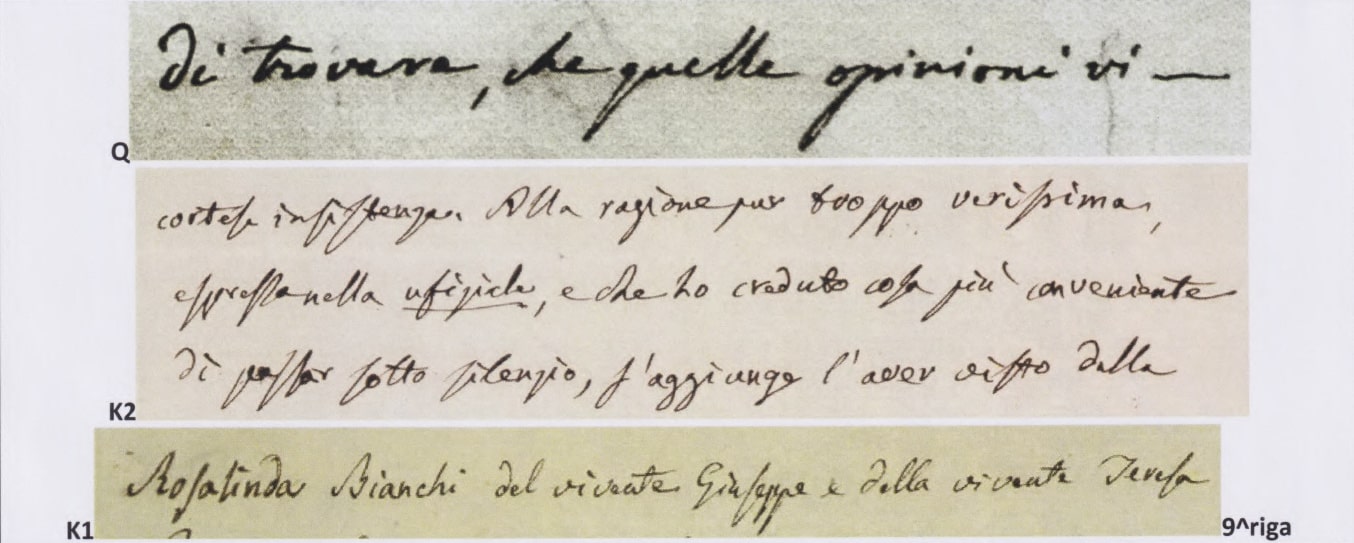
Figura 6: differenze nello stile e nella morfografia, spoglia in Q, ricreata e originale nelle Kn.
— Piccoli segni: le barre delle “t” nei manoscritti del Manzoni sono abitualmente rettilinee o concave, non convesse come in Q.
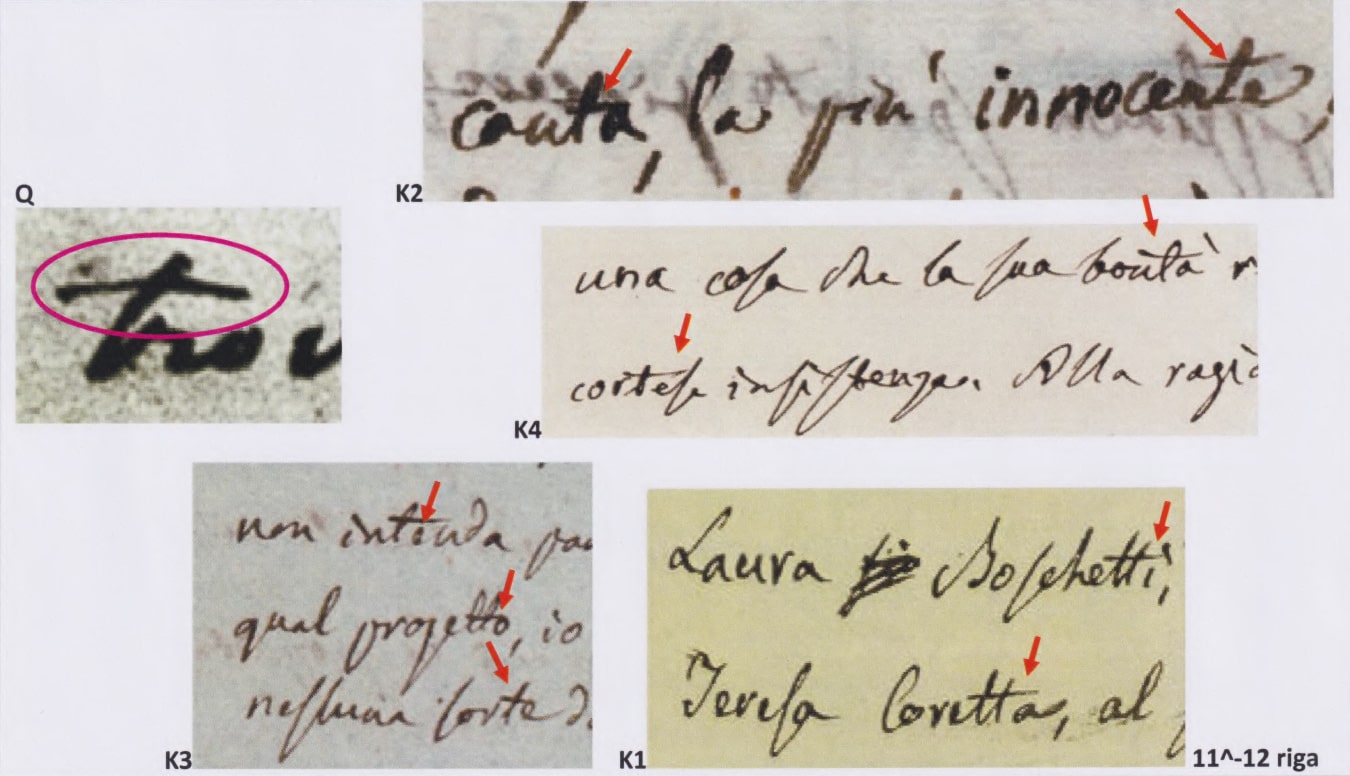
Figura 7: divergenze nella barra della “t”, convessa in Q (ovale fucsia), concava o rettilinea nelle autografe (frecce rosse).
Inoltre, nelle minute e nelle lettere manoscritte non vi sono a fine riga linee ondulate a occupare lo spazio bianco sino al margine destro, simili a quella che conclude la frase in verifica.
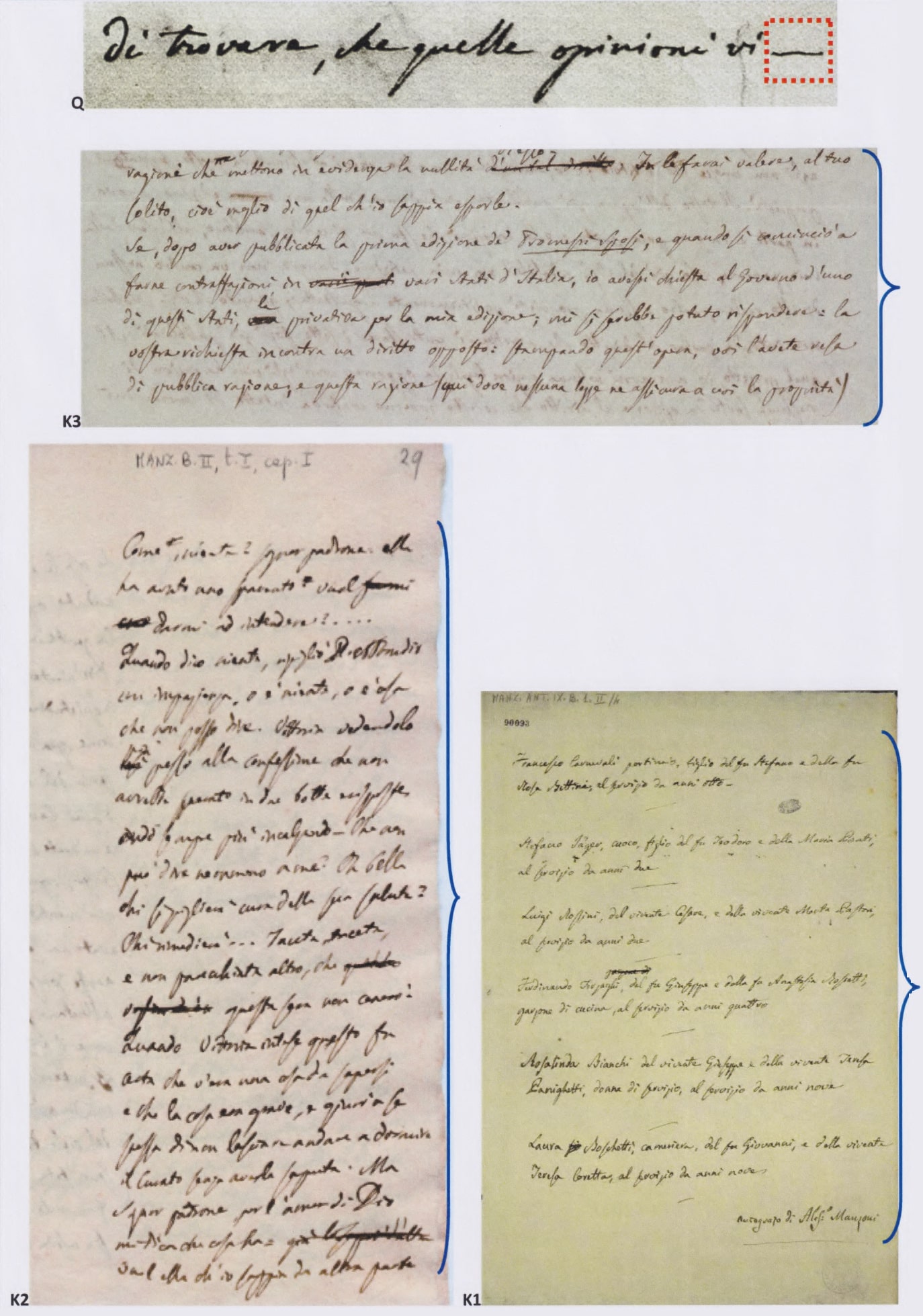
Figura 8: differenza nella linea ondulata a fine frase in Q (riquadro rosso), non rappresentata nelle numerose comparative esaminate.
— Livello grafico: il livello grafico delle autografe è più evoluto (differenza di natura sostanziale) di quello osservato nella frase in verifica.
7.7/ Conclusioni e risposta al quesito.
Nel confronto tra la frase in verifica e le manoscritture autografe sono emerse poche analogie nella forma, nella continuità e nell’inclinazione a destra, quest’ultima conforme al modello corsivo in uso.
Le numerose differenze riscontrate sono qualitativamente rilevanti nel bilancio conclusivo e non sono spiegabili con particolari circostanze di fatto, come ad esempio, la carta, lo strumento scrittorio, l’emozione o l’ambiente circostante.
Q e le Kn denotano inoltre difformità stilistiche e nella forma generale dei grafemi.
Le differenze oggettive nel ritmo, nel movimento, nella velocità e nella direzione tra la frase verificata e i manoscritti del Manzoni fanno ragionevolmente propendere per la diversità di mano.
Il giudizio di apocrifia è confermato altresì dalle discordanze nel calibro, nel livello grafomotorio e nei piccoli segni.
Riservandomi l’esame dei manoscritti in originale per l’analisi del tratto e della pressione, per tutto quanto precedentemente illustrato,
ritengo probabile [10] che la frase oggetto del quesito non sia stata vergata dal noto scrittore Alessandro Manzoni.
Asola – Milano, lì 17.09.2021
Il consulente Tecnico
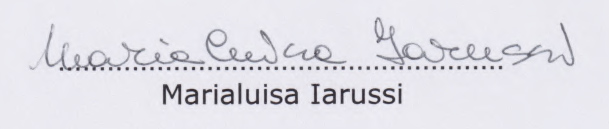
10) Bruno Vettorazzo scrive che “è preferibile esprimere il livello di certezza, positivo o negativo, non in termini percentuali ma secondo una scala ristretta di valori: certezza, alta probabilità, bassa probabilità, possibilità e impossibilità conclusiva” (pag. 137).
Vettorazzo B. – Metodologia della perizia grafica su base grafologica – Milano – Giuffrè 1998.
7.8/ Nostre considerazioni sul “Parere pro Veritate” della dottoressa Marialuisa Iarussi.
Non abbiamo molto da aggiungere a quanto espresso dal perito grafologo dottoressa Iarussi, se non che conferma, sotto un diverso profilo, la convinzione da noi già manifestata circa la non attendibilità di una attribuzione alla mano di Manzoni di quella anodina frasetta alla carta 47r del «Manoscritto Lecco 170».
Naturalmente la valutazione di un esperto non può e non deve essere vista come un assoluto su cui non potere esprimere una diversa posizione.
Rinnoviamo pertanto l’invito alla Professoressa Paola Italia a rendere pubblica la “perizia grafica” da lei asserita essere stata realizzata a convalida della sua tesi secondo cui, invece, quella frasetta deve esser considerata autografa di Manzoni.
Siamo certi che il nostro perito di parte, la dottoressa Iarussi, non si sottrarrà ad alcun tipo di confronto e ne sarà anzi felice.
Va da sé che, per potere aggiungere elementi di certezza a una ulteriore eventuale valutazione, sarà necessario potere avere accesso all’originale del «Manoscritto Lecco 170».
Siamo certi che il Comune di Lecco e il Museo Manzoniano della città sapranno cogliere l’opportunità, offerta da questo confronto, per dare un esempio di come debba essere intesa la ricerca della verità storica (quantomeno quella che è possibile cogliere nel nostro tempo attuale).
La nostra Nota prosegue ora con la sua ultima Sezione, dedicata al tema “Prime minute a confronto”.
8. “prime minute” a confronto.
8.1/ Una solo vantata fedeltà di trama.
Nelle sezioni precedenti abbiamo messo in luce la preoccupante superficialità con cui sono stati affrontati alcuni aspetti relativi al «Manoscritto Lecco 170» e, in particolare, all’Epilogo “Gli Sposi promessi” che ne costituisce la prima sezione:
a/ la disastrosa trascrizione diplomatica del manoscritto stesso ha ridotto Paola Italia a commentare anche sul nulla quando non su dati perfettamente fasulli;
b/ la superficialità dell’analisi del manoscritto con le diverse cecità (per es. sull’alterazione della numerazione delle pagine) mette in non cale le convinzioni espresse dalla studiosa;
c/ la supposta autografia manzoniana della frasetta alla carta 47r, basata su una inevitabilmente risibile perizia “a occhio”, pone evidentemente una serissima ipoteca a tutta la costruzione critica caldeggiata dalla stessa Paola Italia e sodali nell’operazione: appare chiaro a chiunque che se Manzoni non ha mai scritto quelle sei parole su quel fascicoletto è decisamente improbabile che lo abbia visto o ne abbia mai avuto alcun sentore, mentre appare probabilissimo che il fascicoletto stesso sia stato redatto e composto in tutt’altri momenti da quelli ipotizzati — magari più di mezzo secolo dopo la morte di Manzoni.
Ora, in questa ultima sezione, andiamo a verificare — documenti alla mano — se e in che modo l’Epilogo “Gli Sposi promessi” è da considerarsi fedele o meno alla “Prima Minuta”.
Diciamo subito che — comunque — si tratta di una fedeltà alla Don Giovanni, e ciò per due macro-ragioni:
— la prima è che nell’Epilogo è accuratamente ignorata l’intera intelaiatura descrittiva / riflessiva del romanzo, potendovisi rintracciare riferimenti alla sua sola dimensione puramente narrativa;
— la seconda è che gli stessi riferimenti alla sola dimensione banalmente narrativa sono in ben 23 situazioni difformi dalla Prima Minuta.
Diamo subito inoltre alcune altre informazioni:
— CINQUE di queste 23 difformità dalla “Prima Minuta” sono coerenti con le successive stesure del romanzo (“Seconda Minuta”, “I Promessi Sposi” editi nel 1827): come noto Manzoni apportò numerose varianti tra la “Prima Minuta” — da lui mai resa pubblica — e la elaborazione data alle stampe nel 1825-27);
— DICIOTTO sono invece, per così dire, “originali” e non trovano riscontro in documenti di mano manzoniana.
Di queste diciotto soluzioni “originali”, quattro non hanno alcun riscontro con il mondo manzoniano ma — cosa veramente curiosa — sono coerenti con la riduzione che del romanzo di Manzoni fece il regista Mario Camerini nel suo film “I Promessi Sposi” del 1941.
Sì! avete letto bene! Non è una nostra battuta: leggere e guardare per credere!
Per avvalorare la nostra tesi, ci rifacciamo ai testi:
— della “Prima Minuta”, nel 2006 pubblicata con il titolo “Fermo e Lucia”, grazie al lavoro anche di due ben note e stimate filologhe manzoniste: la stessa Paola Italia e Giulia Raboni;
— della “Seconda Minuta”, nel 2012 pubblicata anche con il sostanziale contributo di Giulia Raboni, che condivide in toto le tesi di Paola Italia in merito al «Manoscritto Lecco 170».
Nel seguire questa ultima parte della nostra esposizione — in verità il suo nucleo meno immediatamente evidente — chiediamo al lettore di considerare con una certa attenzione alcuni capitoletti introduttivi con i quali tocchiamo questioni di metodo (non irrilevanti ai fini di una corretta comprensione del nostro percorso espositivo) o diamo informazioni di carattere critico storico, forse non perfettamente presenti a molti lettori.
8.2 / “Compendio” di Paola Italia versus “epilogo” del Manoscritto.
A proposito della definizione di cosa siano le prime 40 pagine del «Manoscritto Lecco 170», Paola Italia compie una curiosa operazione.
In prima pagina il «Manoscritto Lecco 170» reca come sottotitolo “Storia milanese epilogata”.
Viene cioè indicato con precisione ciò che il suo estensore aveva inteso proporre al lettore: un “epilogo”.
Ostentatamente, invece, nei suoi due studi sul manoscritto, Paola Italia non usa mai il termine “epilogo”.
Per quasi trenta volte, e nelle sue varie declinazioni, la Prof. utilizza invece il termine “Compendio” (con la “C” maiuscola), senza motivare il perché di questa scelta, annichilente del dato di fatto documentale.
In modo inconfutabile, infatti, “compendio” ed “epilogo” non sono per nulla sinonimi.
8.3/ “Epilogo”.
Il termine “epilogo” ha assunto nel tempo diversi significati ma sempre coerenti con la sua etimologia.
Per rimanere nell’ambito temporale di Manzoni, vediamone una definizione di Nicolò Tommaseo:
«[T.] S. m. Dal gr. ̓Επὶ, Λέγω; aveva senso più generale ai Latini che a noi; e a’ Greci, ancora più generale. Il verbo valeva e Dir poi, e Dire di più; Scegliere, e Ripensare, e Computare, e Imputare; Epilogo valeva anco Rassegna.
Cicerone gli dá il senso di perorazione da muovere gli affetti.
A noi è il Raccogliere, alla fine d’un discorso o d’una parte di quello, i fatti e le prove, facendone rassegna, ma con iscelta e ragionamento, secondo l’origine greca».
Epilogo può indicare anche la conclusione di un discorso, di uno scritto, di una rappresentazione teatrale, ecc. ecc., come ricorda ancora Tommaseo:
«3. T. Nel teatro antico, Epilogo, Le parole dell’autore agli spettatori nella fine del dramma comico o tragico. Gl’Inglesi l’usano tuttavia.»
In questa ultima accezione, con l’epilogo l’autore o:
— tira le conclusioni “morali” dell’opera (al caso, difendendola in anticipo dalle critiche), oppure …
— si congeda dal pubblico con battute spiritose.
Su questa traccia, ma in altro contesto, ancora Tommaseo:
« L’Amen, o Così sia è conclusione delle cristiane preghiere; conclusione che le epiloga in una, e dá loro il suggello della ferma speranza.»
Riassumendo: per i classici, e anche oggi, “epilogo” non è mai il mero “riassunto” di un testo ma se ne può discostare in funzione deliberatamente orientativa se non anche suggestiva.
Come vedremo meglio più avanti, l’Epilogo” proposto nel «Manoscritto Lecco 170» è proprio tutto tranne che un “epilogo” nelle accezioni sopra indicate.
Per il momento ci limitiamo a segnalare che il suo estensore ha comunque scelto di utilizzare questo termine a indicare il suo lavoro e che, sul piano dell’analisi critica, non è molto sensato cambiare la carte in tavola come ha fatto, influendo sui suoi lettori in modo inevitabilmente suggestivo, la Professoressa Paola Italia.
8.4/ “Compendio”.
Ha invece tutto un altro significato, come bene in evidenza nella sua etimologia, per esempio, ancora da Tommaseo:
«[T.] S. m. Discorso che raccoglie in poco il valore intrinseco di discorso più lungo. L’aureo lat., per l’orig. Pendo, aveva senso più gen. Guadagno di risparmii: e l’uso trasl., che notiamo per primo, ha ragione in questo, che il risparmio di parole e di tempo è de’ più veri guadagni. […]
T. Fare, Scrivere, Stampare un Compendio. Potrebbe anco dirsi Comporlo; ed è tra le composizioni più difficili e più proficue se buono.»
e quindi:
«Compendio delle Regole de’ Triangoli, con le loro dimostrazioni. Bologna, Monti, 1638, in-12°.»
e ancora:
«Compendio d’un Trattato elementare di Chimica, di Giuseppe Gazzeri. Firenze, Piatti, 1833, vol. 2, in-8°.»
Non c’è bisogno di aggiungere altro: “compendio“, oggi come per i nostri bisnonni, esprime la esposizione fedele, e possibilmente di buon livello, di un’opera, ma in forma abbreviata.
Chi compendia può eventualmente sfrondare l’originale da esempi, ecc. ma preservandone fedelmente la struttura.
Il “compendio” cioè né toglie alcunché di strutturale al testo di riferimento né aggiunge alcunché di nuovo — a netta differenza dall’ “epilogo” che invece elabora l’originale e ne suggerisce anche altro, lì non indicato.
Tornando a noi, in sede di riflessione critica potremmo naturalmente considerare se la nostra “storia milanese”, conservata a Lecco, è effettivamente “epilogata”, come dichiarato dal suo autore, oppure “compendiata”, come imposto da Paola Italia.
Vedremo più sotto come questo “coso” non è né un “epilogo” né tanto meno un “compendio”.
Non è epilogo perché privo di una qualsivoglia riflessione o “morale” o suggestione o qualsiasi altra cosa vi venga in mente come “altro dal discorso”, come indica il suo nome.
Non è “compendio” perché della “Prima Minuta” di Manzoni tiene — e quanto malamente e parzialmente! — solo ed esclusivamente alcuni elementi della traccia narrativa, censurando TUTTE le parti del romanzo nelle quali l’autore volle trasmettere al lettore la propria visione del mondo, delle relazioni sociali e umane, delle motivazioni dell’agire umano sia alla scala collettiva che individuale.
Quelle parti cioè che costituiscono la ragion d’essere di qualsiasi composizione artistica e culturale.
Sotto questo profilo l’Epilogo del «Manoscritto Lecco 170» potrebbe essere considerato un promemoria, una scaletta, stesa per chissà quale occasione.
Tutt’al più potrebbe essere paragonato a quei sommarietti dei vari capitoli che (anche nell’Ottocento) venivano posti a inizio volume per attrarne il potenziale acquirente.
Ma passiamo a un altro tema.
8.5/ Più di un secolo di “Prima Minuta” e dintorni: 1905-2012.
Perché il lettore possa ritrovarsi nelle molte citazioni di “prima minuta”, “seconda minuta”, “Fermo e Lucia”, “Sposi promessi”, “I Promessi Sposi”, che seguiranno in questa nostra Nota, è opportuno fare un breve riepilogo delle tappe attraverso cui la critica ha analizzato genesi e scrittura del romanzo di Manzoni in oltre un secolo di studi.
Come noto, la “Prima Minuta” del romanzo di Manzoni, dal medesimo non venne mai né titolata, né resa pubblica, né tanto meno stampata: nel suo ambito a essa si faceva riferimento semplicemente come “prima minuta” o “prima stesura”.
Le carte manoscritte lungo le quali si dipanò la complessa stesura del romanzo rimasero fino alla morte di Manzoni nella sua esclusiva disponibilità, viste e lette solo da un ristrettissimo gruppo di parenti e amici/ collaboratori dello scrittore.
Alla morte di Manzoni (maggio 1873), ordinate da Giovanni Rizzi, Natale Ceroli e Visconti Venosta, vennero consultate da non molti studiosi (per esempio l’Abate Stoppani, grazie all’entratura di Natale Ceroli e alla liberalità di Vittorina Brambilla potè consultare i manoscritti di Manzoni e lì rinvenne quel “Natale del 1833” che egli rese pubblico per la prima volta nel suo “I primi anni di A. Manzoni” del 1874).
Per quanto riguarda la “prima minuta”, solo nel 1905 Giovanni Sforza ne riportò i brani che egli definì “soppressi o rifatti nella seconda”, stampandoli con l’editore Hoepli col titolo “Brani inediti dei Promessi Sposi”.
Il lavoro di Sforza venne accolto con riserva dagli studiosi che non ne apprezzarono la scarsa attenzione filologica.
Venne però molto letto dal pubblico ed è grazie a questa edizione del 1905 che divennero familiari i nomi di “Fermo”, conosciuto fino ad allora esclusivamente come “Renzo”, e del “Conte del Sagrato”, già noto come “l’innominato”; che si conobbe la parte erotico-criminale della vicenda della Signora di Monza, fortemente ridimensionata ne “I Promessi Sposi”.
Nel 1905 il pubblico, cioè, non aveva ancora un quadro organico della “prima minuta” ma non ne era affatto all’oscuro ed era anzi curioso di saperne di più, stimolando così gli studiosi a darsi da fare.
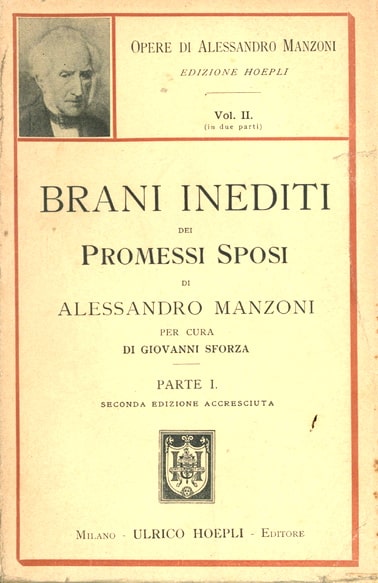
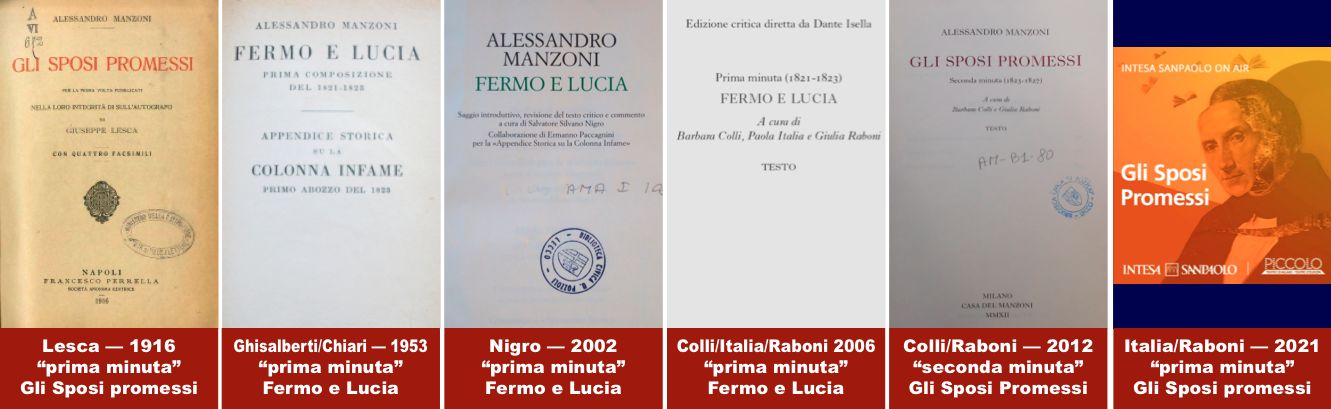
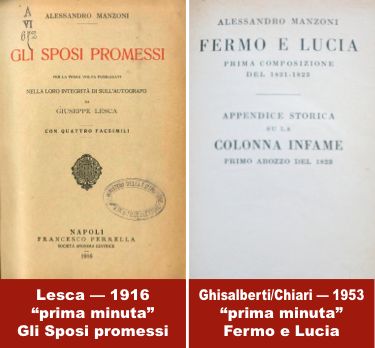
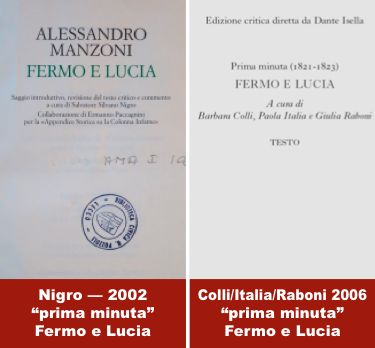
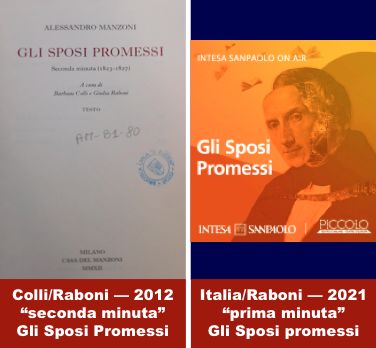
8.6/ In oltre un secolo, sostanziale identità nel testo.
Una domanda che legittimamente può porsi ogni lettore è se tra il testo della prima pubblicazione della “prima minuta” di Lesca del 1916 (titolo, “Gli Sposi promessi”) e quello dell’ultima del 2006 di Colli, Italia, Raboni (titolo, “Fermo e Lucia”) vi sono differenze strutturali o se le eventuali varianti sono significative solo sul piano filologico (importantissimo, si intende).
Giusto per rassicurare il lettore (pensieroso forse per i 140,00 Euro di costo di copertina dell’ultima edizione del 2006), segnaliamo che il testo fissato da Lesca (disponibile gratuitamente su Internet) è rimasto sostanzialmente invariato nelle edizioni successive, condotte con criteri filologici sicuramente più rigorosi.
Tra i diversi commentatori vi sono naturalmente state discussioni — anche serie, anche importanti — su questa o quella parola; su dissonanze, più o meno significative, per es. circa la cronologia della composizione della “prima” e della “seconda” Introduzione.
Per quanto attiene però la successione delle parti narrative, descrittive, dialogiche e riflessive tra gli esperti c’è da sempre una sostanziale unità di giudizio — ai nostri fini anche il testo di Lesca è più che valido.
Naturalmente gli esperti potranno tacciarci di superficialità e redarguirci: voi del Centro Studi di quell’Abate Stoppani ci date l’impressione di sottovalutare il lavoro che si è svolto in oltre un secolo di occhi consumati sulle carte e di impiego diuturno di cervelli sicuramente molto efficienti.
Saremo lietissimi di essere redarguiti — ma nulla di più lontano in noi dal sottovalutare il lavoro degli esperti.
Segnaliamo anzi che sarebbe utile potere disporre di un qualche studio, rivolto al pubblico dei “normali lettori”, dedicato proprio al gran lavoro fatto nel passaggio delle varie edizioni, dal Lesca 1916 al Colli-Italia-Raboni del 2006.
(Qui sotto, da sinistra, Giovanni Sforza, Giuseppe Lesca, Fausto Ghisalberti, Silvano Nigro, Barbara Colli, Giulia Raboni, Paola Italia.)




Ciò detto per la cronaca passata, possiamo passare all’oggetto della nostra analisi, riassumibile nella domanda: l’Epilogo la racconta in modo fedele alla “Prima Minuta” di Manzoni o no?
— Paola Italia assicura che sì.
— Noi sosteniamo che no! E nel modo più assoluto.
Come già anticipato, l’Epilogo, infatti, non solo taglia taglia e taglia il grande arazzo del povero Manzoni ma quel poco che riporta della trama, in ben 23 situazioni narrative lo fa in modo difforme dalla “Prima Minuta” di Don Lisander quando non addirittura OPPOSITIVE.
Leggere per credere!
9. Trame e censure.
9.1/ Conformità di struttura e di trama? Proprio per niente!
Come è ormai ben chiaro al lettore, alla base della “rivoluzione” nella critica manzoniana, proposta da Paola Italia con l’iniziativa “Gli Sposi promessi su Internet”, è l’idea che l’Epilogo “Gli Sposi promessi”, contenuto nel «Manoscritto Lecco 170», sia una riproposizione “ridotta”, “riassunta”, “compendiata” ma comunque “fedele” della “Prima Minuta” di Manzoni qual era PRIMA che a fine 1823 Manzoni ci mettesse le mani per trasformarla nel testo che poi pubblicò nel 1827 con il titolo “I Promessi Sposi”.
Per la verità, circa la qualità di questa supposta “fedeltà” dell’Epilogo alla “Prima Minuta”, Paola Italia sta abbastanza sulle generali.
Dopo averci meritoriamente segnalato che la divisione degli argomenti tra le 4 parti dell’Epilogo è differente da quella della “Prima Minuta”, la Professoressa Italia si limita infatti a dirci che (“Gli Sposi promessi”, 2018, p. 143):
«la presenza di dettagli onomastici e toponomastici precipui della prima stesura e la coerenza della trama […], conforme alla struttura originaria che, come è noto, presentava le vicende del rapimento di Lucia e della conversione del Conte del Sagrato prima di quelle di Fermo, anticipate, a partire dalla revisione della Seconda minuta e poi nella Ventisettana al capitolo XI, divenuto così il centro di smistamento di tutta la complessa macchina narrativa».
Oppure che (idem, p. 147):
«Alcuni particolari della trama, peculiari di FL, mostrano una diretta dipendenza dall’originale. Il patteggiamento per il rapimento di Lucia tra Don Rodrigo e il Conte del Sagrato, ad esempio, è di “duecento doppie”, elemento che in SP cade […] E ancora: […] in particolare la visita del Conte ad Agnese, le scuse e la consegna del danaro.»
O ancora (idem):
«Alcuni particolari, nei capitoli della parte IV, sono di diretta derivazione da FL, come la presentazione delle false notizie, provenienti dalla “Corte di Madrid”, sulle modalità di propagazione della peste».
Come il lettore può abbastanza agevolmente rilevare, Paola Italia, più che dimostrarci la “fedeltà” dell’Epilogo alla “Prima Minuta”, si limita a indicarne alcuni punti di contatto, il che è evidentemente altra cosa.
Ciò fa pensare: dal momento che Paola Italia sostiene essere stato Manzoni non solo a conoscenza ma addirittura mallevadore di quell’Epilogo (che la Prof. si ostina a definire “Compendio”), è certo utile verificare se e in che misura l’Epilogo è fedele alla “Prima Minuta” e se nella sua struttura (la trama) poteva riconoscersi Manzoni.
Diciamone noi qualche cosa.
9.2/ L’Epilogo considera esclusivamente le parti narrative. E anche queste, grossolanamente.
Per farci una prima idea, possiamo vedere come l’Epilogatore ha proceduto nella sua riduzione del Tomo 1, Cap. 1.
Nella edizione del 2006 (curata anche da Paola Italia) questo capitolo occupa 12 pagine per 5.090 parole, con una media di 424 parole a pagina.
Nell’Epilogo il contenuto di queste 5.090 parole è proposto riassunto in 65 parole, pari al 1,28% dell’originale (1 parola dell’Epilogo ne riassume 78 di Manzoni).
Il lettore non si affligga per questa contaminazione tra letteratura e numeri: consideri che spesso anche le tabelline delle elementari possono aiutare a chiarirsi le idee.
Come sa benissimo chiunque ci abbia provato almeno una volta, il riassunto (ancor più un “compendio”) appena appena fedele di un testo complesso come quello del romanzo di Manzoni, richiede un impiego di parole più o meno del 10% rispetto all’originale (ricordiamo che il “compendio”, per essere tale, deve quanto meno richiamare tutti gli elementi dell’originale, altrimenti bisogna parlare di “scelta”, di “cernita” — o di “censura”).
Con questo criterio, per compendiare il Cap. 1 della “Prima Minuta” di Manzoni, l’Epilogatore del «Manoscritto Lecco 170» avrebbe dovuto utilizzare più o meno 510 parole.
Invece ne ha usate 65!
Il lettore si chiederà: ma come ha fatto il nostro sconosciuto Epilogatore per riuscire in cotanta impresa? Era egli un Mago?
Si possono forse dare più risposte: la più semplice, veritiera e verificabile da chiunque, è che della “Prima Minuta” di Manzoni il nostro Epilogatore ha fatto come i beccai:
— ha messo il Capitolo 1 sul suo tavolo di lavoro;
— con un ben affilato mannarino lo ha fatto a pezzi;
— facendo ciò che nessun censore austriacante aveva osato con Manzoni, ha tenuto quel poco che gli faceva comodo, dando il resto ai cani.
Ma vediamo il beccaio/censore al lavoro cominciando col riportare le sue 65 parole con cui ha inteso “compendiare” il Capitolo 1 della “Prima Minuta” manzoniana:
Epilogo “Gli Sposi promessi” — carta 2r:
«Correva l’anno 1628., quando due giovani persone d’una terra presso Lecco, di bassa condizione, dovevano all’indomani presentarsi al Paroco D. Abondio per la celebrazione del loro matrimonio.
In questo mezzo, verso la sera precedente, D. Abondio, mentre passeggiava lungo il lago recitando il Breviario, s’incontra in due Bravi, che bruscamente lo investono, e lo minacciano di peggio, se assista a quel matrimonio.
Il Curato s’intimorisce […]»
Come può comprendere a colpo d’occhio anche il lettore più distratto (che lo abbia, però, almeno una volta scorso), queste 65 parole dell’Epilogatore sono tutto tranne che un “Compendio” del Capitolo 1 della “Prima Minuta” di Manzoni).
A volere essere generosi possono forse essere considerate come la rappresentazione (parziale) di una delle cinque sequenze narrative in cui è idealmente possibile dividere il Cap. 1 della “Prima Minuta”.
A volere essere anche solo oggettivi sono invece una “censura” pesantissima del come Manzoni abbia inteso avviare il suo romanzo.
In ogni caso la nostra valutazione è certamente non molto benevola: ci sembra proprio che l’Epilogo possa essere considerato tutto tranne che un testo che Manzoni avrebbe potuto in qualche modo apprezzare.
Dal momento però che siamo abituati a dimostrare con dati condivisibili ciò che affermiamo, chiediamo al lettore di seguirci un pochino nel dettaglio, per comprendere che non stiamo parlando sulla base di pregiudizi ma solo a partire da una semplice osservazione del dato di fatto.
9.3/ Cinque parti costitutive del Capitolo 1 della “Prima Minuta”.
Per comprendere a ragion veduta il carattere della censura operata dall’Epilogatore sulla “Prima Minuta” di Manzoni, ne abbiamo preso il Capitolo 1 (in Manzoni, 5.085 parole) e lo abbiamo ripartito in 5 “sequenze” concettuali da cui abbiamo tratto un nostro riassunto (o “compendio” se vi piace di più), per un totale di 564 parole (poco più di quel 10% di cui si diceva).
Va da sé che il nostro riassunto non ha alcuna pretesa artistica: è semplicemente strutturato perché riprenda TUTTI gli elementi del Capitolo (ovviamente sviluppati in tutt’altro modo da Manzoni) a mostrare come avrebbe potuto / dovuto essere articolato l’Epilogo se fosse stato concepito (e realizzato) come una vera riduzione fedele della “Prima Minuta”, come sostenuto da Paola Italia e sodali — ricordiamo che stiamo discutendo su questo aspetto.
Sequenza 01.
I luoghi in cui nasce il romanzo.
In Manzoni, 1.212 parole (nostre, 147) — L’Autore descrive quel ramo del lago di Como da cui esce l’Adda che sotto il ponte, nel suo punto più stretto, ha un doppio risuonare. A sinistra, da tre torrenti la riviera è stata ridotta a piano e, dall’uomo, a prati e vigneti; salendo trovi ulivi; castagni; poi massi e pascoli verdissimi; poi ancora, vigneti.
Dal lago alla nuda montagna, case e villaggi, il principale dei quali è Lecco, un borgo con castello e guarnigione spagnola.
Molte le stradicciuole: dalla riviera ve n’è una che tira al monte tra muri e siepi; vi si vedono vette o ampi orizzonti: a settentrione l’acqua si fonde in azzurro col cielo; a mezzogiorno, l’Adda, ridiventato lago e poi ancora fiume, scorre nella lontana pianura; oltre il ponte, il Monte Barro e la sua piana: per l’Autore “è uno dei paesi più belli del mondo”, avendovi passato infanzia, puerizia e giovinezza.
Sequenza 02.
I Bravi di Don Rodrigo fermano Don Abbondio.
In Manzoni, 891 parole (nostre, 100) — Su quella stradicciuola nell’autunno 1628, passeggiava il Curato di *** dicendo l’ufizio; le mani al breviario, l’occhio alle cime imporporate dal tramonto.
A una rivolta (vi era una cappelletta dipinta con figure del purgatorio) distingue, uno in piedi, l’altro seduto sul muricciolo, due uomini inaspettati ma riconoscibilissimi. Reticella in capo; pistole, cartucce, corno di polvere al collo, coltellaccio e spada: due Bravi.
Di evidenza aspettavano proprio lui, il Curato; questi, fingendo lettura, pensa a inimicizie trascurate e se vi è una via di fuga; l’indice al collare guarda di lato e dietro: nessuno. Cercando di sorridere, si avvicina ai due.
Sequenza 03.
Ordine minaccioso dei Bravi. Servile assenso del Curato.
In Manzoni, 384 parole (nostre, 53) — Bravi: il matrimonio tra Fermo Spolino e Lucia Zarella non si farà né domani né mai, altrimenti …
— io non c’entro …
— è avvisato; il nostro padrone D. Rodrigo la riverisce, ma zitto! Altrimenti …
— sempre disposto all’obbedienza …
I Bravi si allontanano intonando una canzonaccia; il Curato, sconvolto, rientra alla propria casa.
Sequenza 04.
La condizione della società e del Clero. Opportunismo di Don Abbondio.
In Manzoni, 1.598 parole (nostre, 165) — Contro la diffusa violenza, l’Autore ricorda numerose “grida” (che non riporta): fonte di arbitrio per gli onesti e inutili contro i disonesti per i tanti birri e giudici loro conniventi.
Tutta la società era sospettosa e in armi, organizzata in confraternite per la difesa e l’offesa. Tenevano alle proprie immunità gli ecclesiastici ambiziosi, violenti, avari ma anche i buoni e pii, a ciò indotti dalla condizione generale; quindi tribunali del clero e la forza per eseguirne gli ordini.
A questo male tutto contaminante, Abbondio si adeguava, vaso di terra tra vasi di bronzo. Prete per convenienza viveva e lasciava vivere; ammiccando al debole ma sempre col più forte. Sentendosi sicuro, criticava: il morto era sempre un imprudente; l’omicida un senza difetti. Irritato dai sacerdoti difensori dei deboli chiamava sconsiderati gli angariati e uomini d’oro i potenti / prepotenti. La sua bandiera: a un galantuomo che bada ai fatti suoi, non accadono mai brutti incontri.
Si immagini come si sentisse dopo quei visi e quelle minacce.
Sequenza 05.
Malanimo di Don Abbondio verso gli sposi. Discussione con la serva Vittoria (Perpetua).
In Manzoni, 980 parole (nostre, 100) — Abbondio rimugina sulla violenza subita: Fermo non si contenterà di un no, potrebbe ricorrere. E Don Rodrigo? Lo aveva sempre riverito e difeso e ora costui… Ma l’ira è tutta per gli sposi, incuranti dei fastidi procurati ai galantuomini.
Giunto frastornato alla casa, è interrogato dalla governante Vittoria che lo pressa e, pur subendo rimbrotti per passate petulanze, gli cava l’accaduto:
— prepotenti, calpestatori dei poverelli; e lei che farà? si ricordi che il cane che abbajia non morde…
— zitta, zitta! son io nei guai!
La governante lo spinge a mangiare un boccone; Don Abbondio si corica pensando al da farsi.
Rileggiamo ora il già proposto “Compendio” (con la “C” maiuscola, secondo Paola Italia) che di questo Cap. 1 della “Prima Minuta” di Manzoni è proposto nel «Manoscritto Lecco 170»:
Epilogo “Gli Sposi promessi” — carta 2r:
«Correva l’anno 1628., quando due giovani persone d’una terra presso Lecco, di bassa condizione, dovevano all’indomani presentarsi al Paroco D. Abondio per la celebrazione del loro matrimonio.
In questo mezzo, verso la sera precedente, D. Abondio, mentre passeggiava lungo il lago recitando il Breviario, s’incontra in due Bravi, che bruscamente lo investono, e lo minacciano di peggio, se assista a quel matrimonio.
Il Curato s’intimorisce […]»
Come chiunque può agevolmente comprendere, delle cinque sequenze in cui abbiamo diviso il Cap. 1 della “Prima Minuta”, l’Epilogatore ha mantenuto (malamente) un qualche riferimento esclusivamente alla
— Sequenza 3 / Ordine minaccioso dei Bravi. Servile assenso del Curato;
Ha invece completamente cancellato ogni riferimento alle altre quattro:
— Sequenza 1 / I luoghi da cui nasce il romanzo;
— Sequenza 2 / I Bravi di Don Rodrigo fermano Don Abbondio;
— Sequenza 4 / La condizione della società e del Clero. Opportunismo di Don Abbondio;
— Sequenza 5 / Malanimo di Don Abbondio verso gli sposi. Discussione con la governante.
Richiamiamo l’attenzione del lettore su due di queste quattro sequenze, come particolarmente caratterizzanti di questo Capitolo Primo del romanzo di Manzoni, ancorché completamente ignorate dall’Epilogo del «Manoscritto Lecco 170».
9.4/ Sequenza 1.
I luoghi da cui nasce il romanzo.
Il quadro descrittivo con cui Manzoni dà inizio al suo romanzo è rimasto invariato (salvo modifiche stilistiche) in tutte le sue versioni, dalla “Prima Minuta” del 1821 al “I Promessi Sposi — Storia della Colonna Infame” del 1840.
Nel leggerne le oltre tre pagine fitte, non c’è lettore che non comprenda come Manzoni non volesse scrivere l’introduzione a una guida del Touring Club del territorio lariano.
È evidente a tutti che nella sua descrizione vi sono molti elementi che lo scrittore considerava importante porre all’inizio del suo lavoro perché il lettore si immergesse immediatamente in un determinato ambiente spiritual-naturalistico.
Vediamone gli elementi più evidenti e immediati.
Primo — Il risvolto autobiografico.
Sono note le parole con cui Manzoni chiude queste prime tre pagine del romanzo, con un riferimento esplicito al valore esistenziale del paesaggio lariano nella vita dello scrittore:
«La giacitura della riviera, i contorni, e le viste lontane, tutto concorre a renderlo un paese che chiamerei uno dei più belli del mondo, se avendovi passata una gran parte della infanzia e della puerizia, e le vacanze autunnali della prima giovinezza, non riflettessi che è impossibile dare un giudizio spassionato dei paesi a cui sono associate le memorie di quegli anni.»
In apertura romanzo, Manzoni ci dice quindi: per l’anagrafe sono nato a Milano ma sono di famiglia lariana e mi sono formato (dai due giorni di vita in poi) nel territorio lariano; quando parlo del ramo del lago di Como da cui esce l’Adda, parlo di casa mia; fin dall’infanzia ho colto e coltivato quell’aura particolare che fa di questo territorio non solo un incanto paesaggistico ma l’evidenza del rapporto tra la natura e il divino.
Secondo — La visione dell’universo.
Certo! Perché per Manzoni la natura è manifestazione del divino, in quell’angolo di mondo cosa che può apparire particolarmente evidente.
Ciò che rende affascinanti le prime tre pagine della “Prima Minuta” (e delle successive versioni del romanzo) è infatti la raffigurazione spazio-temporale del mondo che ci circonda.
La natura non è solo l’oggetto della nostra visione e azione: è essa stessa azione, movimento, passaggio, trasformazione.
È manifestazione di un lungo processo geologico e insieme teleologico: monti sorgenti dall’acque ed innalzati al cielo.
Quelle tre pagine sono una sequenza prettamente descrittiva e insieme di indirizzo morale attraverso cui Manzoni determina nel lettore un precisa suggestione che verrà ripresa con l’altrettanto famoso addio notturno di Lucia in barca, in fuga con il promesso e la madre.
Nella “Prima Minuta” era «Addio, monti posati sugli abissi dell’acque ed elevati al cielo».
L’immagine maturò poi in una più meditata concezione sia geologica sia teologica nella Ventissettana («Addio, montagne sorgenti dalle acque, ed erette al cielo»), in coerenza con le ormai affermate concezioni sulla formazione dei continenti e insieme con l’idea della materia come espressione di uno spirito onnicomprensivo e sempieterno (sia chiaro che questo è l’approccio di Manzoni, non necessariamente condivisibile — ma noi stiamo cercando di esporre Manzoni, non la nostra visione del mondo).
L’immagine della Ventisettana venne infine resa perfetta sul piano artistico nella Quarantana («Addio, monti sorgenti dall’acque, ed elevati al cielo»).
Rilevando la totale assenza nell’Epilogo dei contenuti di questa prima sequenza e ricordando le pretese critiche di Paola Italia, ci sembra appaia fin troppo evidente che:
In primo luogo — Un frequentatore dell’ambiente di Manzoni e — anzi — un suo intrinseco (come ipotizza Paola Italia essere stato l’estensore dell’Epilogo) non avrebbe mai potuto ignorare la descrizione ambientale di avvio del romanzo sia per un troppo scontato rispetto del manifesto richiamo autobiografico sia per l’altrettanto evidente suo valore “morale”, di cui gli intrinseci di Manzoni erano perfettamente consapevoli e consentanei.
Non a caso Antonio Rosmini, conosciuto di persona Manzoni nel 1826, in quello stesso anno gli dedicò il suo scritto «Del Divino nella Natura» (Bortolotti 1869):
Del Divino nella Natura
ad
Alessandro Manzoni«Se non conoscessi per lunga esperienza quanto può l’amicizia nell’anima vostra, o Alessandro, temerei di sembrarvi indiscreto ed intemperante rivolgendovi il discorso in iscritto, non contento de’ lunghi colloqui, ne’ quali voi condiscendete a meco intrattenervi. Ma d’una parte l’amicizia m’assicura di poterlo osare impunemente, dall’altra parte non parrà strano a nessuno, se non fosse a voi solo, che io brami così di provocare il vostro giudizio sopra queste mie ricerche intorno al divino nell’ordine della natura, il quale si può dire comun patrimonio della Poesia e della Filosofia.
Qualora me lo negaste, io mi rivolgerei all’Italia, e le domanderei chi mai sia colui che, tra tutti i suoi figli, abbia più altamente pensato e sentito il nesso e l’intima unione di quelle due nobilissime figlie del pensiero umano, e gliel’abbia fatto sentire meglio di chicchessia e in modo novo e suo proprio.»
In secondo luogo — Mai Manzoni avrebbe “approvato” o finanche “voluto” (come imprudentemente scrive Paola Italia) un Epilogo / Compendio / Riassunto / Scaletta — chiamatelo come volete — della prima stesura del suo romanzo nel quale si fossero amputati in modo così rozzo la sua creazione artistica e la sua visione del creato.
9.5/ Sequenza 4.
La condizione della società e del Clero.
Etica opportunistica di Don Abbondio.
Con questa sequenza Manzoni, attraverso Don Abbondio, consegna sia perle al repertorio della letteratura mondiale sia una lettura decisamente evoluta dei meccanismi sociali, validi per il Seicento ma — è troppo ovvio — per il 1821 e per il 2021.
Pur con la mancanza del testo delle “grida” (Manzoni nella “Prima Minuta” non ne aveva trascritto il contenuto) questa sequenza del Capitolo 1 è veramente notevole.
Ma evidentemente non abbastanza perché l’Epilogatore pensasse di farvi il benché minimo riferimento.
Perché è notevole questa parte del Capitolo 1?
Perché con essa Manzoni indica con precisione uno dei problemi della società del XVII secolo ma con un ovvio richiamo alla società dei suoi tempi, all’Italia 1821, agitata da problemi enormi, risolti (diciamo così) solo dopo 40 anni di sanguinose lotte risorgimentali.
Il ruolo della Chiesa. Nel XVII secolo ma anche nel XIX.
Manzoni mette qui in luce il carattere ribelle e disgregante di buona parte dell’ordine nobiliare, in rivolta contro il potere centrale (straniero!) e in conflitto con le altre formazioni della società.
Tra queste formazioni Manzoni evidenzia la Chiesa.
Ne mostra i guasti, prodotti dalla generale degenerazione della società (la “Chiesa cattiva”), ma ne mostra anche gli elementi positivi (la “Chiesa buona”).
E in effetti, uno dei due assi portanti del suo romanzo è dato dalla capacità della “Chiesa buona” di intervenire a colmare le lacune del potere centrale, riuscendo a divenire elemento di riferimento della collettività nelle crisi (carestia e peste) e insieme moderatore del disfacimento di cui è portatrice la classe nobiliare.
Alle angherie del nobile Don Rodrigo si piega la “Chiesa cattiva” (Don Abbondio) ma alza la fronte la “Chiesa buona” (Padre Cristoforo).
E chi favorisce il ritorno alla normalità sociale il delinquente Conte del Sagrato? Ancora la “Chiesa buona”, attraverso la figura del Cardinale Federigo Borromeo.
Non è difficile vedere in questa rappresentazione del ruolo storico (ossia, effettivamente attuato) della Chiesa ai primi del ’600, l’idea coltivata da Manzoni di una Chiesa del XIX secolo in grado di porsi come elemento di equilibrio e di riferimento dell’intera collettività.
Si può essere d’accordo o meno sulla validità storica di questa prospettiva coltivata da Manzoni fin dal 1808 ma è inevitabile riconoscere che questa è la sua prospettiva ed è uno degli elementi portanti del suo romanzo.
Se non si comprende questo, non si comprende nulla né di Manzoni né del suo “I Promessi Sposi” né tanto meno della sua “Prima Minuta”.
Non è comunque difficile vedere come le figure storiche di 200 anni prima potessero apparire attuali proprio nella cerchia dei sodali di Manzoni.
Bisogna ricordare che il sacerdote Antonio Rosmini (lo stesso che, trascinato dalle rappresentazioni artistiche dell’amico, aveva dedicato nel 1826 a Manzoni il suo “Del divino nella Natura”) nel quadro della crisi del 1848, fu uno dei più attivi e influenti attori della politica nazionale cercando di spingere per una soluzione federativa degli Stati italiani, con la Chiesa come garante etico-politico.
Tornando a noi, il problema è che di tutto ciò, nell’Epilogo non vi è neppure il più lontano riferimento.
E si vuole — ci ripetiamo, ma a volte è proprio il caso — che questo pateracchio lungo quaranta pagine manoscritte fosse conosciuto, apprezzato e voluto da Manzoni?
Signore Professoresse, se non la scienza, almeno un poco di buon senso, per favore!
Abbiamo già ripetuto e ripetuto che l’Epilogo del «Manoscritto Lecco 170» ignora TOTALMENTE gli elementi di carattere etico-sociale che Manzoni pone all’inizio del suo romanzo attraverso le sequenze 1, 2, 4 e 5.
Dobbiamo ora evidenziare come anche della sequenza 3 (l’unica considerata nell’Epilogo) vengono ripresi solo gli elementi più banalmente descrittivi e ignorati invece quelli eventualmente utili alla stessa comprensione della narrazione.
9.6/ Sequenza 3.
Ordine minaccioso dei Bravi. Servile assenso del Curato.
Nostro riassunto:
— Bravi: il matrimonio tra Fermo Spolino e Lucia Zarella non si farà né domani né mai, altrimenti …
— io non c’entro …
— è avvisato; il nostro padrone D. Rodrigo la riverisce, ma zitto! Altrimenti …
— sempre disposto all’obbedienza …
I Bravi si allontanano intonando una canzonaccia; il Curato, sconvolto, rientra alla propria casa.
Epilogo “Gli Sposi promessi” — carta 2r:
«[…] Bravi che bruscamente lo investono, e lo minacciano di peggio, se assista a quel matrimonio.
Il Curato s’intimorisce […]
Questa è l’unica sequenza del Capitolo 1 di cui si trova una qualche traccia nell’Epilogo.
Ma si tratta, per l’appunto, solo di “tracce” — e la cosa è veramente grave!
A inizio romanzo, con questo dialogo e attraverso la bocca dei Bravi, Manzoni consegna infatti al lettore il nome e insieme l’identità sociale dei suoi protagonisti: da una parte Don Rodrigo (un nobile), dall’altra Fermo Spolino e Lucia Zarella (popolani, entrambi tessitori — lo dice il loro nome).
Rileviamo che nell’Epilogo questi elementi, decisamente orientativi del senso complessivo del romanzo, non vengono nemmeno lontanamente menzionati.
La cosa non è marginale: senza l’indicazione del mandante che senso ha l’appostamento dei Bravi e le loro minacce al Curato?
Seguendo l’Epilogo, il lettore che non avesse avuto conoscenza dell’originale di Manzoni (e quelli che lo conoscevano si contavano sulle due mani, prima della pubblicazione del 1827) doveva inevitabilmente pensare che fossero i Bravi stessi ad avere una qualche ragione contro il matrimonio tra i due giovani di bassa condizione.
Senza l’indicazione del mandante, perché il Curato avrebbe dovuto “intimorirsi”, come scrive l’Epilogatore?
Se si fosse trattato solo di cani sciolti, il Curato, uscito dalla situazione contingente, li avrebbe immediatamente denunciati e fatti arrestare!
Tutto il problema stava nella figura del mandante Don Rodrigo, cui il Curato infatti (in Manzoni, si intende, non in quel tonto dell’Epilogatore) non manca di dichiararsi “sempre pronto all’obbedienza”!
Sotto questo profilo l’Epilogatore si mostra un veramente pessimo narratore e l’Epilogo del «Manoscritto Lecco 170» solo un “coso”, valido a nulla.
E Manzoni avrebbe dovuto – è questo che sostiene Paola Italia e la sua cordata — approvare e apprezzare questa ciabatta bucata di pseudo-riassuntino?
9.7/ Bilancio sul come l’Epilogatore abbia inteso la “riduzione” del Capitolo 1 della “Prima Minuta” di Manzoni.
Per riassumere anche visivamente il rapporto tra il Capitolo Primo della “Prima Minuta” di Manzoni e quella parte dell’Epilogo che ne richiama i contenuti, proponiamo un grafico semplice semplice.
Le barre rappresentano le cinque sequenze nelle quali abbiamo diviso il Cap. 1 della “Prima Minuta” di Manzoni con l’indicazione dello spazio, in termini di parole, che rispettivamente occupano nella struttura del capitolo.
La barra evidenziata in grigio indica l’unica sequenza di cui si è occupato l’Epilogatore (e abbiamo visto con quanta superficialità).
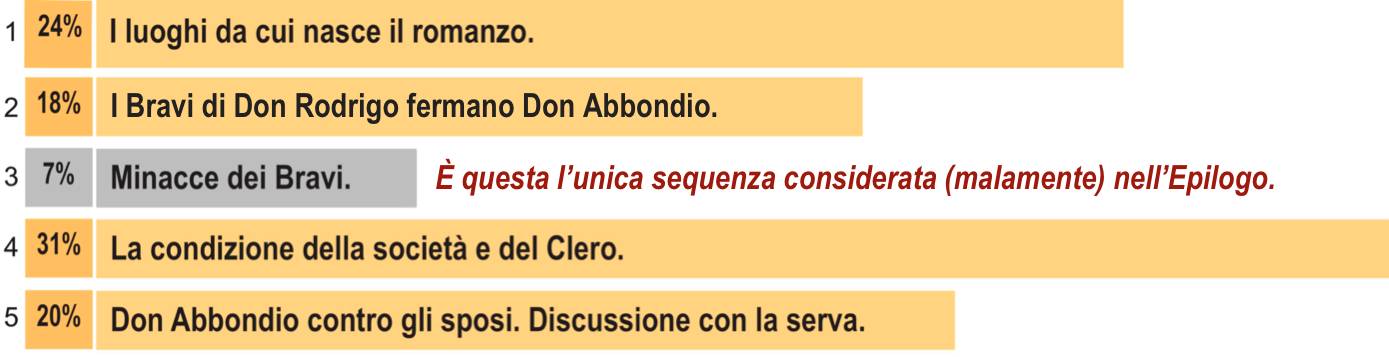
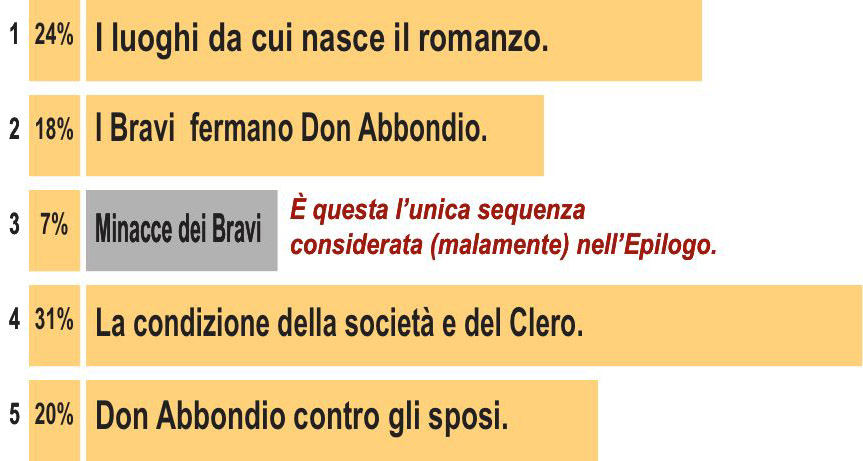
Quindi?
Quindi, l’Epilogatore del «Manoscritto Lecco 170» ha impiegato 65 parole per riassumere:
— non il Capitolo 1 della “Prima Minuta” di Manzoni ma …
… esclusivamente quella sua parte delle minacce dei Bravi al Curato — pari al 7% del testo di tutto il Capitolo 1 — e anche questo in modo monco e fuorviante.
Nulla nell’Epilogo del «Manoscritto Lecco 170» riguardante il Capitolo 1 della “Prima Minuta” di Manzoni, richiama — neppure lontanamente — il formidabile impianto di questa apertura del romanzo, nella quale Manzoni ha trasfuso la sua genialità di artista e insieme la profondità del pensiero storico e sociale: in una parola ciò che ha fatto de “I Promessi Sposi” una creazione letteraria atta a muovere menti e coscienze verso una più consapevole visione del mondo.
Quindi — di tutta evidenza — le prime 40 pagine del «Manoscritto Lecco 170», che Paola Italia vorrebbe farci pensare come conosciute, apprezzate e finanche volute da Alessandro Manzoni come testimonianza della prima stesura del romanzo, non solo nulla hanno che vedere con una qualche forma di “compendio” o “riassunto” o “riduzione” della “Prima Minuta” ma sono di fatto un rifiuto delle parti più significative del romanzo fondativo della lingua italiana del nostro tempo a favore di una sua misera volgarizzazione, indegna anche della più scalcinata scuola elementare non dell’Italia ma di qualsiasi parte del Mondo.
Il lettore incredulo certo si chiederà: ma questo svilimento del lavoro di Manzoni da parte dell’Epilogatore vale per tutto lo svolgimento della “Prima Minuta”?
Dobbiamo purtroppo rispondere che sì!
Ma la questione è ancora più grave: non solo l’Epilogo del «Manoscritto Lecco 170» si fa un baffo dei temi che hanno fatto grande Manzoni e più maturi i suoi lettori, e si limita a raccontare solo brani della storiella ma della storiella stessa ha anche falsato i più banali fatti in ben 23 punti.
È quanto ci proponiamo di dimostrare con la prossima sezione.
10. Le 23 difformità di fatto.
Più sopra abbiamo svolto l’analisi del Capitolo 1 della “Prima Minuta”, evidenziando come l’Epilogo “Gli Sposi promessi” ne ha ignorati tutti gli elementi che possiamo definire “morali” in senso lato.
L’Epilogo si è cioè limitato a riprenderne solo alcune delle sequenze più strettamente narrative.
Ora vogliamo illustrare come, nell’Epilogo del «Manoscritto Lecco 170», molte di quelle stesse sequenze narrative sono rappresentate in modo difforme rispetto alla “Prima Minuta” di Manzoni.
Detto alla buona: in molti — troppi — punti l’Epilogo racconta gli avvenimenti in modo diverso da come li aveva scritti Manzoni nella prima stesura del romanzo.
E non parliamo di dettagli.
Si tratta di elementi significativi per lo stesso meccanismo narrativo che, nell’Epilogo, risulta dissimile, quando non divergente, da quello tracciato da Manzoni, e ciò in almeno tre modalità.
10.1/ Le molte facce della infedeltà.
Più sotto il lettore trova illustrate 23 difformità di fatto tra Epilogo e “Prima Minuta”.
Prima di passare alla rassegna, può essere utile riassumerne le tre modalità con cui le 23 difformità si manifestano.
A/ Come “invenzione originale”.
In 15 sequenze la narrazione proposta dall’Epilogo è assolutamente originale: non ha cioè riscontro in altri testi o rappresentazioni di qualsivoglia natura o qualsivoglia datazione (naturalmente sulla base alle conoscenze di chi scrive — ben vengano smentite documentate).
B/ Come “ripresa da altri scritti di Manzoni”.
In 4 sequenze la narrazione dell’Epilogo è ripresa da “I Promessi Sposi” del 1827 (Manzoni apportò numerose varianti tra la “Prima Minuta” — da lui mai resa pubblica — e la elaborazione data alle stampe nel 1825-27).
C/ Concorde con il film di Mario Camerini “I Promessi Sposi” del 1941.
Quattro sequenze narrative dell’Epilogo, non hanno alcuna relazione con scritti di Manzoni ma sono concordi con quelle proposte da Camerini nel suo film del 1941, a loro volta difformi dal testo di Manzoni.
Immaginiamo che ciò può lasciare perplesso il lettore ma è proprio così: leggere e vedere per credere.
Viene inevitabilmente da pensare che l’Epilogatore, cronologicamente molto vicino a noi, fosse un grandissimo cialtrone in vena di burle, ispiratosi anche al film di Camerini per sollevare un po’ di polvere.
Oppure che, attivo a metà Ottocento, avesse preso a riferimento per il suo riassuntino testi diversi da quella che noi consideriamo la “Prima Minuta” scritta da Manzoni, ai quali avrebbe attinto anche il regista Camerini.
Indagare più a fondo questa seconda ipotesi (per altro decisamente interessante) esula dal nostro attuale obiettivo; per il momento ci limitiamo quindi a segnalare le 23 più evidenti difformità di fatto rispetto alla “Prima Minuta” manzoniana quale ci è stata consegnata dalla critica, in particolare come possiamo leggerla nella edizione del 2006, curata anche dalla già ampiamente citata Professoressa Paola Italia.
Difformità n. 1 — Invenzione originale.
10.2/ “Presentandosi gli Sposi” …
La situazione — Don Abbondio, minacciato dai Bravi di Don Rodrigo, nella notte insonne pensa con quali argomenti convincere Fermo Spolino e Lucia Mondella a rinviare le nozze. E al mattino, che succede?
Vediamo come la cosa è presentata nell’Epilogo (carta 2r, p. 3, evidenziazioni nostre):
«Il Curato s’intimorisce, e, presentandosi gli Sposi, muove difficoltà per tirare in lungo, e si finge poscia ammalato».
Aiutooo! Per due motivi.
Primo — Nella “Prima Minuta” di Manzoni (e poi, senza variazioni, nella Ventisettana e nella Quarantana) è il solo Renzo a presentarsi da Don Abbondio.
Egli deve semplicemente chiedergli fra quanto (mezz’ora? una ora?) il parroco potrà celebrare le nozze.
Lucia non ha alcuna ragione per recarsi anch’essa dal sacerdote per fissare l’ora del matrimonio — ovvio no? Essa è nella propria abitazione (poco distante dalla chiesa), indaffarata a mettere a punto l’abito da sposa con la madre e le amiche; attende che Fermo, l’ormai quasi suo sposo, torni a dirle: su andiamo, il parroco è pronto, ci aspetta!
Con quel plurale «gli Sposi», l’Epilogatore mostra o una ben curiosa disattenzione o di avere riassunto un testo diverso dalla “Prima Minuta” di Manzoni cui, secondo Paola Italia, egli avrebbe invece fatto fedele riferimento.
Secondo — L’Epilogatore ignora lo scontro tra Fermo e Don Abbondio, uno dei topos dell’intero romanzo.
L’episodio è ovviamente importante in Manzoni perché gli consente di:
— presentare il portamento franco e anche di braveria di Fermo, bonario ma pronto a trasformarsi in iroso anche violento; una caratterizzazione del promesso sposo che sarà una costante in tutto il romanzo;
— presentare il carattere doppiamente vile di Don Abbondio che, prono all’obbedienza verso il forte, punta sulla propria superiorità culturale per rendere a sua volta obbediente Fermo, grazie all’uso del latino;
— rendere immediatamente esplicito l’impedimento al matrimonio, ossia l’imposizione del prepotente Don Rodrigo e l’ubbidienza del parroco vile: è infatti in quei pochi minuti burrascosi in casa del Curato che Fermo viene a sapere dal parroco stesso che è il signorotto a essersi messo di traverso al matrimonio.
In poche diecine di righe Manzoni evidenzia così al lettore alcuni degli elementi base del romanzo.
E che fa l’Epilogatore? Con quel suo incongruo “presentandosi gli Sposi”, pescato chissà dove, cancella il lavoro di Manzoni e raffigura una situazione assolutamente estranea al romanzo.
Difformità n. 2 — Invenzione originale.
10.3/ “Gli Sposi sono in ismania. Sospettano, che D. Rodrigo” …
La situazione — Rinviato dal parroco il matrimonio, che succede? che ne pensano i promessi sposi?
Vediamo come la cosa è raccontata nell’Epilogo (carta 2v, p. 4):
«Gli Sposi sono in ismania. Sospettano, che D. Rodrigo, Signore prepotente, che abitava un vicino [2v] castello, il quale aveva adocchiata Lucia per rapirsela, ne abbia fatte minacce al Paroco.»
Lo abbiamo già anticipato: l’Epilogatore sta evidentemente sunteggiando un altro testo.
“Sospettano” — In Manzoni gli Sposi non “sospettano“ proprio nulla: sono assolutamente certi che vi è stata da parte di Don Rodrigo la minaccia al parroco: è stato lo stesso Don Abbondio a confessarlo a Fermo.
“rapirsela” — Che c’entra? Nella “Prima Minuta” Don Rodrigo, all’inizio della vicenda, non aveva assolutamente alcuna idea di rapire proprio nessuno: voleva solo cercare di spassarsela con Lucia, come già avvenuto con successo con altre ragazze della filanda (è la stessa Lucia a raccontarlo alla Signora monaca).
Per soprammercato l’Epilogo ignora i propositi omicidiari che Fermo è quasi sul punto di portare a compimento, appena saputo dell’intrusione di Don Rodrigo nella sua vicenda d’amore.
Come si vede, l’Epilogatore dà un quadro narrativo decisamente difforme dalla “Prima Minuta” — e siamo solo agli inizi!
Il prosieguo dell’Epilogo stravolge infatti radicalmente sia la successione dei fatti come esposti da Manzoni sia i contenuti veicolati dai fatti stessi.
Difformità n. 3 — Invenzione originale.
10.4/ “Se e come possa il Paroco obbligarsi ad unirli” …
Per orientarsi — A fronte della prepotenza di Don Rodrigo sul curato, su suggerimento di Agnese (la madre della sposa), Fermo consulta l’avvocato Pettola di Lecco per averne consiglio.
Come si svolge l’incontro?
Sulla natura del consiglio richiesto, leggiamo l’Epilogo (carta 2v, p. 4, evidenziazioni nostre):
«Consultano un legale, se e come possa il Paroco obbligarsi ad unirli».
Come si vede, l’Epilogatore continua con il suo privatissimo percorso, estraneo alla “Prima Minuta”: ci sta dicendo che Fermo chiede all’avvocato Pettola se e in che modo è possibile obbligare il Parroco a fare il suo dovere, ossia a unire lui e Lucia in matrimonio.
Tutt’altra cosa scrive Manzoni (Tomo 1º, cap. 3, p. 37, evidenziazioni nostre):
«Ella ha da scusarmi signor dottore = noi altri poveri non abbiamo studio. Vorrei dunque sapere se a minacciare un curato, perchè non faccia un matrimonio c’è penale.»
È chiaro no?
Secondo l’Epilogatore, Fermo chiede all’avvocato se c’è un modo per obbligare Don Abbondio a celebrare le nozze.
Secondo Manzoni, Fermo chiede invece all’avvocato se è possibile perseguire Don Rodrigo per le sue minacce a Don Abbondio per costringerlo a NON celebrare le nozze!
Manzoni pone cioè esplicitamente per bocca di un membro del popolo minuto un problema, non del XVII secolo ma di tutti i secoli passati, presenti e buona parte dei futuri: il cittadino conculcato nei suoi diritti dalla violenza può ricorrere alla legge per difendersi e uscirne vittorioso?
Non è una cosina da poco ma l’Epilogatore batte tutt’altra strada!
Inutile insistere: il lettore ha già compreso come molti dei contenuti trasmessi dell’Epilogatore sono non solo diversi ma anche divergenti da quelli presentati da Manzoni.
Difformità n. 4 — Invenzione originale.
10.5/ “Si fanno progetti di sorprendere il paroco”…
Per orientarsi (leggendo Manzoni):
— mentre Fermo è dall’avvocato Pettola, Lucia pensa di consultarsi con il Padre Cristoforo (suo confessore) e lo convoca attraverso il frate questuante;
— Cristoforo si presenta subito prima che torni Fermo; tornato il giovane, si impegna con i tre a parlare con Don Rodrigo;
— mentre il Padre è al colloquio con il prepotente, Agnese e Fermo (con esitazioni di Lucia) pensano al matrimonio di sorpresa e Fermo, immediatamente, esce dalla casa e arruola i due testimoni;
— quando Padre Cristoforo ritorna con il risultato negativo del colloquio con Don Rodrigo, i tre (compresa Lucia) non gli dicono parola del piano ai danni del curato, concordato e già avviato.
Vediamo come invece la cosa è raccontata nell’Epilogo (carta 2v, p. 4):
«Si fanno quindi progetti di sorprendere il Paroco. Disputandosi però fra la madre di Lucia Agnese, Fermo, e la sposa, se fossero praticabili, e se leciti, si risolvono d’invocare l’assistenza d’un santo Capuccino / Padre Cristoforo / confessore della sposa.»
L’Epilogatore ci dice: tornato Fermo scornato dall’avvocato, i tre pensano a come gabbare Don Abbondio; in disaccordo se ciò è bene o meno, decidono di affidarsi a Padre Cristoforo.
Dalle parole dell’Epilogatore sembrerebbe quindi che si richieda l’intervento del frate per dirimere la questione: è lecito gabbare e forzare il parroco?
Come si vede, dopo l’inversione di senso nel rapporto con l’avvocato, anche la forzatura del parroco a sposare i due, dall’Epilogatore viene posta in modo nettamente divergente da Manzoni.
Infatti (lo abbiamo appena sopra ricordato) nella “Prima Minuta” di Manzoni le cose vanno in modo molto diverso: mentre Fermo è in missione dall’avvocato (un componente della struttura giuridica, lontana ed estranea ai tre popolani) Lucia pensa di ricorrere a un altro tipo di autorità, che a lei pare più vicina: quella morale incarnata nella Chiesa e, nello specifico, in Padre Cristoforo (il Cappuccino suo confessore), noto per la probità, lo spirito di giustizia e la disponibilità verso la gente del popolo.
Manzoni, attraverso la figura di Lucia (e in opposizione a Fermo e ad Agnese) propone quindi una soluzione “morale”, a prescindere da quanto dirà l’avvocato (ancora Lucia non sa dell’esito negativo dell’abboccamento di Fermo con Pettola).
È una prima caratterizzazione del ruolo giuocato da Lucia nell’intero romanzo — ma l’Epilogatore segue una traccia tutta sua.
Difformità n. 5 — Invenzione originale.
10.6/ “Rispettando nondimeno il carattere” …
A proposito del colloquio tra Padre Cristoforo e Don Rodrigo, leggiamo l’Epilogo (carta 3v, p. 6, evidenziazioni nostre):
«Congedati i commensali, D. Rodrigo riceve in disparte il Frate. Questi entra in proposito, e cerca di trargli il segreto, e, trattolo, di sconsigliare l’opposizione al matrimonio di Fermo, e Lucia. D. Rodrigo [4r] si adira; rimbrotta il Frate, e, rispettando nondimeno il carattere, lo rimanda.
Giunto il P. Cristoforo alla casa di Agnese narra il cattivo successo. Quindi smanie, furie, progetti. Il Frate cerca di metter calma; e, riservandosi a meglio consigliare, torna al Convento.»
È l’ennesima sintesi infedele della “Prima Minuta” di Manzoni:
— nell’Epilogo il frate è presentato come debole: “cerca di sconsigliare”;
— con quella frase «rispettando nondimeno il carattere, lo rimanda» anche Don Rodrigo è presentato come, in fondo, rispettoso della figura del religioso.
Nel meccanismo narrativo in Manzoni, le cose vanno però in tutt’altr’altro modo.
Nella “Prima Minuta” (e poi, senza mutamenti, nella Ventisettana e nella Quarantana) il dialogo tra i due è un urto in crescendo che culmina con la predizione di sventura e dannazione da parte del frate (T. 1º, cap. 6º, p. 81):
«Ho compassione di questa casa = ella è segnata dalla maledizione. State a vedere che la giustizia di Dio avrà rispetto a quattro pietre e a quattro scherani! Voi avete creduto che Dio abbia fatta una creatura a sua immagine per darvi il diletto di tormentarla! voi avete creduto che Dio non saprebbe difenderla contra voi! Vi siete giudicato. Ne ho visti di più sicuri, di più potenti, di più temuti di voi; e mentre agguantavano la loro preda, mentre non avevano altro timore che di vederla fuggire, la mano di Dio si allungava in silenzio dietro alle loro spalle per coglierli. Lucia è sicura di voi, ve lo dico io povero frate, | e quanto a voi, verrà un giorno…»
e con la minaccia esplicita di vie di fatto da parte di don Rodrigo (T. 1º, cap. 6º, p. 82):
«Villan rifatto! proseguì D. Rodrigo: così rimeriti accoglienze alle quali non sei avvezzo, e che non son fatte per te: ma tu adoperi da par tuo. Ringrazia quel sajo che ti copre quelle spalle di paltoniere, e ti salva dalle carezze che si fanno ai pari tuoi per insegnar loro a parlare. Esci colle tue gambe per questa volta; e la vedremo.»
In Manzoni, il dialogo tra i due personaggi drammatizza la situazione e la presenta come senza via di uscita (tale comunque da autorizzare moralmente l’iniziativa diretta da parte dei promessi sposi).
Nell’Epilogo, invece, il contrasto è decisamente ammorbidito.
L’Epilogatore manca inoltre di ricordare due elementi della macchina narrativa di Manzoni: all’uscita dal colloquio tempestoso con Don Rodrigo, Padre Cristoforo è avvicinato da un servo di casa che gli promette di informarlo degli sviluppi della situazione (sarà questo servo ad avvertire che al palazzo di Don Rodrigo si prepara per la notte successiva il rapimento di Lucia, guidato dal Griso e poi fallito).
In Manzoni questo particolare ha una importanza non solo narrativa: è la prima occasione in cui lo scrittore ci propone la sua idea di Provvidenza: il servo anziano di Don Rodrigo è un segnale di conferma della bontà dell’impegno del Frate a favore dei promessi sposi.
È questo ovviamente un elemento che una figura vicina a Manzoni (quale viene presentato da Paola Italia l’Epilogatore) non avrebbe potuto ignorare.
Il secondo elemento è la richiesta da parte di Padre Cristoforo ai tre di mandare al convento di Pescarenico un loro messaggero che possa riportare le sue indicazioni sul da farsi. Questo messaggero sarà Menico che svolgerà poche ore dopo un ruolo importante.
Senza questi due elementi, apparentemente marginali, non si comprende nulla degli sviluppi della notte degli inganni.
E infatti l’Epilogatore anche sull’andamento di quella notte tradisce in più punti l’opera che, secondo Paola Italia, egli invece riporterebbe in sintesi fedelissima.
Difformità n. 6 — Dalla “Seconda Minuta”.
10.7/ “D’altra parte viene avviso dalla casa di Agnese” …
Riassumiamo i precedenti (prendendoli da Manzoni): nell’imminenza del matrimonio a sorpresa, all’imbrunire, Fermo porta all’osteria i due fratelli/testimoni per una breve cena. Qui trovano raccolti i Bravi di Don Rodrigo (fatti gli opportuni sopraluoghi la mattina, il loro piano è di entrare di notte nella casa di Lucia e di rapirla).
Terminata la breve cena, Fermo e Lucia con i due testimoni (mentre Agnese distrae Perpetua) entrano nella casa di Don Abbondio per sposarsi da sé; quasi ci riescono; per la pronta reazione del parroco devono però svignarsela in strada; Fermo, Lucia e Agnese si muovono di fretta verso la casa di Agnese; il sagrestano suona la campana a martello…
Vediamo come prosegue l’Epilogo (carta 4v/5r, p. 8 / 9):
«Questo improviso romore viene opportuno per isgomentare [5r] i Bravi di D. Rodrigo appostati quella sera per rapire Lucia, onde fuggono temendosi scoperti, e che si suoni l’allarme contro di essi. D’altra parte viene avviso dalla casa d’Agnese, che non vi si vada, e si vada invece al Convento de’ Capuccini.»
L’Epilogatore ci dice quindi:
-
- che i Bravi appostati fuggono;
- che dalla casa di Agnese si avvertono gli sposi (in fuga verso quella stessa casa) di non tornarvi e di andare invece al convento di Pescarenico.
Ognuno sa che il termine “appostati” sta a indicare chi, nascosto, prepara una insidia (si appostano gli animali in cerca di preda, così come si appostano gli uomini per un’aggressione o uno scontro): l’Epilogatore non ci dice dove fossero appostati i Bravi ma il suo richiamo “all’avviso dalla casa di Agnese” fa comprendere come per lui i Bravi fossero “appostati” nella casa di Agnese o nelle sue immediate vicinanze (la casa era un poco isolata dal paese).
L’Epilogatore non ci dice neppure chi avverte gli sposi, se non che questo qualcuno viene dalla casa di Agnese (e che quindi lì — o lì vicino — ha visto i Bravi “appostati”) — grande confusione quindi.
Manzoni è invece molto chiaro (“Prima Minuta”, T. 1º, cap. 8º, p. 110)
«Ma in mezzo ai paesani si videro passare in ordine di battaglia alcuni armati e di sinistro aspetto: erano gli amici che abbiam già veduti all’osteria. […]
Ma i tre personaggi che c’interessano nascondendosi quanto potevano, non rispondendo alle inchieste e fuggendo la folla erano sulla via che conduceva alla casa di Lucia; quando un garzoncello che andava guardando attentamente tutti quelli che passavano, al vederli, mise un sospiro che pareva volesse dire: gli ho trovati una volta; si pose dinanzi a loro, pigliò Agnese pel lembo della veste, e disse con voce bassa e affannata: Tornate indietro per amor del cielo. Era Menico, e fu tosto riconosciuto. – Perchè? dissero tutti e tre. – Indietro, indietro, vi dico non tornate a casa, venite al convento; così mi ha detto il padre Cristoforo.»
Secondo Manzoni quindi:
— quando suona l’allarme campanaro, i Bravi erano ancora all’osteria (non alla casa di Agnese o in qualche luogo lì vicino);
— Menico dice agli Sposi di non andare a casa — perché lo ha detto Padre Cristoforo! — non perché egli vi abbia visto alcunché di sospetto.
Il lettore sa che su questo punto già nella “Seconda Minuta” (quella che Raboni nel 2012 pubblicò con il titolo “Gli Sposi promessi” — che ridicola girandola di titoli!) Manzoni apporterà una opportuna modifica: mandato dal Padre Cristoforo, Menico va alla casa di Agnese per avvertire che lì vi sarà l’aggressione dei Bravi; si accorge che i Bravi sono già nella casa; da loro non visto si precipita dal campanaro per dare l’allarme; per strada incontra Agnese e subito dopo gli Sposi, usciti a precipizio dalla casa del curato.
Nella Ventisettana (e nella Quarantana) Manzoni modifica ancora: mandato dal Frate, Menico va alla casa di Agnese per avvertire che vi sarà l’aggressione dei Bravi; qui è preso dagli sgherri già in agguato dentro la casa; riesce a sfuggire per la loro sorpresa al sentire la campana; per strada incontra i tre che stanno ritornando verso quella stessa casa.
Nel corso della stesura Manzoni quindi cambia il quadro narrativo ma — ripetiamo — nella “Prima Minuta” Menico NON è affatto andato alla casa di Agnese né tantomeno ci erano andati i Bravi, cosa che invece è adombrata (ma in confuso) dall’Epilogatore.
Facile pensare che questi conoscesse almeno la versione della vicenda data da Manzoni nella “Seconda Minuta” nella quale (ripetiamolo) Menico si affaccia alla casa di Agnese; si accorge della presenza dei Bravi; ne esce e corre verso la chiesa incontrando i tre in fuga.
Inevitabile pensare che l’Epilogo sia stato steso non PRIMA delle correzioni della “Prima Minuta” (come sostenuto da Paola Italia) ma DOPO di esse.
Quando? almeno quando già Manzoni aveva cominciato a modificare lo schema dell’episodio, ossia a Seconda Minuta già bene avviata.
Ma non è finita.
Difformità n. 7 — Invenzione originale.
10.8/ “e i testimoni si recano al Convento” …
L’Epilogo continua (carta 5r, p. 9):
«Quindi Agnese con Fermo, e Lucia, ed i testimoni si recano al Convento posto in disparte, ed ivi, fatti entrare in Chiesa, trovano il P. Cristoforo, che gli avverte di salvarsi colla fuga, e gli indirizza, dove aveva già disposta una barca per tragittarli, avvertendoli dove troverebbero guida per recarsi a salvezza, dove egli con lettera gli scortava.
Partono dunque Agnese, Fermo, e Lucia pieni di doglia, dopo avere raccomandato ai testimoni di nulla rivelare dell’occorso.
Fermi tutti!
Da dove saltano fuori questi “testimoni” che, secondo l’Epilogatore, sarebbero andati al Convento assieme ai due tentati sposi e ad Agnese, per esserne poi raccomandati di tacere?
Dalla “Prima Minuta”, alla “Seconda”, alla Ventisettana, alla Quarantana, Manzoni ci ha sempre detto che nella fuga dal paese verso il convento di Pescarenico, i nostri tre personaggi (i quasi sposi + Agnese) erano accompagnati solo da Menico. Il quale era testimone solo di un pezzo della vicenda: Menico (così come Padre Cristoforo del resto — e tutto il paese) non sa nulla del tentato matrimonio fai-da-te.
E quindi?
È chiaro che questa ulteriore macroscopica differenza tra Epilogo del «Manoscritto Lecco 170» e tutto ciò che su questo particolare della notte degli inganni ci ha lasciato Manzoni, pone un bel problema.
Ma andiamo avanti e arriviamo al rapimento di Lucia su cui abbiamo due rilevanti difformità di fatto.
11. Difformità sul rapimento di Lucia.
Difformità n. 8 — Invenzione originale.
11.1/ La lettera inesistente …
Per orientarsi — Lucia è ricoverata presso il convento di clausura di Monza, teoricamente sotto la protezione della Signora monaca. La quale in realtà è amante e complice di Egidio, sodale del Conte del Sagrato, assoldato da Don Rodrigo per il ratto della giovane promessa sposa.
Il quale ratto, come viene architettato?
Nell’Epilogo è scritto (carta 7r):
«Lucia frattanto, spedita colla lettera al Capuccino viene arrestata per via, messa in vettura per forza, e condotta dai Bravi del Conte Sagrato al di lui Castello.»
L’Epilogatore ci dice, quindi, che Lucia viene indotta (immaginiamo dalla Signora, l’Epilogo ne tace) a uscire dal convento perché consegni una lettera al Padre Capuccino che pochi giorni prima ve l’ha condotta.
Nella “Prima Minuta” (e in tutte le successive versioni del romanzo) di questa lettera non si fa mai alcuna menzione.
Nella “Prima Minuta” Manzoni riporta in dettaglio il tradimento di Lucia da parte della Signora: deve parlare con il padre guardiano dei Cappuccini; non ha nessuno di fidato per chiamarlo; vada Lucia a fare l’ambasciata.
Leggiamo il testo (T. 2, cap. 9, 93b, p. 243):
«Geltrude ripetendo la lezione del suo infernale maestro cominciò ad impastocchiarla con una storia misteriosa, […] e terminò con dire che le bisognava in quel momento un uomo da cui potesse aspettarsi un consiglio fidato, […] era quel padre guardiano dal quale Lucia era stata scorta al monastero; che ella aveva bisogno di parlare con lui ma che le mancava il mezzo di farlo avvertire con sicurezza,[…] era necessario che Lucia prendesse un po’ di risoluzione, si snighittisse, e facesse tosto, e segretamente e sola questa commissione.»
Nella “Prima Minuta” Manzoni quindi non dice in chiaro come si dovrà estrinsecare questa ambasciata, non scrive né di lettera né di altro.
Ma in tutte le successive rielaborazioni, forse cogliendo una più che prevedibile domanda su questo dettaglio, chiarisce che l’ambasciata sarà a voce.
In “Gli Sposi promessi” (T. 2, cap. 20, c. 104d; p. 292) e in “Promessi Sposi” 1827 (p. T.2, p. 230), ce lo scrive esattamente allo stesso modo (p. 292):
«Andate al convento de’ cappuccini,» e le descrisse la strada di nuovo: «fate chiamare il padre guardiano, ditegli che venga da me tosto tosto.»
In “I Promessi Sposi” 1840 (p. 385), lo ripete, con lieve variante:
«Andate al convento del cappuccini» e le descrisse la strada di nuovo: «fate chiamare il padre guardiano, ditegli, da solo a solo, che venga da me subito subito».
Lucia è quindi inviata dalla Signora per un’ambasciata: dire al Padre, da parte della Signora, di recarsi al Convento per parlare con la Signora stessa di cose importanti per Lucia.
In “Prima Minuta” senza alcuna specificazione del come; in tutte le altre versioni, esplicitamente, con una ambasciata a voce.
L’Epilogatore, quindi, o si è inventato egli stesso questo particolare della lettera, oppure ha riassunto da un qualche cosa dove si parlava di lettera.
Oppure, da epilogatore scalcagnato, ha mal ricordato cose sentite o lette distrattamente.
Infatti nella “Prima Minuta” si parla sì di una “lettera al Padre Cappuccino” — ma si tratta della lettera di raccomandazione del Padre Cristoforo all’amico e correligionario di Monza, cui affida Lucia e Agnese, da Manzoni citata 120 pagine prima:
(T. 2, cap. 2, 5b, p. 128):
«La madre e la figlia si trovavano dunque, dopo la partenza di Fermo, solette in una osteria di Monza, senza alcuna pratica del paese, senza alcuna conoscenza, non avendo in così alto mare altra bussola che la lettera del Padre Cristoforo. La lettera era diretta al Padre Guardiano dei Cappuccini.»
Siamo quindi, eventualmente, di fronte a un conclamato caso di marasma epilogatorio.
D’altra parte, sul piano narrativo (e della semplice logica del tradimento), l’Epilogatore non dà in questa occasione (come in altre) prova di grande perspicuità.
È infatti un evidente non senso pensare che la Signora potesse avere dato a Lucia uno scritto di proprio pugno, dal quale avrebbe potuto emergere lampante la sua complicità nel rapimento.
Ricordiamo che Manzoni, anche quando avrà optato decisamente per la “ambasciata a voce”, richiamerà l’attenzione su questo aspetto: quando la Signora viene a sapere del mutamento del Conte, il suo primo pensiero sarà proprio che Lucia potrà denunciarla come evidente complice del ratto.
E in effetti, quando Federigo interrogherà Lucia su quanto avvenuto, benché la giovane non esprima una chiara accusa, al Cardinale apparirà subito sospetto il ruolo della Signora.
Sarà certo anche questo uno dei motivi per cui, come illustrato in dettaglio poco più avanti da Manzoni nella “Prima Minuta”, egli andrà a fare visita al convento della Signora, avviando la scoperta dell’intreccio erotico-criminale sviluppatosi nel Convento; il trasferimento della Signora; l’epilogo delittuoso di tutta la tresca a opera di Egidio; la morte violenta di quest’ultimo.
Ovvio che se, attraverso il Conte, fosse giunta al Cardinale una lettera di pugno della Signora (una patente confessione di correità nel rapimento), lo schema narrativo seguito da Manzoni sarebbe stato tutto un altro.
E veniamo alla seconda difformità nell’episodio del rapimento di Lucia (ma siamo al n. 9 nell’elenco generale).
Difformità n. 9 — Ripresa da “I Promessi Sposi”.
11.2/ Un fiume scomparso e una vecchia fuori tempo.
In Epilogo, Lucia rapita è:
«condotta dai Bravi del Conte Sagrato al di lui Castello. Qui viene consegnata ad una trista vecchia».
Questa versione è la medesima che troviamo già in “Gli Sposi Promessi” (Raboni, 2012), poi nella Ventisettana (e nella Quarantana).
Ma nella “Prima Minuta” la storia è invece parecchio diversa: abbiamo in più l’Adda e la vecchia che vi compare anzitempo (T. 2, Cap. 10, c. 17):
«Era l’Adda infatti a cui la carrozza si avvicinava […] Lucia | vedendo che si stava per fare qualche cosa da cui doveva decidersi il suo destino, ricominciò le sue preghiere, […] La carrozza si fermò presso la riva, quel della serpe fece un segno a cui fu risposto dal battello, e tosto ne uscirono tre bravi con una vecchia, e si avviarono verso la carrozza.»
(T. 2, Cap. 10, c. 26):
«Guardò intorno e non vide altro che la boscaglia la riva e il fiume e il battello; alzò gli occhi, e vide al di sopra delle cime dei monti la cima tagliata a sega del Resegone […] quasi fuor di se, fu posta a sedere nel battello sotto la tenda: la vecchia le si pose acanto: il capo di quelli che erano venuti in carrozza saltò pure nel battello, stette al di fuori coi bravi venuti per acqua; i quali tosto puntati i remi alla riva ne fecero allontanare il battello, pigliarono l’alto del fiume, diedero dei remi nell’acqua e il battello partì.»
(T. 2, Cap. 10, c. 28):
«Lucia ricominciò a pregare Colui che ode anche quando non risponde, si abbandonò alla sua provvidenza. Dopo forse due altre ore di viaggio il battello approdò: la notte precipitava, e Lucia sbigottita, tremante […] fu tolta in questo stato dal battello, posta in una lettiga, e portata al castello del Conte del Sagrato.
La vecchia accompagnava la lettiga, entrò insieme in casa, la fece deporre in una stanza, dove rimase sola con Lucia».
Quindi, nella “Prima Minuta”, Lucia, vecchia e Bravi risalgono in barca l’Adda per un paio d’ore; sbarcano; salgono al castello del Conte in lettiga.
Parecchio diverso, vero, dall’Epilogo? E da tutte le successive versioni del romanzo, dove mai l’Adda è accostato al rapimento di Lucia.
Anche per questa difformità, l’Epilogatore ha ripreso forse il racconto di Manzoni quale è riportato nelle tre versioni successive — ma di sicuro NON dalla “Prima Minuta”.
Passiamo ora al Conte del Sagrato.
Nel lungo episodio riguardante il mutamento del Conte e la liberazione di Lucia, abbiamo ben tre difformità di fatto tra l’Epilogo e la “Prima Minuta” di Manzoni.
12. Sul Conte, marasma epilogatorio.
Difformità n. 10 — Omogenea al film di Camerini, 1941
12.1/ La terrazza inventata.
La situazione — Siamo alle soglie del mutamento d’animo del Conte del Sagrato; dopo il dialogo con Lucia il Conte passa una notte insonne rimuginando pensieri già suoi da tempo; al mattino guarda nella valle l’accorrere del popolo a incontrare il Cardinale Borromeo.
Da dove guarda il Conte?
Nell’Epilogo è scritto (carta 7v, evidenziazioni nostre):
«Alzatosi il Conte, […] vede dalla terrazza la folla del popolo, che trae a far omaggio al Card.le Federico Borromeo in visita a Chiuso».
Domanda: cosa è una terrazza? Vediamo che ne dice Treccani:
«terrazza s. f. [dal fr. terrasse, che ha lo stesso etimo dell’ital. terrazzo]. – 1. Ripiano scoperto d’un edificio, per lo più praticabile, delimitato in tutto o in parte dal suo perimetro; in partic., il ripiano di copertura dell’edificio […]»
E che dice Treccani per “finestra”:
«finèstra (ant. fenèstra) s. f. [lat. fenĕstra]. – 1. a. Apertura nei muri esterni di un edificio, destinata a dare luce e aria agli ambienti interni e a consentire la vista da questi ultimi verso l’esterno […]».
Nell’esperienza plurimillenaria delle strutture edilizie, quindi, “finestra” e “terrazza” non sono assimilabili, neppure alla lontana: si tratta di elementi né confrontabili né confondibili.
Ciò chiarito, torniamo a noi.
L’ambiente da cui — secondo l’Epilogo — il Conte del Sagrato, in procinto di cambiar vita, guarda la valle sottostante al suo castello, va benissimo in sé: una terrazza è perfetta per guardare dall’alto di un castello.
Il problema è che in tutta la “Prima Minuta” di Manzoni non c’è neppure un cenno a terrazze di alcun tipo e, nel caso del Conte del Sagrato in procinto di mutar vita, si parla solo di una “finestra” (T. 2, cap. 10, c. 108c; p. 267):
«Si alzò, si vestì rapidamente, e prima d’andare alla stanza di Lucia (che la risoluzione gliene era rimasta) si fece alla finestra della sua stanza»;
idem, 108d, p. 267:
«Il Conte congedò con un cenno del capo il fidato, e rimase ancora un momento alla finestra a guardare; dicendo fra se: Come sono contenti costoro! E perchè?»
Nella “Prima Minuta, quindi, “finestra”, non “terrazza”.
D’altra parte, anche in tutte le successive diverse versioni del romanzo, abbiamo sempre finestre e mai terrazze.
— “Gli Sposi promessi” (Colli, Raboni, 2012):
«andò ad aprire le imposte d’una finestra e guardò giù.».
— “I Promessi Sposi”, Ferrario 1825-27, Tomo 2, p. 268:
«andò ad aprire le imposte d’una finestra, e guardò.»
— “I Promessi Sposi — Edizione riveduta”, Redaelli 1840:
«Saltò fuori da quel covile di pruni; e vestitosi a mezzo, corse a aprire una finestra, e guardò.»
Da dove salta fuori quindi quella “terrazza” dell’Epilogo?
Chiediamo al lettore un attimo di attenzione in quanto la questione è meno banale di quanto sembri.
Se sul piano funzionale è chiaro che una terrazza vale quanto — e anche più — di una finestra per guardare alcunché dall’alto, è altrettanto chiaro che la diversità nella fruizione, in una opera letteraria può implicare una diversità di contenuti narrativi.
12.2/ “Finestre” e “finestra” in Manzoni.
Nella “Prima Minuta” di Manzoni il termine “finestre” (al plurale quindi) compare per 22 occorrenze; per 33 occorrenze al singolare: “finestra”.
Al plurale — FINESTRE — il termine indica il più delle volte (con ovvie eccezioni naturalmente) gli elementi di un edificio (negozio, convento, abitazione che sia) considerati dal punto di vista di chi “sta fuori” dall’edificio stesso e vuole entrarvi, il più delle volte con cattive intenzioni: sono una delle vie preferite per chi voglia introdurvisi di forza e violarne l’intimità.
Che siano manifestanti all’assalto dei forni; aspiranti omicidi alla caccia del Vicario di Provvisione; reclusi al lazzeretto che rimpiangono di non potere gettare schifezze carnevalesche nelle case dei signori, è sempre alle finestre che pensano o guardano per una azione negativa.
Al singolare — FINESTRA — ha invece il più delle volte la funzione opposta: è il mezzo attraverso cui chi è all’interno dell’edificio si mette in comunicazione con l’esterno.
Facendo cosa?
O gettando nell’ambiente sottostante polveri venefiche (e anche cadaveri) come nella Milano appestata.
O affacciandosi per interagire con l’esterno (Perpetua e Don Abbondio nella notte degli imbrogli; la signora Ghita con Fermo alla ricerca di Lucia, ecc.).
O per rubare il tempo alle novità (Don Rodrigo che si fa alla finestra per vedere se compare il Griso con la preda).
Oppure …
Oppure guardando attraverso di essa un alcunché di esterno ma rimanendo in se stessi: guardo fuori per vedere che succede o cosa vi è al di là del vetro; ma io sono dentro, al chiuso, al sicuro; posso guardare senza essere visto.
È il caso della Geltrude monaca all’inizio dell’innamoramento per Egidio: la finestra le conferma (senza esserne vista) dell’interesse per lei del bel giovanotto senza scrupoli.
Ed è il caso del Conte del Sagrato / l’innominato: egli è nella sua stanza (nella medesima dove ha passato in rassegna il suo vergognoso passato) ed è ancora preso dai suoi pensieri angosciosi.
Attraverso la finestra egli vede la valle, il movimento degli uomini, la luce del giorno per tutti e la speranza della luce per sé.
Ma non è ancora all’aperto e aperto agli altri; è ancora al chiuso, in se stesso, seppure con una prima apertura all’esterno, simbolizzata da quella finestra.
È facile notare da questi due esempi come in Manzoni la “finestra” possa dunque avere una funzione di mediazione tra una condizione psicologica di chiusura e un’altra diversa, di apertura verso l’esterno — che sia un uomo da amare come nel caso della Signora, o una vita nuova come per il Conte, poco importa.
E allora perché nell’Epilogo si parla di “terrazza” e non di “finestra”?
La cosa è curiosa perché nella storia della “riduzioni”, più o meno artistiche, del romanzo di Manzoni, c’è un caso (sicuramente più noto dell’Epilogo del «Manoscritto Lecco 170») nel quale viene operata la medesima sostituzione.
12.3/ “La “terrazza” ne “I Promessi Sposi” di Mario Camerini del 1941.
Nel suo film “I Promessi Sposi” del 1941, prodotto e distribuito dalla Lux Film in occasione del 100esimo della pubblicazione della Quarantana, Camerini si muove lungo quella che a prima vista sembra solo la strada più comoda per un regista cinematografico ma nella quale — a più attenta analisi — è più che evidente uno scostamento strutturale da Manzoni.





Allo spettatore sono proposte alcune sequenze decisamente “innovative” rispetto al romanzo (in qualsivoglia delle sue redazioni):
a/ immediatamente dopo avere parlato con Lucia, l’innominato esce dalla stanza e, percorso un breve corridoio, arriva sul terrazzo alla sommità del suo castello; lo segue l’anziana serva;
b/ rimasta sola, Lucia pronuncia il voto di castità;
c/ dalla terrazza l’innominato guarda la moltitudine che si snoda verso Chiuso;
d/ lo raggiunge l’anziana serva: «non andate a dormire signore?» — «dove va quella canaglia?» — «vanno incontro al Cardinale Borromeo»; l’innominato la congeda bruscamente;
d/ gran scampanio da tutte le chiese della zona; l’innominato continua a guardare nella valle; la folla si concentra attorno alla chiesa nella quale il Cardinale è mostrato inginocchiato; l’innominato è mostrato già nella sagrestia.
Guardando queste scene, anche il più distratto lettore di Manzoni comprende che Camerini più che la cinepresa ha usato le forbici: nulla, né nel volto del burbero Carlo Ninchi né nei suoi atteggiamenti, fa pensare che nel masnadiero vi sia non diciamo un mutamento d’animo ma neppure una qualsivoglia riflessione.
E, in effetti, da Camerini l’innominato non è mai rappresentato, neppure per un istante, nel chiuso della propria stanza (ossia solo con se stesso).
È rappresentato esclusivamente all’aperto, nel suo fissare la valle, che sia appena spuntata la deserta alba oppure nel primo mattino, quando la popolazione si muove verso Chiuso
E la sempre citata lunga notte insonne dell’innominato, descritta da Manzoni in sei fitte pagine, dove è andata finire?
12.4/ Come nasce e si afferma il mutamento?
In Manzoni (in tutte le diverse stesure, a parte le varianti stilistiche o di accentuazione — per esempio nella “Prima Minuta” non compare affatto l’idea del suicidio) il mutamento dell’innominato è — come tutti i moti profondi nell’uomo — un processo lungo, anche se a lungo inconsapevole.
L’innominato già da tempo sente il peso della sua scelta di vita e la spinta verso un cambiamento.
Quel suo essere attore e complice nel delitto gli appare sempre più come un tradimento del suo essere uomo; sente confusamente che così non può andare avanti.
L’incontro con Lucia, così estranea a qualsiasi colpa, così in balia di volontà prevaricatrici da lei incontrastabili, gli fa scattare il meccanismo di revisione; è una spinta ad affrontare quanto egli già da tempo medita nel suo intimo.
Nella notte insonne, tutti i pensieri maturati nel tempo riemergono e si impongono per una soluzione che egli ancora non sa quale possa essere.
Guarda dalla finestra e vede la collettività festante, da cui si sente escluso: forse là, in quel nucleo di positività, è la soluzione.
La finestra è quindi il punto di collegamento tra il proprio stato interiore e la soluzione che può esser data solo dall’appartenenza onesta e pulita alla collettività.
Ecco perché la finestra — in sé e per sé assolutamente anonima — in questo processo è così importante ed è consapevolmente utilizzata da Manzoni.
12.5/ La censura di Camerini, a pro’ dell’autorità esclusiva della Chiesa?
In Camerini si ha quindi un taglio radicale nella narrazione di Manzoni: è stata cancellata la lunga e complessa descrizione del processo interiore di mutamento attraverso cui l’innominato giunge da sé alla nuova vita, prima ancora di avere incontrato il Cardinale, il quale è solo l’autorevole tramite che rende sociale e collettivo il processo di maturazione interna.
Al processo di mutamento interiore e autonomo dell’innominato, Camerini sostituisce invece l’intervento salvifico del Cardinale Borromeo.
In Camerini — e in tutti i suoi ispiratori, collaboratori e sodali di allora e di oggi — il mutamento dell’innominato è posto quindi come promanare esclusivamente dall’autorità della Chiesa: l’innominato cattivo si presenta al Cardinale e diventa istantaneamente buono (semplifichiamo, naturalmente, ma il meccanismo proposto è questo).
È chiaro che si tratta di una inversione rispetto a Manzoni che vede nell’autorità della Chiesa la conferma di un processo di maturazione interiore che non può che essere individuale.
Non si tratta quindi di finestre o di terrazze: si tratta di due modi diversi di rappresentare il ruolo della Chiesa e del rapporto del fedele con essa.
Non è difficile pensare che Camerini e collaboratori alla sceneggiatura non fossero per nulla consapevoli delle implicazioni del loro sostituire in quel modo “terrazza” a “finestra”.
Ed è del tutto possibile che essi fossero mossi solo dall’uso più facile e spettacolare della terrazza come luogo di visione dall’alto.
Ma possiamo dire lo stesso dell’Epilogatore del «Manoscritto Lecco 170»?
Stando alla Prof. Paola Italia l’estensore dell’Epilogo sarebbe stato della cerchia stretta amicale e familiare di Manzoni.
E quindi, perché, ha operato quella del tutto gratuita sostituzione?
La domenica, dopo essersi ricreato con Don Lisander, andava forse al cinema?
Scherziamo naturalmente (ma non troppo).
Ma mentre scherziamo, a margine, possiamo notare che degli altri tre film dedicati a “I Promessi Sposi” nel secolo scorso:
— Bonnard (1922) è rimasto fedele a Manzoni (la notte agitata dell’innominato; la tentazione del suicidio e poi, lo sguardo attraverso la finestra);
— Bolchi (1969) si è mosso sulla scia di Camerini (anche Salvo Randone guarda da una terrazza, agitato da pensieri);
— Nocita (1989) ha ignorato il problema: né terrazza né finestra: dopo avere lungamente illustrata l’angoscia notturna di Murray Abraham, ce lo fa vedere già in paese, a cavallo.
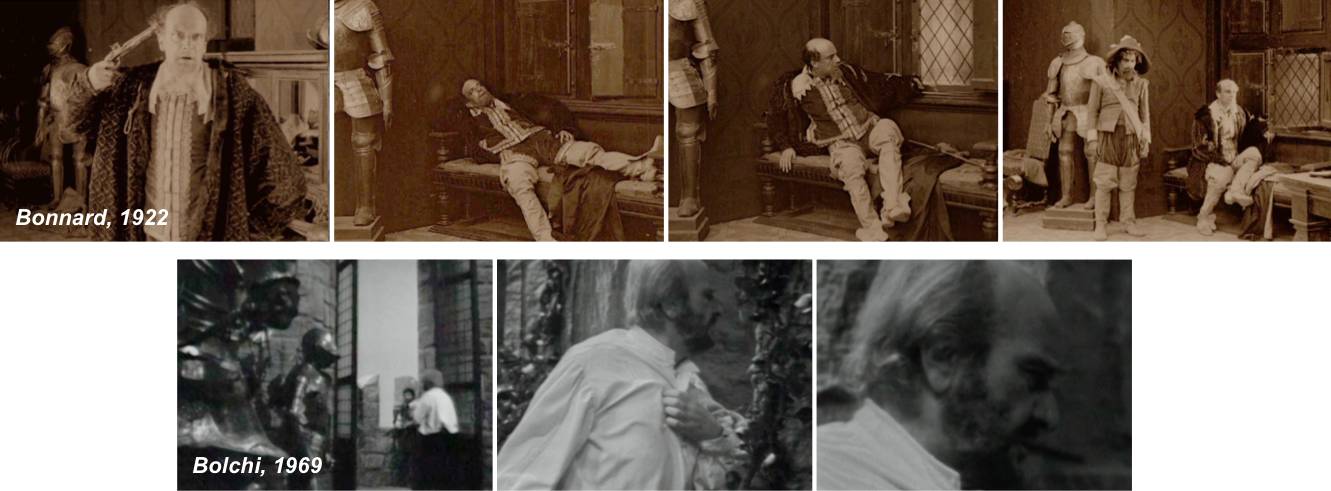






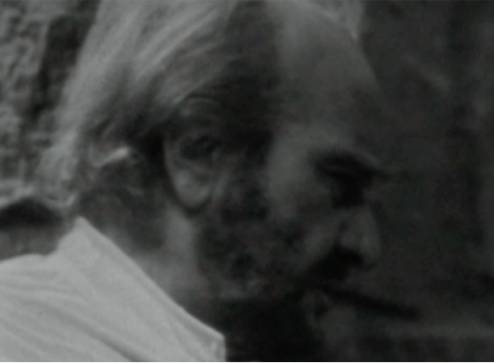
Difformità n. 11 — Ripresa da “I Promessi Sposi”.
12.6/ “Viene onestamente congedata” …
Sulla liberazione di Lucia da parte del Conte del Sagrato, in Epilogo così si scrive (carta 8r):
«Destatasi la vecchia custode cerca frattanto di rallegrare Lucia, ma invano, finché giunge l’avviso della libertà concessa, e sopragiunge la scorta, che dee condurla. Essa parte onestamente congedata.»
Cosa ogni lettore è indotto a intendere con questo “parte onestamente congedata”, proposto dall’Epilogo?
Più o meno che il Conte, divenuto buono, faccia venire a prendere Lucia con un taxi dell’epoca, a cavalli; si scusi con lei per il disturbo arrecatole; le dia dei quattrini per risarcirla delle tribolazioni; la saluti con affetto, assicurandole anche in futuro la sua protezione, e arrivederci!
Ma è così che il Manzoni presenta la vicenda nella “Prima Minuta”?
Niente affatto: nella “Prima Minuta” le cose vengono raccontate proprio all’opposto.
È facile verificarlo leggendo le due pagine che Manzoni dedica al come Lucia riesce ad uscire dal castello del Conte (T. 3, cap. 2, c. 15; p. 300) ed è ancora più facile leggendo questa nostra brevissima sintesi che riprende i pensieri del Conte mentre ritorna al proprio castello dopo il colloquio con Federigo e la conseguente determinazione di lasciare libera Lucia:
«Guaj se costoro, credono ch’io non sia più quello da stendere in terra colui che ardisse resistermi! […] pose macchinalmente la mano al luogo dov’era solito tenere una pistola, e si ricordò di averle lasciate con le altre armi in casa del curato […] quello che importa è di non far parole, di non perder tempo […] Se in questa casa […] cessa la disciplina, il terrore del padrone, diventa un inferno! […] Bisogna dissimulare […]. Così pensando […] si avvicinò alla lettiga, e […] disse sottovoce: non dite parola che a quella poveretta […]. Voi entrerete nella stanza […] le direte che siete venuta a liberarla; […] la lettiga verrà nella stanza, e ripartiremo tosto. Il Conte […] si avvicinò alla mula di D. Abbondio […] e gli disse sotto voce: Signor Curato […] è necessaria una prudenza che io solo pur troppo posso conoscere appieno. Se le sta a cuore la riuscita […] non dica parola […] nè di quello che si vuol fare, nè di quello ch’io penso. […] .
Il Conte salì di nuovo su la mula, e volto ai lettighieri, e ai palafrenieri disse loro: Silenzio, e obbedienza: non dite nè rispondete una parola in quel castello: […] non fiatate, perchè potreste far molto male a voi e ad altri. Andiamo. I lettighieri che deposta la lettiga avevano ascoltata a bocca aperta questa arringa, ripresero le cinghie su le spalle, continuarono la loro strada, le mule seguirono; e si giunse alla porta del castello.»
(T. 3, cap. 2, c. 60; p. 308):
«[…] ma quello che portava al sommo il loro stupore si era di vedere il loro padrone senz’armi. Quella partenza aveva dato luogo a molte congetture, […] ma il ritorno invece di soddisfare la curiosità la cresceva […] Alla porta […] il Conte […] si avviò alla stanza dov’era Lucia, in quella che le era vicina […] comandò che la lettiga fosse posta a terra. […] disse sotto voce, in modo da non essere inteso che da quelli che lo vedevano: In quella stanza è la giovane da condursi via […] voi entrate, e voi pure Sig.r Curato. […] la cosa deve passare quietamente; non perdete tempo […] quando è disposta, […] la lettiga verrà nella stanza = fatela sedere in essa, ponetevi al suo fianco, tirate le cortine, […] io vi aspetto = andrò innanzi, poi la lettiga, poi il signor curato; dritto alla porta; quivi saliremo sulle nostre mule, e ripartiremo. E voi, disse rivolto ai lettighieri: zitti. […] Lucia vi entrò, e la buona donna dopo lei, si tirarono le cortine, i lettighieri uscirono, il curato dietro […] Nel cortile, alla porta del castello, il Conte e il Curato a cavallo, la lettiga davanti, giù per la discesa, e dritto a Chiuso. […] la buona donna raccomandò a Lucia di non parlare finch’ella non gliene desse avviso. Ma poi che dallo scalpito delle mule che seguivano s’accorse che era varcata la soglia, cominciò a guardare un po’ fuori delle cortine, e vista la strada libera, ruppe ella stessa il silenzio dicendo a Lucia: Povera giovane! l’avete passata brutta! Ma Dio ha pensato a voi, e tutto è finito.»
Manca solo la musica di Ennio Morricone, in vista di uno scanna scanna all’arma bianca.
Lucia quindi lascia il castello nascosta in una lettiga, all’insaputa di tutti tranne che del Conte, della buona donna, di Don Abbondio e dei lettighieri.
Lucia non è affatto “onestamente congedata”, ma nascostamente fatta fuggire; rapita un’altra volta, questa volta dal rapitore fatto nuovo e buono che la rapisce al vecchio se stesso.
In realtà l’Epilogatore, per tutto questo episodio di non poco conto, si è rifatto non alla “Prima Minuta” ma a “I Promessi Sposi” del 1827 e poi del 1840.
Nella stesura definitiva del romanzo Lucia è infatti liberata dall’innominato non di nascosto ma in modo “normale”, proprio come indicato nell’Epilogo.
Infatti ne “I Promessi Sposi” (del 1827 e del 1840) l’innominato, con Abbondio e la buona donna incaricata dal Cardinale, torna al castello armato come era quando ne era uscito al mattino, il che impedisce ogni idea strana nei suoi uomini sulla situazione; senza alcun sotterfugio fa salire sulla lettiga Lucia e l’accompagnatrice (dà anche loro il braccio per aiuto); fa uscire dal castello la comitiva alla luce del sole.
Sul piano “romanzesco” la soluzione della “Prima Minuta” è forse più stimolante; c’è suspense; se qualcosa andasse storto, il Conte si troverebbe a combattere — e a mani nude! — contro i suoi stessi sgherri; allora sì che Don Abbondio se la vedrebbe brutta!
Ma l’Epilogatore stava leggendosi non la “Prima Minuta” ma il testo che sarebbe poi diventato quello della Ventisettana, oppure una delle tante ristampe del romanzo.
Ed eccoci alla ulteriore difformità tra Epilogo e “Prima Minuta” di Manzoni nell’episodio del Conte del Sagrato.
Difformità n. 12 — Ripresa da “I Promessi Sposi”.
12.7/ A chi rende visita il Conte “ricomparso”? E a chi dà i quattrini?
Per ambientarsi — Dopo avere in Chiuso aiutato il Conte del Sagrato nel suo percorso esistenziale, il Cardinale Federigo Borromeo prosegue nel viaggio pastorale, toccando vari paesi fino a giungere a quello di Renzo e Lucia. In tutti i suoi spostamenti viene seguito dal Conte che, ogni giorno, gli fà visita per confermarsi nel suo mutamento. Così il Conte fà anche nel paese degli sposi e lì …
Ma vediamo che scrive l’Epilogo (carta 8v):
«Ricomparisce il Conte per rinnovare le dimostrazioni di pentimento, e si porta a visitare la madre della rapita; le fa scusa, e le lascia danaro.»
In Epilogo, quindi, nelle poche parole già riportate sopra si dice:
- che il Conte “ricomparisce”, dando per supposto che fosse in un qualche momento scomparso;
- che di persona porta del denaro alla madre di Lucia, dando per supposta l’assenza della stessa Lucia.
Nella “Prima Minuta” di Manzoni, le cose sono però ben diverse.
Primo — È continuamente ripetuto che il Conte — ogni giorno, per tutti i giorni dal suo ravvedimento — si presenta a Federigo, nell’ora che precede il pranzo; insieme parlano a lungo: in “Prima Minuta” il Conte quindi non “ricomparisce”, dal momento che non è mai scomparso.
Secondo — In quel particolare giorno in cui Lucia torna al paese; proprio in quel giorno, il Conte chiede a Federigo:
— se può vedere Lucia;
— se può chiederle il perdono;
— se può in qualche modo sdebitarsi.
Manzoni è quindi preciso nell’indicare che Lucia è sotto la protezione e tutela del Cardinale, potenza spirituale ma con anche ampi poteri temporali; è preciso nell’indicare che il Conte, nei confronti di Lucia, non può fare di testa sua ma solo avendo il consenso del Cardinale; è preciso inoltre nel narrare come il Conte non vada a trovare la madre di Lucia, ma Lucia stessa (ovviamente con essa vi è anche Agnese); perché è Lucia che deve dargli il perdono.
Se non si coglie questo insieme di elementi, non si comprende nulla del discorso di Manzoni.
Al solito, i casi quindi sono due: o l’epilogatore non capiva un accidente di Manzoni — e quindi non poteva né esserne vicino né averne la simpatia, come scritto dalla Professoressa Italia — oppure non conosceva praticamente nulla dello svolgimento della “Prima Minuta” e ha semplicemente riportato, anche in questo caso, un semplice promemoria, poche parole per segnare una riflessione.
Oppure — lo abbiamo già anticipato ma conviene cominciare a farsene un quadro più preciso, è un furbone che ha voluto produrre un testo colmo di lacune a testimoniarne la genuinità — vecchio trucco di qualsiasi imbonitore.
A proposito di imbonitori, giova ricordare che è ne “I Promessi Sposi” del 1827 che Manzoni presenta la cosa in un modo cui vagamente si avvicina l’Epilogo: Donna Prassede (nella “Prima Minuta” comparirà molto più avanti) è in villeggiatura vicino a Chiuso; si è offerta di avere con sé Lucia in Milano; Lucia e Agnese quindi si separano, la prima per fermarsi da Donna Prassede, la seconda per tornare al paese. È in questo momento che l’innominato (il Conte della “Prima Minuta”) fa avere ad Agnese un rotolo di denaro:
«Il cardinale era anch’egli sulle mosse, per portarsi ad un’altra parrocchia, quando capitò, e chiese di parlargli, il curato di quella in cui era il castello dell’innominato. Intromesso, presentò un gruppo e una lettera di quel signore, la quale pregava Federigo di fare accettare alla madre di Lucia un cento scudi d’oro che erano nel gruppo, per servir di dote alla giovane, o per quell’uso che ad entrambe sarebbe paruto migliore;»
Abbiamo quindi una ennesima riprova delle ampie e ripetute difformità tra l’Epilogo del «Manoscritto Lecco170» e “Prima Minuta” di Manzoni.
Ma passiamo ora alle difformità riscontrabili nella lunga parte dedicata a Fermo: sono anche in questo caso bene evidenti.
13. Cinque difformità su Fermo nella rivolta del pane.
Difformità n. 13 — Invenzione originale.
13.1/ Perché l’assalto ai forni?
Ricordando al lettore che in tutta questa sezione stiamo soltanto verificando se e in che misura l’Epilogo “Gli Sposi promessi” del «Manoscritto Lecco 170» è fedele alla “Prima Minuta” del romanzo (siamo comunque alla difformità n. 13 e solo a metà percorso), vediamo che succede quando Fermo arriva in Milano a San Martino (sabato 11 novembre 1628), giorno in cui esplode la rivolta del pane con l’assalto ai forni, e come quegli avvenimenti sono descritti — nell’Epilogo da una parte e in Manzoni dall’altra.
Nell’Epilogo così è scritto (carta 9v, evidenziazioni nostre):
«il popolo in tumulto saccheggia e devasta il Prestino delle Scansce, e ne rapisce il pane, le farine […]
I regolamenti improvidi di D. Antonio Ferrer Cancelliere dell’assente Governatore avevano tassati i prezzi, onde, non trovandosi chi volesse vender pane al prezzo tassato, il pane era mancato ed il popolo s’era messo in furore, incolpandosi l’avidità de’ Fornaj d’avere costretto il Cancelliere a derogare a quel primo regolamento ciecamente applaudito».
In poco meno di 30 parole (a sintesi delle 4.600 di Manzoni), l’Epilogatore ha infilato due macroscopiche difformità rispetto a quanto scritto da Don Lisander nella “Prima Minuta”, in 11 pagine fitte di fatti e riflessioni:
«Regolamenti improvidi» … «Il pane era mancato».
Secondo l’Epilogatore, Ferrer sarebbe stato “improvido”, in quanto:
a/ il calmieramento del prezzo del pane da lui voluto (la “tassa sul prezzo”), avrebbe spinto i fornai a interrompere la produzione e a non vendere più il pane;
b/ il popolo affamato avrebbe quindi risposto saccheggiando e devastando il “Prestino delle Scansce” e gli altri forni della città.
La “imprevidenza” di Ferrer sarebbe quindi consistita nel non avere previsto la rivolta popolare, scatenata dalla mancata vendita del pane, determinata dal calmieramento da egli stesso proclamato.
Potrebbe essere la traccia per una fiction garantita culturalmente dai nostri amici dell’Accademia: peccato però non abbia nulla a che vedere con la vicenda raccontataci da Manzoni — e con la storia vera.
Nella “Prima Minuta”, infatti, le cose vanno in tutt’altro modo:
a/ Il calmieramento di Ferrer sul prezzo del pane suscita l’opposizione sorda dei fornai che, confidando in un ripensamento di Ferrer, continuano a infornare e vendere il pane (Prima Minuta, T. 3, cap. 6, 65b, p. 376): «I fornaj avevano protestato fin da principio, che se la legge non veniva tolta, essi avrebbero gettata la pala nel forno, e abbandonate le | botteghe; e non lo avevano ancor fatto, perchè sono di quelle cose alle quali gli uomini si appigliano solo all’estremo, e perchè speravano di dì in dì che Antonio Ferrer gran cancelliere sarebbe restato capace, o qualche altro in vece sua.»);
b/ di fronte al persistere di Ferrer nella politica di calmieramento, i fornai premono sul Consiglio dei Sessanta Decurioni [magistrati patrizi, molti dei quali proprietari di grandi forni, annotazione nostra];
c/ questo sul Governatore Gonzales;
d/ il quale (troppo impegnato nella guerra attorno a Casale per occuparsi di simili inezie) istituisce una Commissione;
e/ la quale abolisce il calmieramento stabilito da Ferrer, lasciando libero il prezzo di vendita del pane.
La rivolta popolare, quindi, si scatena non perché i fornai hanno chiuso bottega — come ci dice l’Epilogo — ma perché nelle botteghe dei fornai il prezzo del pane è tornato al libero mercato — come detto da Manzoni.
Lo scenario narrativo svolto da Don Lisander è perfettamente coerente con il dato storico: in “Prima Minuta”, infatti, prodromo degli assalti ai forni è l’appropriazione, da parte della folla in agitazione fin dall’alba, del pane che i fattorini dei fornai di primo mattino portano ai possidenti e ai conventi.
Quindi con forni normalmente aperti e in produzione — ma il pane costa troppo per la povera gente.
Diciamo noi che l’assalto ai forni (“spesa proletaria” ante litteram) è un calmieramento sui generis che il Manzoni (allora iper-liberista alla Say: “lasciate libero il prezzo del pane, arriverà da dove costa meno”; e insieme interventista alla Borromeo: “si attivi la Chiesa attraverso una capillare politica dell’elemosina”) giudicava ovviamente vano nel lungo periodo ma che, da storico serio, non poteva non rappresentare nella sua dinamica reale, completamente deformata dalla narrazione dell’Epilogo.
Come semplice curiosità, ricordiamo che fino al 1993, nel nostro paese, il pane comune era calmierato (a Milano, in vendita a “prezzo tassato”, stile Ferrer, era la “michetta”).
E veniamo alla seconda difformità, relativa al comportamento di Fermo nel sommovimento generale.
Difformità n. 14 — Invenzione originale.
13.2/ Ma Fermo è un rivoltoso omicidiario o un rigoroso legalitario?
Dopo l’assalto ai forni, la folla si propone di giustiziare il Vicario di provvisione, imputato sia di complicità con i fornai sia di colludere con i francesi per affamare Milano.
La dimora del magistrato viene assediata e la situazione non degenera nel sangue solo per l’intervento di Ferrer: attorno alla sua azione riesce a compattarsi il “partito della legge” che, nella situazione di aspra tensione, riesce a prevalere sul “partito della violenza diretta” — un tema ricorrente nella elaborazione complessiva di Manzoni che, pur disponibile a giustificare le azioni popolari dal basso, lamenta la mancanza di una direzione che le sappia mantenere in un quadro di legalità.
Come si comporta Fermo sia di fronte all’assalto ai forni sia nella caccia al Vicario?
Nell’Epilogo, così se ne scrive (carta 10v, evidenziazioni nostre):
«Fermo confuso colla moltitudine si mesce in discorsi, e grida egli pure con chi grida abbondanza, giustizia, morte al Vicario, viva Ferrer, e simili cose.
Quindi, stanco, dimanda di un albergo […]»
Se le parole non sono farfalle, l’Epilogatore mette quindi Fermo nella schiera — battuta di misura — dei manifestanti decisi a una sanguinosa azione diretta e immediata contro il Vicario di Provvigione.
Ma nella “Prima Minuta” di Manzoni le cose sono proprio all’opposto:
— Fermo, che invita alla moderazione e al rispetto della legge, è indicato dai rivoltosi come sostenitore del Vicario e viene minacciato a sua volta di fare la stessa fine;
— è tra quelli che appoggiano Ferrer perché sottragga il Vicario alla violenza e lo metta sotto la tutela della legge;
— alla fine della giornata è tra i sostenitori di una giustizia senza compromessi e sofismi dilatori ma nel quadro di un diritto riconosciuto dalla collettività.
Vediamo il testo di Manzoni (T. 3, Cap. 6, 71d, p. 385):
«Fermo si trovava in mezzo alla calca, ma questa volta strascinato e assorbito dal vortice piuttosto che venuto di sua voglia; le grida che chiedevano il sangue, i volti che ne mostravano la abbominevole sete lo avevano riempiuto di turbamento e di orrore; egli detestava in quel momento quella che gli era paruta giustizia del popolo, la trovava più atroce della fame. – Andiamo andiamo, diceva egli ai suoi vicini; è una vergogna! vogliamo noi fare il boja? assassinare un cristiano? Come volete che Dio ci dia il pane a buon mercato se commettiamo di queste iniquità?
– Ah! traditore della patria! disse uno che era vicino a Fermo rivolgendosi a lui con un viso d’indemoniato: aspetta, aspetta, tu sei un amico del Vicario, e dei tiranni […]
Mentre la situazione sta precipitando verso la tragedia, a trarre in salvo il Vicario (e Fermo) giunge in carrozza il vice-governatore Ferrer, ben visto dal popolo per aver giorni prima calmierato il pane.
L’anziano politico, lanciatosi con coraggio in una missione impossibile, tiene ottimamente la scena; riesce a farsi sostenere dalla parte legalitaria dei manifestanti e salva il Vicario (idem, 73b, p. 387):
«– Sì figliuoli miei cari! diceva il vecchio, alzando la voce quanto poteva: comanderò io = si farà giustizia = il pane a buon mercato.
Intanto, fatemi un piacere, datemi un po’ di passaggio. Vengo per mettere in prigione il vicario di provvisione.
Questa nuova parola fu pure trasmessa di bocca in bocca. – Sì sì = bravo! in prigione! – nò nò! lo vogliamo morto! – Nò in prigione! giustizia! largo! largo! […]
I più, placati in parte e raddolciti dal vedere che un alto magistrato veniva a riconoscere la giustizia della loro causa, e a compirla legalmente, […] gridavano che gli si facesse luogo, e che il vicario gli fosse rilasciato.
Fermo era tra questi, e gridava a testa: prigione e giustizia!»
Ferrer riesce a far salire il Vicario in carrozza, cui fanno largo i più legalitari della folla; tra questi è il nostro promesso sposo (T. 3, cap. 7, c. 78d; p. 397):
«Fermo, dopo avere finchè potè, seguita la carrozza che aveva salvato il Vicario dal furore del popolo e lo conduceva legalmente in prigione, si fermò a riaversi un poco […]»
Risolta da Ferrer la difficile situazione del Vicario (ormai è sera) la folla si disperde, salvo crocchi, dove si discute. Fermo vi si ferma, ascolta, poi si fa oratore ma con un ben preciso indirizzo. Prima di farlo parlare Manzoni ne descrive i sentimenti, tutti da brava persona (T. 3, cap. 7, 78d, p. 397):
«Quel disgusto che gli avevano recato le grida del sangue, e i preparativi della carnificina, aveva dato luogo alla gioja di vedere la giustizia, e l’umanità vittoriose, il delitto punito senza delitti, e la dignità del magistrato, il potere legale unito col voto pubblico, e divenuto suo amico e suo ministro.»
E quando poi lo fa parlare gli fa dire solo cose di buon senso comune, presentandolo come lontanissimo da ogni idea di rivolta sanguinaria (T. 3, cap. 7, 80a, p. 399):
«e dirlo al Ferrer, ma dirglielo in piazza, e in molti, che faccia fare il processo a tutti costoro, e poi, perchè ci vuol altro che una carrozza a condur prigione tutti costoro, bisognerà far venir oltre tutti quelli che sono come Ferrer, che hanno il timore di Dio e vogliono le cose giuste, e condurli alle case di questi tiranni […] e farli metter tutti allo scuro, e far loro un buon processo, e giustizia sommaria, e poi far lo stesso anche fuori dalle porte di Milano […] . Dico bene, signori miei?»
Riassumendo: secondo l’Epilogo, Fermo è uno dei favorevoli al linciaggio del Vicario; secondo la “Prima Minuta” di Manzoni, invece, nel momento critico, quando basterebbe poco a trasformare la protesta in omicidio e aperta rivolta, Fermo:
— si batte per l’osservanza della legalità;
— è contro il ricorso all’azione diretta e violenta del popolo nelle piazze;
— è invece in favore di una vera giustizia, somministrata cioè a seguito di un regolare processo, ancorché “sommaria” (ossia, nel linguaggio dell’epoca, un regolare procedimento giudiziario nel quale, per dirla con le parole di Tommaseo nel suo Dizionario: «i giudizii non sieno ingarbugliati da false interpretazioni.»).
A conferma della distanza strutturale tra la narrazione dell’Epilogo e quella della “Prima Minuta”, ricordiamo che la soluzione “impicchiamo fornai e affamatori” viene da Manzoni messa in bocca ai “nemici” di Fermo, all’origine delle sue tribolazioni; al cugino Attilio e ai commensali di Don Rodrigo, nell’incontro-scontro tra il prepotente e Padre Cristoforo; e ciò alla distanza di 329 pagine nel romanzo ma solo due giorni prima dell’arrivo di Fermo in Milano.
A ribadire il sentire di Fermo, in modo anche troppo didattico, Manzoni ci dice chiaro e tondo che mai il promesso sposo avrebbe potuto esprimersi come i suoi prevaricatori (T1, Cap. 5, 58°, p. 75):
«– Io decido e sentenzio, disse il Dottore, che le cene di Eliogabalo sarebbero vinte al confronto dei pransi del nobile sig.r D. Rodrigo, e che la carestia non ardisce approssimarsi a questa casa […] Carestia! diceva uno, non c’è carestia sono gli accapparratori, birbanti. – I fornaj, i fornaj – gridava un altro. – Impiccarli! dei buoni esempj, senza pietà. […] Impiccarli, impiccarli! sono i peggiori = | tutte invenzioni per nascondere gli accapparramenti. […] Oh scellerati! impiccarli! […] Dov’è tutto il male? nella carezza del pane: e chi lo vende caro? i fornaj = e per farli mutar vezzo, impiccarne uno o due. […] Impiccarli, impiccarli! »
Tornando a noi, dopo questa Difformità n. 14, non possiamo più limitarci a dire che l’Epilogo si discosta in molti punti importanti dalla “Prima Minuta” di Manzoni: siamo purtroppo costretti a dire chiaro e tondo che l’Epilogo sviluppa a tratti una linea difforme e finanche ostile al pensiero e alla esperienza esistenziale di Manzoni.
Difformità n. 15 — Invenzione originale.
13.3/ L’oste denuncia Fermo al mattino o alla sera?
In Milano, a sera inoltrata e al termine della giornata dell’assalto ai forni (sabato 11 novembre 1628), Fermo, stanco e affamato, chiede dove può trovare da mangiare e dormire a un passante — in realtà un agente di polizia in borghese che lo teneva d’occhio già da un po’. Questi lo accompagna a un’osteria; beve con lui un bicchiere di vino; gli fa dire abilmente provenienza, nome e professione; lo saluta e va diritto al palazzo del Capitano di Giustizia a denunciarlo come uno dei caporioni della giornata. Fermo si ubriaca; è portato a letto dall’oste il quale … e poi che succede?
Nell’Epilogo così si scrive (c. 11r):
«Il compagno lo lascia; ed egli continua bevendo; s’inebria, ed è condotto a letto dall’albergatore, che di buon mattino il denunzia al Capitano di Giustizia, dicendo, ch’egli non aveva voluto notificarsi, e trova, che l’amico, il quale era un bargello travestito, lo aveva già denunziato per nome.»
Quindi, secondo l’Epilogatore, l’oste si reca al palazzo di giustizia per denunciare Fermo il mattino successivo alla giornata del tentato linciaggio del Vicario di Provvisione.
Ma nella Prima Minuta (e nella Ventisettana e Quarantana) la cosa non è così raccontata.
Riassumiamo noi le due pagine di Manzoni dedicate all’episodio: Fermo beve e ciarla, ciarla e beve; ormai ubriaco, su per una scala è portato alla sua stanza dall’oste. Sistematolo, questi si copre d’un mantello, si raccomanda alla moglie per una avveduta gestione degli avventori e, munito di un randello, se ne esce subito in strada, nella notte ormai fonda, borbottando tra sé: «E tu prega il cielo che domani tiri l’aria d’oggi, se nò, stai fresco. Hai voluto affogare, affoga […] mi volevi esporre a trecento scudi di pena, o a cinque anni di galera.»
E va dritto al palazzo del Capitano di Giustizia a denunciare Fermo, già registrato ai birri da quel tale accompagnatore sconosciuto, anch’egli birro, che lo aveva di poco preceduto.
Dal momento che per l’Epilogatore non avrebbe fatto alcuna differenza scrivere “che alla sera stessa il denunzia”, anziché “che di buon mattino il denunzia” come invece leggiamo nel suo manoscritto, è evidente anche da questa difformità che egli:
— o non ha fatto riferimento alla “Prima Minuta” quale la conosciamo ma a un qualche cosa d’altro, nel quale l’oste va a denunciare Fermo al mattino; oppure
— aveva anch’egli bevuto un bicchier di troppo.
Comunque, evviva la filologia!
Difformità n. 16 — Ripresa da “I Promessi Sposi”.
13.4/ A Gorgonzola, Fermo viene richiesto su quanto avviene in Milano? O invece viene ignorato?
Siamo a domenica 12 novembre.
Con l’aiuto della folla nuovamente in fermento, Fermo è riuscito a sottrarsi all’arresto; essendo ricercato dalla polizia, fugge da Milano per rifugiarsi a Bergamo; cammina tutto il giorno e giunge a Gorgonzola all’imbrunire; per un boccone, si ferma in una locanda dove gli avventori discutono dei fatti di Milano.
In questa situazione che succede a Fermo, secondo l’Epilogo e secondo la “Prima Minuta” di Manzoni?
Nell’Epilogo così se ne scrive (c. 11v, evidenziazioni nostre):
«Giunto a Gorgonzola, si ferma all’osteria, dove molti curiosi contano, e dimandano delle cose di Milano: ma egli finge di non venire da quella parte, e di non sapere; e ascolta in silenzio il racconto d’un mercante capitato al momento a narrarvi le cose del giorno stesso […]»
Quindi, secondo l’Epilogatore, alla locanda di Gorgonzola Fermo viene interrogato dai presenti su quanto successo a Milano, ma egli finge di non sapere.
Ma nella “Prima Minuta” di Manzoni le cose sono presentate in modo ben diverso (T. 3, cap. 8, 94c; p. 419):
«Si sapeva in cento maniere […] il guazzabuglio del giorno antecedente, e s’era pur bucinato che il mattino la pentola aveva cominciato a ribollire; sicchè la curiosità era infiammata. Gli occhi furono tosto addosso a Fermo, ma visto ch’egli era un forese, nessuno pensò a lui, per sua buona ventura […] In vece, senza essere importunato di richieste potè egli mentre mangiava saporitamente, sentire i discorsi che si facevano […]»
Secondo Manzoni, quindi, nessuno rivolge parola a Fermo ed egli può ascoltare indisturbato.
Guarda, guarda: è invece ne “I Promessi Sposi” del 1827 e del 1840 che le cose vanno come dice l’Epilogo (T. 2, p. 122):
«Tutti gli occhi si rivolsero a quel ch’era entrato; e uno della brigata, spicciatosene, gli si fece accanto, e gli domandò se veniva da Milano.
«Io?» disse Renzo sorpreso, per pigliar tempo a rispondere. «Voi, se la domanda è lecita.» Renzo, scotendo il capo, strignendo le labbra, e facendone uscire un suono inarticolato, disse: « Milano, per quel che sento … così, a dire della gente non debb’essere paese da andarvi al presente, fuori d’un gran caso di necessità.» «Continua dunque anche oggi il fracasso?» domandò con più istanza il curioso. «Bisognerebbe esser colà, per saperlo» disse Renzo.
«Ma voi, non venite da Milano?» «Vengo da Liscate,» rispose netto il giovane, che intanto aveva pensata la sua risposta.»
Ma allora, l’Epilogatore per il suo riassuntino è andato a pescare nella Ventisettana (o nella Quarantana)! o che altro gli è passato tra le mani?
In attesa di autorevoli risposte da parte degli attuali sponsor accademici dell’Epilogatore, stiamo ancora un attimo a Gorgonzola, in quella tale osteria.
Difformità n. 17 — Omogenea al film di Camerini, 1941
13.5/ Perché si fermano i tumulti in Milano?
Lo abbiamo appena visto: Fermo è all’osteria di Gorgonzola; senza che nessuno si occupi di lui ascolta i racconti di un mercante appena giunto da Milano.
Che dice questo mercante, secondo l’Epilogo e secondo la “Prima Minuta” di Manzoni?
Nell’Epilogo è così scritto:
«[Fermo] ascolta in silenzio il racconto d’un mercante capitato al momento a narrarvi le cose del giorno stesso, nel quale erasi rinnovato il tumulto, sedato coll’intervento del Capitolo della Metropolitana a Croce alzata, e colla impiccatura di quattro capipopolo, e con provvedimenti annonarj, della stravaganza ed inefficacia de’ quali l’Autore rende conto in esteso.
Fermo passa a Bergamo, e vi resta.»
Quindi, secondo l’Epilogatore, il mercante giunto da Milano aveva riferito che il tumulto era stato sedato attraverso tre distinti passaggi:
— per l’intervento del Capitolo della Metropolitana;
— colla impiccatura di quattro capipopolo;
— con stravaganti e inefficaci provvedimenti annonari, bene illustrati dall’Autore.
Senza aggiunger altro, l’Epilogatore dà poi Fermo come arrivato a Bergamo — e vada a farsi benedire il tanto citato attraversamento dell’Adda!
A parte la bizzarria di indicare come “inefficaci” provvedimenti annonari poche parole prima indicati come risolutivi nel “sedare il tumulto”, la narrazione dell’Epilogatore appare non tanto “difforme” quanto decisamente opposta e oppositiva a quella di Manzoni.
Tanto da far pensare a una sua qualche ostilità nei confronti di Don Lisander — la si direbbe scritta da un rappresentante di quel clero reazionario, tutto “preci e capestro”, contro cui l’autore della “Prima Minuta” si batté tutta la vita.
Infatti, nella “Prima Minuta” di Manzoni, le cose sono presentate in modo ben diverso per tutti e tre i passaggi evidenziati nell’Epilogo.
Per vedere il come, dobbiamo invertirne l’ordine espositivo.
a/ Provvedimenti annonari.
Nella “Prima Minuta”, tra i primi provvedimenti utili — anzi indispensabili — a spegnere la rivolta, Manzoni (che non era un minchione) mette al primo posto proprio quei “provvedimenti annonari” che l’Epilogatore dice da lui criticati “per esteso”, in quanto “inefficaci” (T. 3, Cap. 8, 88a, p. 410):
«Ma quando sul declinar del giorno venne la relazione, che il Vicario era in salvo […] Si ordinò che fossero mandate guardie ai forni rimasti intatti fin allora, per assicurarli, e per obbligare i fornaj a far pane in abbondanza per l’indomani […] e il prezzo del pane fu riabbassato a quella prima tassa immaginata dal Ferrer.»
b/ Intervento Capitolo della Metropolitana.
Manzoni, pur essendo un fervente cattolico (più che rispettoso del ruolo della Chiesa anche nella vita sociale) non era certo un tonto e presenta quindi in modo realistico l’intervento dei presbiteri milanesi in quelle ore di rivolta: degli autorevoli canonici del Duomo evidenzia la funzione di “garanti” dei “provvedimenti annonari” presi dal potere politico, proprio quelli che l’Epilogatore definisce “stravaganti e inefficaci” (T. 3, cap. 8, 96c; p. 423):
«Intanto venne tutto il capitolo del duomo in processione, a croce alzata, […] e cominciarono a predicare: figliuoli dabbene, che cosa fate? è una vergogna, dove è il timor di Dio? […] Via, tornate a casa, da bravi, che quel che è stato è stato. Avrete abbondanza = il pane di otto once ad un soldo = la grida è stampata.
– Era vero poi? domandò uno degli ascoltanti.
– Vero come il Vangelo. Volete voi che i canonici venissero in paramenti a dir bugie?»
Manzoni ci dice cioè chiaro e tondo che il popolo in rivolta, per l’immediato, ha vinto la partita: il prezzo del pane è stato nuovamente calmierato, come fatto da Ferrer prima dell’intervento della Commissione del Consiglio dei Decurioni; a garantire non si tratta di un inganno della politica è il fior fiore del clero della città.
c/ Impiccatura di quattro capipopolo.
Nel racconto del mercante giunto da Milano, l’Epilogatore dà come avvenuta l’impiccagione di quattro uomini, ritenuti caporioni della rivolta.
Ma, riportando il racconto del mercante, Manzoni la dice diversamente (idem):
«Ma ecco che venne l’ultima medicina che fece l’effetto.
– E fu?…
– E fu, unguento di canape = bastò nominarlo, per far guarire tanti matti. Si fece pubblicare, ed è vera anche questa, che quattro capi erano stati presi jer sera, e saranno impiccati. Ah! ah! vi dico io che ognuno studiava la via più corta per andarsene a casa, per non diventare il numero cinque. Quando io sono uscito da Milano, pareva un monastero.
– Dunque gli impiccheranno? domandò un altro uditore.
– Senza fallo, e presto, rispose il mercante.
– E la gente che cosa farà? domandò ancora quegli.
– Anderà a vedere, rispose ancora il mercante.»
Quindi, mentre secondo l’Epilogo, i quattro capi sono stati impiccati nel corso della giornata del 12, secondo Manzoni, benché giudicati e condannati alla impiccagione, il 12 novembre i quattro malcapitati sono ancora perfettamente vivi.
Per quei poveri disgraziati ciò contò poco, perché effettivamente vennero impiccati qualche tempo dopo.
Ma per noi la cosa ha una sua valenza.
Non essendo né capi popolo, né mercanti, né filatori di seta costretti alla fuga su e giù per la Lombardia, da innocenti lettori, fidenti nella competenza e serietà degli accademici, siano solo desiderosi di capire.
Secondo il racconto del mercante, per come lo riporta l’Epilogo, i presunti capi della rivolta sarebbero stati impiccati proprio nel pieno del suo dispiegarsi e in aperta contraddizione con l’opera di sedazione, a base di pane a buon mercato, accortamente adottata dai politici — e scrupolosamente riferita da Manzoni.
Come vadano queste cose nella vita reale Manzoni lo aveva sentito raccontare in lungo e in largo dai suoi amici di Parigi, alcuni dei quali protagonisti della stagione rivoluzionaria francese (l’amico Fauriel, per esempio, aveva fatto parte della polizia politica di Fouchet); anche per ciò mai avrebbe scritto la fesseria messa nero su bianco dall’Epilogatore.
E, infatti, nella Ventisettana, Manzoni indica nel 24 dicembre 1628 la giornata in cui i disgraziati giudicati responsabili dei tumulti vennero impiccati (Buon Natale, ragazzi!).
A questo punto il lettore si starà chiedendo: perché questi del Centro Studi dell’Abate stanno così insistendo sul quando effettivamente venne eseguita la condanna?
E allora diciamolo subito: la cosa ha un suo valore in relazione a curiose coincidenze tra alcuni elementi presenti dell’Epilogo:
— assolutamente difformi da quanto scritto da Manzoni sia nella “Prima Minuta” sia nelle successive edizioni;
— ma curiosamente coincidenti con il già citato film di Camerini del 1941.
Vediamo come.
Camerini, nel presentare le 36 ore passate da Renzo a Milano (la giornata di sabato 11 novembre e la mattinata di domenica) le condensa in sole 12 (dalla mattina alla sera dell’11).
Ignora del tutto la vicenda serale e notturna dell’osteria e presenta il tentativo di arresto di Renzo come avvenuto in pieno giorno; fa trascorrere qualche ora (si presume con Renzo nascosto da qualche parte) e, a sera già iniziata, mostra momenti delle due distinte impiccagioni (al forno delle scansce e alla abitazione del Vicario di Provvisione) dei ritenuti responsabili delle violenze della giornata; immediatamente dopo, fa uscire Renzo dalla città in un carro, sotto falso nome; salta del tutto la sequenza di Gorgonzola e ce lo fa ritrovare mentre si appresta a passare l’Adda di primo mattino.









Secondo Camerini quindi, Renzo esce da Milano mentre sono in corso (o sono state appena eseguite) le condanne a morte — in questo, in modo difforme da Manzoni ma esattamente come narrato nell’Epilogo.
E allora?
Non sapremmo che dire.
Bisognerebbe girare la domanda a chi sostiene che l’Epilogo sia stato redatto e composto almeno 100 anni prima del film di Camerini.
Auguri!
14. Difformità sugli sposi ricongiunti.
Difformità n. 18 — Invenzione originale.
14.1/ “Se vi fosse Lucia Mandelli” …
Colpito in Bergamo dalla peste e guaritone, Fermo si reca al paese proprio e di Lucia; incontra Don Abbondio e Agnese che gli narrano dei fatti avvenuti. Per ritrovare Lucia, Fermo torna a Milano nel colmo del contagio. Cerca e trova la casa di Don Ferrante presso cui dovrebbe essere Lucia.
Vediamo come la cosa è raccontata nell’Epilogo (carta 16r, p. 31):
«giunge alla porta chiusa di D. Ferrante; vi batte; e la cameriera di D.a Prassede, tratta al romore, e spinto il capo fuori della finestra, risponde alla dimanda, se ivi fosse Lucia Mandelli, che essa era caduta inferma di peste, e condotta al Lazzaretto.»
Nuova incongruenza, quindi, questa volta di tipo onomastico.
Opportunamente Paola Italia ha segnalato la cosa — ma molto superficialmente e limitandosi a indicarla come l’unico dei punti di discostamento tra Epilogo e Prima Minuta.
Abbiamo invece visto che è solo una delle 23 (ventitré) difformità tra i due scritti e che quindi è forse opportuno considerarla con altri occhi, dicendone qualche cosa di più.
È questa l’unica volta in cui nell’Epilogo si fa il cognome di Lucia e — guarda caso — risulta altro da “Mondella”, indicato da Manzoni nella “Prima Minuta” per ben quattro volte:
— «Il Conte cavò la sua vacchetta, e dopo aver rivolta qualche carta, lesse: Lucia Mondella» (p. 225, immediatamente dopo il mutamento d’animo del masnadiero];
— «Federigo a Don Abbondio: come, non conoscete Lucia Mondella, vostra parrocchiana, che era scomparsa…?» (p. 291, il Cardinale si adopera per ricongiungere Lucia alla madre);
— «Signora, disse Fermo con voce tremante, sta qui una forese, che si chiama Lucia Mondella?» (p. 536, Fermo è in Milano, alla casa di D. Ferrante);
— «Son qui, rispose Fermo [a Don Abbondio], grazie a Dio, e sono ad avvertirla che presto sarà qui anche Lucia Mondella» (p. 574, appena tornato da Milano, Fermo a Don Abbondio).
La superficialità che abbiamo segnalato in Paola Italia è l’avere ignorato il dato di fatto delle quattro “Mondella” — certo non irrilevante — lasciando il lettore a bocca asciutta e costringendolo ad arrangiarsi da sé per le opportune verifiche (ma a che servono allora gli specialisti?).
Già che siamo capitati sulla onomastica, può essere opportuno toccare un’altra difformità di tipo linguistico, perfettamente ignorata dalla Professoressa.
Difformità n. 19 — Invenzione originale.
14.2/ “Lazzaretto” dell’Epilogo versus “lazzeretto” di Manzoni.
Come anticipato, da parte della filologa Paola Italia non se ne è fatto neppure un vago accenno ma, rispetto alla “Prima Minuta” di Manzoni (e anche in tutte le successive versioni del romanzo), nell’Epilogo del «Manoscritto Lecco 170» è riscontrabile una vistosissima difformità toponomastica relativa alla denominazione del luogo di ricovero in Milano dei colpiti dalla peste.
Vediamo di che si tratta:
— nell’Epilogo la parola “Lazzaretto” si ripete per 11 volte, tutte con l’iniziale maiuscola;
— nella “Prima Minuta” di Manzoni, invece, “Lazzaretto” non compare mai;
— compare invece, per 71 occorrenze “Lazzeretto / lazzeretto”, 14 volte con l’iniziale maiuscola (12 delle quali concentrate nel T. 4, cap. 1);
— nelle due edizioni del 1827 e del 1840, Manzoni usa sempre “lazzeretto” con l’iniziale minuscola.
È quindi un dato di fatto che tra Epilogo e “Prima Minuta” di Manzoni abbiamo anche questa difformità, ci pare non attribuibile a curiose abitudini scrittorie del copista ma a una precisa scelta toponomastica che ha autorevoli testimoni, tutti difformi dalla lezione cui si rifà Manzoni:
— Landino nel suo “Raguaglio” del 1648 (onnipresente in Manzoni) usa sempre il termine “Lazaretto” (una “z”);
— usa costantemente “Lazzaretto” Francesco Cusani (1841), nella sua traduzione dal latino del “De peste” di Ripamonti (anch’egli di casa in Manzoni) che usa a sua volta sempre “Lazaretus”;
— “Lazzaretto” è usato costantemente da Pio La Croce il cui “Memorie delle cose notabili successe in Milano” (1730) Manzoni teneva bene in vista nella sua biblioteca di Via Morone;
— nel dizionario di Tommaseo trovano spazio entrambe le lezioni ma segnaliamo che “Lazzaretto” è riportato per autori sia veneti sia emiliani sia toscani, a indicarne l’indipendenza dalle parlate locali;
— per quello che può valere in termini filologici, ricordiamo che anche l’Abate Stoppani (fervente manzonian-manzonista) nel suo “I primi anni di A. Manzoni” usa sempre il termine “Lazzaretto”.
D’altra parte nel Dizionario della Crusca, ricordato che nel Vangelo si scrive di “Lazarus” (e non “Lazerus”), sono riportate entrambe le lezioni con schiere di testimoni illustri.
Ad abundantiam (e nonostante la sua proverbiale inaffidabilità — voluta e non) ricordiamo che Cesare Cantù nel suo “Sulla Storia Lombarda del Secolo XVII / Ragionamenti per commento ai Promessi Sposi” (Milano, 1832), sta abbottonatissimo a Manzoni e usa per 11 occorrenze “lazzeretto” (con iniziale sia maiuscola che minuscola).
A p. 116 gli sfugge solo un “Lazzaretto”, probabilmente auto-suggestionato da altre due uguali occorrenze presenti in citazioni da lui stesso evidenziate (p. 118, da una “patente” del Tribunale di Sanità del 1632; p. 122, dal Somaglia, “Alleggiamento dello Stato”, 1653), poste nelle immediate vicinanze concettuali e fisiche del volume.
Ci fermiamo qui ma è comunque ben curioso che la filologa Italia non abbia fatto caso a quella selva di “Lazzaretto”, che distingue così nettamente l’Epilogo del “Manoscritto Lecco 170” dalla “Prima Minuta” di Manzoni.
Tra l’altro, lo notiamo solo per dovere, il termine proposto da Manzoni non riuscì mai ad attecchire e a scalzare il già affermatissimo “Lazzaretto”, che domina tuttora.
Da Paola Italia “Gli Sposi promessi”, storia milanese epilogata nel 1824”:
«Altrettanto ingiustificato (e assente geneticamente) è lo scempiamento “don Abondio”, costante nel testo (e abbastanza diffuso sin da prima della Quarantana, attraverso i Ragionamenti di Cesare Cantù sulla storia lombarda: “La parrochia di Don Abondio e la patria de’ due promessi sposi vollero metterla ad Acquate”, Sulla storia lombarda del secolo XVII, Milano, presso l’editore dell’Indicatore, 1832, p. 35).
A differenza che per “Abbondio” (con 2 [b]), proprio grazie a Manzoni divenuto standard onomastico nazionale a discapito del corretto nome che in italiano è “Abondio” — ci pare senza nessunissimo rapporto con la tendenza allo scempiamento delle doppie, richiamata da Paola Italia.
La quale si è appoggiata molto distrattamente al già citato Cantù — occhio Professoressa: nei tre riferimenti al curato di Acquate, Cesare usa sì UNA volta “Abondio” (ma a pag. 55, non 35) ma DUE volte “Abbondio”: «Il D. Abbondio di Manzoni “fin da’ primi suoi anni aveva dovuto accorgersi”» (p. 17); «que’ terribili lanzichinecchi che fecero una sì brutta paura a D. Abbondio» (p. 91).
Ma chiudiamo questa parentesi toponomastica e torniamo alle difformità tra Epilogo e “Prima Minuta” di Manzoni nella narrazione degli aspetti più elementari della vicenda.
Difformità n. 20 — Omogenea al film di Camerini, 1941
14.3/ Per cosa Lucia è riconosciuta da Fermo?
Fermo, incontrato Padre Cristoforo al Lazzaretto, dà il perdono a Don Rodrigo e così può porsi alla ricerca di Lucia; a un dato momento la riconosce: da cosa?
Leggiamo che ne dice l’Epilogo (carta 18r, evidenziazioni nostre):
«S’avvolge in quel labirinto; e, cercando da tutti i lati, finalmente [18v] in una capannuccia rimota ritrova due donne, una sorta dalla infermità, e l’altra ammalata. Osserva attentamente; ed ai tratti riconosce nella convalescente la sua Lucia, e n’è da essa riconosciuto.»
La descrizione è puntuale ma con nulla ha a che vedere con la “Prima Minuta” di Manzoni che, dal canto suo, descrive in poche righe lo svolgimento del ritrovamento con tutt’altre modalità, dando al contempo una benissimo scritta rappresentazione del sentimento d’amore.
Prima Minuta (T. 4, cap. 8, 98c, p. 559, evidenziazioni nostre):
«Le capanne in quel luogo eran tutte abitate da donne; ed egli procedeva lentamente d’una in altra, guardando. Or mentre passando, come per un vicolo, tra due di queste, l’una delle <quali> aveva l’apertura sul suo passaggio, e l’altra rivolta dalla parte opposta, egli metteva il capo nella prima, sentì venire dall’altra, per lo fesso delle assacce ond’era connessa, sentì venire una voce… una voce, giusto cielo! che egli avrebbe distinta in un coro di cento cantanti, e che con una modulazione di tenerezza e di confidenza ignota ancora al suo orecchio, articolava parole che forse in altri tempi erano state pensate per lui, ma che certamente non gli erano mai state proferite: Non dubitate = son qui tutta per voi = non vi abbandonerò mai. […]
In tre balzi girò la capanna, fu su la porta, vide una donna inclinata sur un letto che andava assestando.
– Lucia! chiamò Fermo con gran forza e sottovoce ad un tempo: Lucia!»
Con quasi le medesime parole Manzoni ripropone questa scena nella Ventisettana e nella Quarantana (unica variante, la frase di Lucia che diventa: «paura di che? Abbiamo passato ben altro che un temporale; il Signore che ci ha custodite finora, ci custodirà anche adesso»).
Abbiamo quindi due rappresentazioni nettamente difformi:
— nell’Epilogo il riconoscimento avviene attraverso uno scrutare intenso;
— in Manzoni attraverso il riconoscimento della voce.
Non c’è lettore appena appena attento che non sappia il valore che Manzoni attribuisce ai suoni della natura: che siano torrenti o fiumi è la loro “voce” che si sente, prima di ogni altra cosa; così come gli esseri amati che si riconoscono all’udito (dai passi per esempio) prima che alla vista.
Questa è l’esperienza maturata dal giovane Manzoni in una terra dove ancora erano ben distinguibili i suoni della natura, ed è ovvio che egli trasferisca su Fermo/Renzo l’abitudine e la capacità di coglierne le diverse modulazioni.
Ma allora, perché nell’Epilogo si parla di “vedere” e non di “udire”, come scritto da Manzoni?
La cosa è curiosa perché nella storia della “riduzioni”, più o meno artistiche, del romanzo di Manzoni, c’è un caso, già citato, nel quale viene operata la medesima sostituzione — e siamo a tre!
14.4/ Camerini/Epilogo: ti riconosco perché ti vedo, ti guardo e ti riguardo.
Per intenderci meglio, scorriamo alcune immagini dal film di Camerini, cominciando da un passo indietro rispetto al momento in cui Fermo / Renzo ritrova Lucia (per non appesantire l’esposizione d’ora in poi ci richiameremo al promesso sposo solo col nome di Renzo).

14.4/ Camerini/Epilogo: ti riconosco perché ti vedo, ti guardo e ti riguardo.
Per intenderci meglio, scorriamo alcune immagini dal film di Camerini, cominciando da un passo indietro rispetto al momento in cui Fermo / Renzo ritrova Lucia (per non appesantire l’esposizione d’ora in poi ci richiameremo al promesso sposo solo col nome di Renzo).
Al Lazzaretto Renzo incontra Padre Cristoforo che lo sollecita a dare il perdono a Don Rodrigo, appestato e lì ricoverato. Il giovane acconsente, insieme vanno alla capanna ove è il morente (questa è una sequenza introdotta da Manzoni con la Ventisettana — nella “Prima Minuta” non vi è rapporto diretto con Don Rodrigo e il perdono è garantito da P. Cristoforo).
Renzo dà il perdono al persecutore.
Il Padre Cristoforo lo invita quindi a cercare Lucia: nel perdono da lui dato a Don Rodrigo è la chiave per la felice soluzione; la cerchi con fiducia e con rassegnazione; Renzo gli bacia le mani in atto di riconoscenza e consenso.
Fin qui Camerini segue il testo manzoniano.
Il problema viene adesso.
Salutato Padre Cristoforo, Renzo comincia ad aggirarsi nel Lazzaretto ma inutilmente: dove è finita Lucia? … A un certo punto vede un gruppo di donne convalescenti che si preparano a lasciare il lugubre luogo …
Ma vediamo come propone la cosa la già citata sceneggiatura del film (i numeri indicano le scene, evidenziazioni nostre):
585. (P.P.) Renzo osserva l’uscita delle convalescenti. Va con l’occhio dall’una all’altra. È in preda a una nervosa agitazione.
586. (P.A.) Le convalescenti escono, con esasperante lentezza. Lucia non è tra di esse.
587. (P.P.) Renzo impaziente.
588. (P.A.) La folla diventa sempre più rada. Sono le ultime convalescenti.
589. (P.P.) L’impazienza di Renzo si muta in disperazione. Sta per allontanarsi, deluso, quando un nuovo rumore di passi l’arresta. L’espressione di Renzo subisce un repentino cambiamento. Egli non crede più ai suoi occhi. Guarda meglio. Si slancia in avanti. Il suo volto è raggiante di felicità.
RENZO: — Lucia!.»






Quindi anche per Camerini (come per l’Epilogo) Renzo ritrova Lucia perché ne vede la fisionomia.
Ma — lo abbiamo già indicato sopra — per Manzoni, Renzo ritrova Lucia perché ne sente la voce!
Attenzione! Non siamo a un seminario di anatomia: stiamo parlando di una differenza sostanziale, con ampie implicazioni dottrinali.
Non siamo evidentemente una succursale del Vaticano: è però ovvio che, dovendoci occupare di Manzoni e di un momento del suo romanzo nel quale vi è un notevole dispiegamento di elementi etico-religiosi, non possiamo chiudere gli occhi e fare finta di nulla.
14.5/ Manzoni: ti riconosco immediatamente perché mi giunge la tua VOCE!
Per comprendere quanto sia discordante la narrazione di Camerini/Epilogo da quella di Manzoni, dobbiamo riprendere ciò quest’ultimo scrive sull’intero processo vissuto da Renzo / Fermo dal momento in cui trova Padre Cristoforo al Lazzaretto e insieme affrontano il tema del rapporto con Don Rodrigo (T. 4, cap. 7, 92d, p. 553):
«[Padre Cristoforo] Fermo! giuri tu il perdono?…
– Ah! lo giuro, rispose Fermo in tuono solenne. […]
– Sì, Fermo, a Don Rodrigo = […] Vedi tu questo pane? Lo conservo da quarant’anni; l’ho mendicato nella casa di quello sventurato… l’ho avuto dai suoi come un pegno di pace, e di perdono. […] Prendi, – e porse il pane a Fermo – conservalo ora tu: è il dono ch’io posso lasciarti per mia memoria. […]
Fermo non disse nulla, ma il suo volto esprimeva il pentimento.
– Or va, disse il padre alzandosi, Iddio benedica le tue ricerche.»
In Manzoni, quindi, Fermo dà senz’altro il perdono a Don Rodrigo PRIMA di mettersi alla ricerca di Lucia e di impetrare per questo l’intervento divino.
La questione (per Manzoni, si intende, e per la dottrina cristiana) è importante: solo essendosi purificato con l’avere dato il perdono (prerogativa divina che però è alla portata anche di ogni essere umano) Fermo può aspirare a essere ascoltato da Dio nella sua invocazione di ritrovata serenità.
La invocazione di Renzo viene rappresentata da Manzoni con tutti i crismi (T. 4, cap. 8, 97d, evidenziazioni nostre):
«Si prostrò su gli scaglioni del tempio, fece a Dio una preghiera, o per dir meglio, un viluppo di parole scompigliate, di frasi interrotte, di esclamazioni, di domande, di proteste, di disdette, uno di quei discorsi che non si fanno agli uomini, perché non hanno abbastanza penetrazione per intenderli, nè sofferenza per ascoltarli; non sono abbastanza grandi per sentirne compassione senza disprezzo. Si levò di là più rincorato e si avviò.»
È subito dopo questa invocazione a Dio che Renzo ritrova Lucia.
E come volete che risponda Dio all’invocazione di un fedele se non attraverso la propria VOCE?
14.6/ In Epilogo/Camerini è l’umano ad agire; in Manzoni è il divino.
Parliamo un po’ in punto di dottrina: nel Cristianesimo (a differenza che nell’Ebraismo e nell’Islamismo, le altre due grandi religioni rivelate nelle quali Dio comunica con l’uomo esclusivamente attraverso la parola) la rivelazione di Dio all’uomo passa anche attraverso la vista e le immagini — la comunicazione non è aniconica come le altre due.
Ma ciò non toglie il rilievo assoluto della Parola (Logos) intesa come modalità primaria ed eterna della Creazione/Rivelazione, che pur si è manifestata visivamente nella storia con l’Evento della Incarnazione.
Detto altrimenti: anche se nel Cristianesimo l’immagine ha un ruolo positivo, lo ha solo nella misura in cui “dice” un richiamo che echeggia da sempre, perché trasmette il rapportarsi e relazionarsi di Dio con l’uomo, facendosi da lui sentire e non restando muto.
Ed è quindi del tutto ovvio che, a Renzo, Manzoni faccia ritrovare Lucia attraverso la VOCE.
Si intende che è Dio che parla a Fermo attraverso Lucia; e infatti la frase che Renzo sente è a doppio registro: «Non dubitate = son qui tutta per voi = non vi abbandonerò mai.», dove, oltre che la donna fedele al suo amato, è ovviamente la divinità che assicura: non abbandonerò mai colui che non dubita!
Badate che, a differenza della necessità di uno sguardo reiterato come nel duo Epilogatore / Camerini, in Manzoni, Renzo non ha bisogno di sentire ripetere la indicazione divina, per definizione perfetta: «sentì venire una voce… una voce, giusto cielo! che egli avrebbe distinta in un coro di cento cantanti».
Qui Manzoni scrive a prova di tonti: è inequivocabile!
È quindi chiaro: per la coppia Epilogatore / Camerini Renzo trova Lucia attraverso un proprio impulso, rimanendo in un ambito esclusivamente umano.
Per Manzoni, invece, è Dio che, da lui pregato, consente a Renzo di ritrovare Lucia: i teologi ci consentano il linguaggio un po’ alla mano: all’uomo spetta il compito gravoso (ma anche esaltante) di non essere un pupazzo in balia della divinità ma di potere influire su se stesso e sulla collettività con la propria intelligenza, moralità e volontà — il che è perfettamente in linea con la concezione di Provvidenza che proprio in quel torno di tempo Manzoni viene elaborando: questa governa l’Universo ma l’uomo non ne è affatto un elemento passivo.
A prescindere dal profilo esistenziale che ognuno di noi può avere, è chiaro a chiunque che, quella indicata dal duo Epilogatore / Camerini da una parte e Manzoni dall’altra, non è difformità di dettaglio ma va al cuore dell’intero impianto del romanzo di Manzoni.
Non siamo in grado di affermare su base documentale a cosa sia dovuto questo significativo allontanamento da Manzoni da parte di Camerini: più che a una volontà di revisione del pensiero dello scrittore, ci sembra si debba ascrivere a semplice inconsapevolezza.
Vista la formazione familiare di Mario Camerini (aquilano e di una famiglia di magistrati, il padre Camillo era un noto avvocato, ai primi del ’900 con ruoli di responsabilità nel Partito Socialista in Roma — il che però non significa molto), è probabile che il suo sguardo (ci sembra tendenzialmente laico e con non evidenti interessi per gli aspetti teologici) non abbia neppure percepito l’opportunità di valutare con attenzione questi aspetti, non appariscenti ma invece rilevanti sul piano culturale-religioso.
Del pari, uno degli sceneggiatori del film, il giovanissimo Gabriele Baldini (nel 1950 con lui si sposerà in seconde nozze Natalia, dal 1944 vedova di Leone Ginsburg), con tutto il suo talento letterario non sembra avere avuto alcuna consapevolezza dei contenuti dottrinali del romanzo di Manzoni.
Ciò che invece fa specie è l’essere esattamente sulla sua stessa traccia narrativa l’Epilogatore che (ce lo dice come altamente probabile la Professoressa Paola Italia) doveva essere sia un intrinseco di Manzoni sia — addirittura — un ecclesiastico.
Non è che, anche in questo caso, l’Epilogatore, dimenticando di essere sia un intrinseco di Manzoni sia un ecclesiastico, sia rimasto così preso da Camerini da riprodurre con la sua penna (su fogli eventualmente prodotti entro il 1835) ciò che aveva visto sullo schermo, in un qualche momento dopo il dicembre 1941?
Scherziamo, naturalmente!
Ma, intanto, mostriamo come hanno risolto la cosa gli altri tre registi:
— Bonnard (1922) ha anticipato Camerini, tradendo Manzoni: Renzo e Padre Cristoforo si aggirano per il Lazzaretto; Renzo vede dalla porta di una capanna la sua Lucia. Il film era muto e forse poteva risultare macchinoso il mostrare il suono di una voce (tutto si può fare comunque! e anzi ne sarebbe venuta una cosa rimarchevole).
— Bolchi (1969), invece, per questa sequenza è stato fedele a Manzoni, mostrando bene che il problema non era di carattere tecnico-scenico: Castelnuovo sente alle sue spalle la voce di Lucia, entra nella capanna: vi ritrovo!.
— Nocita (1989), infine, ha scelto di dare un colpo al cerchio e uno alla botte (Quinn sente e vede insieme la sua Lucia).
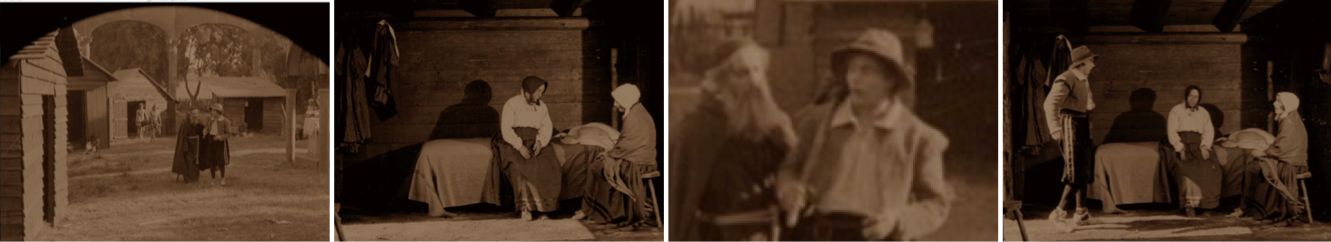

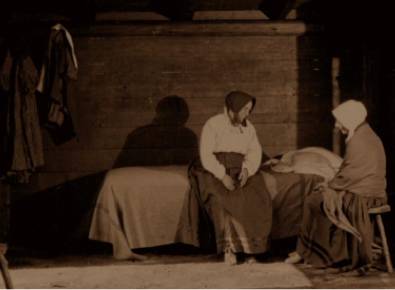


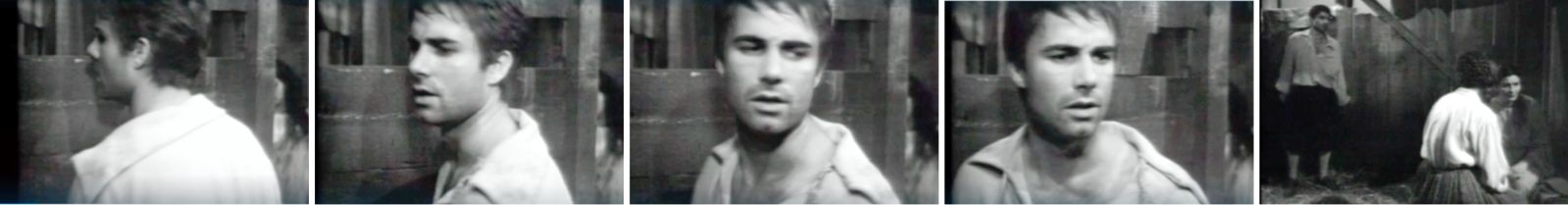

14.7/ Sempre nel Lazzaretto, un grappolo di difformità.
A conclusione di questo regesto delle difformità tra Epilogo del «Manoscritto Lecco 170» e “Prima Minuta” di Manzoni, dobbiamo evidenziarne un grappolo, tutto relativo alla parte conclusiva del ritrovamento di Lucia al Lazzaretto da parte di Fermo.
Le difformità sono tre e si susseguono l’un l’altra. Meritano però di essere evidenziate partitamente per le importanti implicazioni di ognuna di esse sui contenuti “morali” (usiamo questo termine sempre in senso lato) della nostra discussione.
Riteniamo quindi opportuno, presentare prima di tutto il testo dell’Epilogo a esse relativo per poi esaminare ogni singola difformità.
Vediamo intanto come le cose sono presentate nell’Epilogo (carta 19r-19v-20r, p. 37-38-39, evidenziazioni nostre):
«[Padre Cristoforo] si rende alla capanna di Lucia. E qui la persuade, ed in nome della Chiesa la scioglie dal voto. Quindi si congeda, dando agli sposi promessi un addio, che bene si avvisano essere l’ultimo.
Rimane Fermo; e consente, che Lucia resti ad assistere la compagna, donna facoltosa, finché sia ristabilita. E perchè lo scroscio d’immensa pioggia seguito all’apparso nembo minaccioso fece [19v] rallentare la peste, vi rimase esso pure.
In questo mezzo, ecco furiosamente avventarsi, e presentarsi alla capanna un appestato frenetico, lacero, livido, presago di morte vicina; ed era / oh spettacolo! / D. Rodrigo, il quale, sebbene trasognato, aveva raffigurati nel passaggio il P. Cristoforo, e Fermo. Egli, sbarrando due occhi mezzo fra istupiditi e furiosi, ribalza indietro, e, datosi a correre pel campo, afferra un cavallo de’ Monatti, e gettatosi d’un salto sopra, come furiosamente inseguito da’ Monatti, perduta ogni lena, cade e muore, ed è condotto alla fossa.
Fermo, e Lucia colla compagna, veduta la trista fine di quel prepotente, gli pregano pace, avendo Fermo obbliata la vendetta, e promesso perdono [20r] all’esortazione del P. Cristoforo.
Ma, cessando ormai dovunque il flagello della peste, sortono da Lazzaretto; e la compagna si offre a scortarli alla loro terra, ed a fornire un equipaggio di vesti a Lucia, volendo prender parte alla di Lei consolazione.»
Questo brano dell’Epilogo sembra essere stato strutturato per dire chiaro e tondo anche al lettore più distratto: guarda che quanto leggi qui ha poco a che vedere con la “Prima Minuta” di Don Lisander.
Per capire perché, vediamo intanto di renderne più intelligibile il testo, decisamente ingarbugliato.
1/ Facendo intendere sia l’ultimo incontro, P. Cristoforo si congeda dai due sposi e lascia la capanna.
2/ Fermo invece vi rimane; concorda che Lucia assista la compagna [è la vedova assistita da Lucia] fino a guarigione completa.
3/ Inizia l’acquazzone che farà rallentare la peste; Fermo rimane al Lazzaretto.
4/ “Nel mezzo” [non è chiaro fra quale dei tre punti sopra esposti], alla capanna si presenta un esagitato Don Rodrigo; squadra con furia gli Sposi; fa dietro-front; inforca un cavallo dei Monatti; inseguito dagli stessi lo lancia al galoppo; cade, muore, è sepolto.
5/ Fermo, Lucia e la vedova pregano per lui, avendo Fermo, sollecitato da P. Cristoforo [non è detto quando], promesso il perdono.
6/ Esauritasi la peste, entrambi gli sposi lasciano il Lazzaretto per il loro paese; li accompagna l’amica di Lucia che le dona il corredo.
L’Epilogo mette a dura prova la pazienza del lettore ma soprattutto non lascia dubbi sulla sua estraneità rispetto a Manzoni che nella sua “Prima Minuta” la racconta ben diversamente:
1/ Sciolta Lucia dal voto di castità, P. Cristoforo raccomanda agli sposi l’unità nell’amore.
2/ Mentre egli parla di amore e rispetto, appare Don Rodrigo, stravolto e lacero, che guata con furore e paura: visti passare, non visto, Fermo e il Padre, gli era rinato il desiderio di vendetta; intravistili nella capanna aveva udito la voce del Padre Cristoforo, che già in altra occasione (all’inizio del romanzo) aveva disprezzata.
3/ Lucia ne è terrorizzata; Padre Cristoforo e Fermo hanno invece un moto di compassione e gli si avvicinano per aiutarlo; lo seguono per un tratto mentre il delirante fugge correndo frenetico verso la chiesa.
4/ Don Rodrigo si appropria di un cavallo dei monatti, vi sale e lo lancia al galoppo, provocando lo scompiglio generale.
5/ I due uomini tornano alla capanna; P. Cristoforo invita a pregare per l’infelice; dopo un momento di silenzio, concertano il da farsi: Fermo partirà immediatamente, troverà ricovero lungo il cammino; andrà al paese a dare le nuove ad Agnese; andrà a Bergamo a predisporre per la famiglia; tornerà al paese in attesa di Lucia per celebrare le nozze con Don Abbondio.
6/ Lucia vuole attendere che l’amica sia guarita; essendo unanime l’accordo, questa promette di accompagnare Lucia e di donarle il corredo.
7/ Essendo ormai prossima la notte, P. Cristoforo invita Fermo a mettersi in cammino; al giovane spiace soprattutto di lasciare il buon frate che intuisce non rivedrà; lo riverisce; saluta Lucia e la vedova; ormai col buio, esce dal Lazzaretto diretto a Lecco.
8/ Il P. Cristoforo assicura Lucia che Don Rodrigo non tornerà; raccomanda le donne a un frate e lascia la capanna; Lucia lo segue; vedono Don Rodrigo morto portato da un gruppo di monatti che lo gettano su un carro commentandone con scherno la fine; il Padre raccomanda a Lucia di pregare per il poveretto; si allontana definitivamente; commossa, Lucia rientra alla capanna.
9/ Nella notte si scatena la tempesta; lungo il cammino Renzo alloggia come può e il terzo giorno, sempre sotto l’acqua battente, giunge al paese; poi va a Bergamo; ritorna al paese, ecc. ecc.
10/ Guarita la vedova, Lucia passa la quarantena in casa di questa lavorando al corredo; alla fine vengono a sapere che il P. Cristoforo è morto; le due donne vanno insieme al paese degli sposi, dove Renzo è in attesa della promessa per celebrare il matrimonio, ecc. ecc.
Rispetto al testo di Manzoni (che Paola Italia sostiene essere reso fedelmente dal manoscritto in esame) l’Epilogo in 198 parole contiene quindi tre difformità strutturali, significative anche sul piano dei contenuti etici del romanzo di Manzoni:
— che P. Cristoforo sia assente durante l’incursione di Don Rodrigo;
— che durante e dopo lo “scroscio d’immensa pioggia” Fermo se ne stia tranquillo al Lazzaretto, assieme alla sua Lucia e alla vedova;
— che, ormai esauritasi la peste, i due sposi e la vedova partano insieme per Lecco.
Analizziamo queste tre difformità.
Difformità n. 21 — Invenzione originale.
14.8/ “Padre Cristoforo quindi si congeda” …
Lo abbiamo già evidenziato: secondo l’Epilogo Don Rodrigo irrompe quando Padre Cristoforo “si è già congedato”, ossia non è più con i promessi sposi.
Il che non è tanto un diverso modo di presentare fatti (cosa ammissibilissima in qualsiasi riduzione di un’opera letteraria) ma è un diverso modo di rappresentarne i contenuti.
Padre Cristoforo e Don Rodrigo: si chiude il cerchio.
Ripetiamolo: secondo l’Epilogo, la apparizione di Don Rodrigo avverrebbe quando già P. Cristoforo si è congedato definitivamente dai quasi sposi.
Come abbiamo poco sopra sintetizzato, in Manzoni il Padre è invece presentissimo e, come sempre, svolge un ruolo decisamente attivo.
Da notare che Manzoni, con questa sequenza, chiude il cerchio del rapporto tra Padre Cristoforo e Don Rodrigo, avviato a inizio racconto nel troppo noto incontro al palazzo di Don Rodrigo, finito con maledizioni da una parte e minacce di bastonatura dall’altra.
Da notare, inoltre, che Manzoni ci propone questa conclusione richiamando il ruolo della VOCE, che abbiamo già sviluppato nel capitolo precedente a proposito delle modalità di ritrovamento di Lucia da parte di Fermo (T. 4, cap. 9, 110b, p. 571, evidenziazioni nostre):
«Quell’infelice da una capanna, […] aveva veduto passarsi davanti Fermo, e poi il Padre Cristoforo; senza esser veduto da loro. Quella comparsa aveva suscitato […] l’antico furore, e il desiderio della vendetta […] in un tale delirio […] aveva tenuto dietro da lontano a quei due. […] mettendo il capo su la porta aveva rivedute in iscorcio quelle figure. Quivi […] udì quella voce ben conosciuta che nel suo castello aveva intuonata al suo orecchio una predica troncata allora da lui con rabbia e con disprezzo ma che aveva però lasciata nel suo animo una impressione che s’era risvegliata nel tristo sogno precursore della malattia. […] Quella voce lo teneva immobile a quel modo che altre volte si credeva che le biscie stessero all’incanto.»
Nella ricerca di Lucia, la divinità si rivela a Fermo attraverso la voce della amata; a Don Rodrigo in delirio (anch’egli alla ricerca di Lucia ma con ben altre intenzioni) la divinità si rivela attraverso la voce del sacerdote/frate, in inevitabile continuità oppositiva al suo animo ottenebrato dalla prepotenza.
È ovvio anche a un bimbo che, in assenza di P. Cristoforo, risulterebbe impossibile rappresentare questo snodo espositivo, decisamente articolato sul piano concettuale,
Ma l’Epilogo si fa un baffo della coerenza narrativa e dottrinale e scodella il suo inconsapevole minestrone di parole in libertà.
Difformità n. 22 — Omogenea al film di Camerini, 1941
14.9/ “Fermo vi rimase egli pure” …
È questa dell’Epilogo una trovata narrativa veramente “innovativa” rispetto a Manzoni che — lo abbiamo visto in sintesi più sopra — la racconta in modo radicalmente diverso.
Secondo l’Epilogo, il P. Cristoforo se ne va; si scatena la tempesta; Fermo rimane.
Dove rimane? Nella capanna di Lucia e della vedova, posta nell’area del Lazzaretto riservata alle donne?
Il Promesso sposo aspetta lì non solo che spiova ma anche che “sia cessato ovunque il flagello della peste”; quindi 2 giorni di pioggia + almeno 20 giorni di quarantena = tre settimane?
È così?
Il lettore non si deve inquietare per il nostro uso del calendario: quando ci si trova di fronte a conclamate manifestazioni di marasma narrativo e intellettivo, bisogna pure fissare dei termini di riferimento condivisibili! o no?
Comunque, l’Epilogatore, ancora una volta — e siamo a quattro — alla compagnia di Manzoni preferisce quella di Camerini.
Alla pioggia, e al modo con cui viene accolta da chi era al Lazzaretto, Camerini dedica una carrellata lunga 110 secondi tutta articolata sul ringraziamento alla divinità per il nubifragio (c’è anche un malato che — la scena risulta inevitabilmente grottesca — muore sotto l’acquazzone facendosi il segno della croce).
Si dirà: e che c’è di strano? la popolazione in Milano era molto religiosa e quindi …
Benissimo!
Qui però non stiamo discutendo su se e come fossero religiosi i milanesi ma in che modo Manzoni ritenne di rappresentare quel determinato fenomeno nel quadro del più ampio evento della peste e della vicenda dei due promessi sposi.
Lasciando per il momento da parte il tema tempesta/peste (discorso meritevole di riflessioni ma estraneo a questa Nota) dobbiamo ricordare che, comunque sia, in Camerini, mentre si scatena la tempesta, Renzo è al Lazzaretto con Lucia, ossia, come scritto nell’Epilogo “rimane esso pure”.
Il regista Camerini ha infatti la bella trovata di fare terminare proprio lì, al Lazzaretto, il romanzo di Manzoni assieme col suo film: con Renzo e Lucia che, fianco a fianco, in ginocchio, estatici ringraziano il Signore.
E poi che fanno? Camerini non lo mostra perché ci mette la parola FINE.
Ma ogni spettatore, inevitabilmente, ne ricava che, di fatto, in quel momento i promessi si sono ricongiunti — anzi si possono considerare come sposati.
Camerini infatti non ci dice nulla sul capitolo conclusivo de “I promessi Sposi”, in Manzoni denso di contenuti etici, tra cui — fondamentale — la celebrazione del matrimonio.
Più sotto illustriamo in dettaglio come questa invenzione narrativa di Camerini (e dell’Epilogatore) non solo non segue Manzoni (in una riduzione non è obbligatorio un ricalco in ghisa dell’originale) ma è in opposizione con lui su una questione molto seria: il rapporto tra Renzo e Lucia.
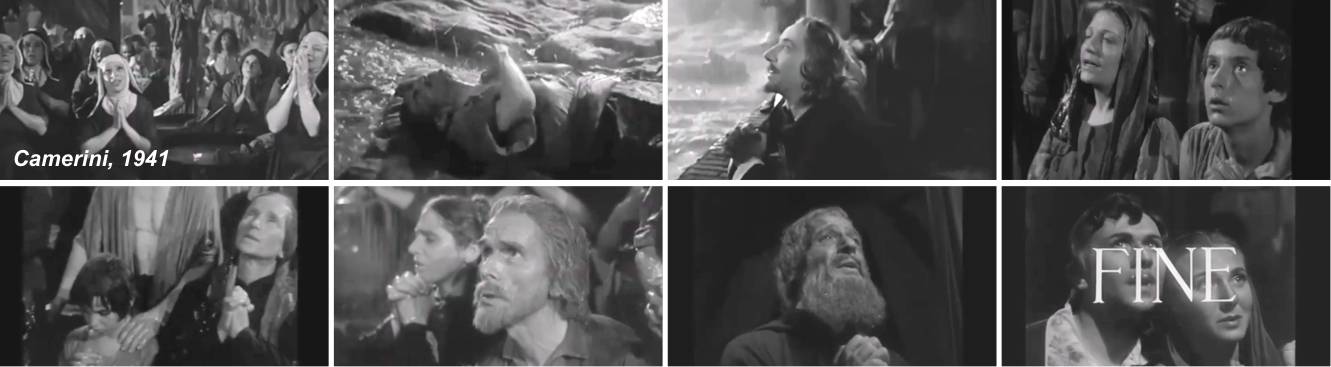
E allora vediamo come la racconta Manzoni: è una storia tutta diversa!
Attraverso la penna di Don Lisander, Padre Cristoforo insiste perché Fermo si allontani subito dal Lazzaretto (e da Lucia) (T. 4, cap. 9, 111c, p. 572):
«Dopo un momento di silenzio, il pensiero che venne a tutti fu di concertare insieme quello che era da farsi: e i concerti furon questi: che Fermo partirebbe tosto, giacchè ivi non v’era ospitalità da offerirgli, cercherebbe un ricovero per la notte in qualche albergo e all’indomani si rimetterebbe in via pel suo paese, […]»
non solo, ma al promesso sposo fa anche dire che ne è contento (T. 4, cap. 9, 112a, p. 573):
«E tu, disse poi a Fermo, che stai qui tardando? il tempo, come vedi, si fa più nero, e la notte si avvicina = affrettati di cercare un ricovero.
Convien dire ancora ad onore di Fermo che in quel momento non gli doleva tanto lo staccarsi da Lucia appena trovata, è vero, ma ch’egli contava di riveder presto, quanto dal Padre Cristoforo, che restava lì a morire.»
Alla luce di queste inequivocabili espressioni di Manzoni risulta veramente curioso ciò che invece ci dice l’Epilogo — ripetiamolo — secondo cui Fermo si sarebbe fermato per tre settimane al Lazzaretto con Lucia — per soprammercato, essendosi il Padre Cristoforo da loro “definitivamente congedato”.
Il lettore potrebbe pensare che sì, effettivamente, questa narrazione dell’Epilogo non c’entra proprio nulla con Manzoni; ma forse la “Prima Minuta” in questo punto non era ben leggibile e quindi il povero Epilogatore ha preso involontariamente un abbaglio.
Spiace dire che non è affatto così: il manoscritto di Manzoni in questa sequenza è perfettamente leggibile, come può constatare ogni lettore scorrendo i manoscritti di Manzoni messi molto opportunamente a disposizione del pubblico.
La difformità n. 22 che abbiamo appena evidenziato, è sicuramente la più significativa sul piano dei contenuti morali ed etici e ci conferma della lontananza abissale tra l’estensore dell’Epilogo e Manzoni.
Attenzione: diciamo proprio lontananza da Manzoni, non solo dalla sua “Prima Minuta” del romanzo.
L’Epilogatore, in perfetta linea con Camerini (cui, in questo, si allineò più tardi Salvatore Nocita nel suo “I Promessi Sposi” del 1989) con quella bella trovata di un Fermo che “rimase egli pure” al Lazzaretto per tre settimane con Lucia, ci indica infatti una totale estraneità al mondo manzoniano.
Per come Don Lisander vedeva il senso e il significato della vita di coppia (il matrimonio è la via per la santificazione), gli sarebbe parsa inconcepibile anche solo l’idea che Fermo/Renzo, prima del matrimonio, potesse starsene con Lucia per tre settimane, come scritto a chiare lettere nell’Epilogo.
Ma passiamo all’ultima difformità: il lettore si tenga forte perché questa è proprio formidabile e insieme ridicola!
Difformità n. 23 — Invenzione originale.
14.10/ “Sortono da Lazzaretto e la compagna si offre a scortarli alla loro terra” …
Delle 23 difformità tra Epilogo e “Prima Minuta” questa è sicuramente la più bizzarra e anche la più lontana da qualunque elaborazione di Manzoni.
Per rinfrescare la memoria del lettore riprendiamo l’intera narrazione dell’Epilogo (carta 19r-19v-20r, p. 37-38-39, evidenziazioni nostre):
«Rimane Fermo; e consente, che Lucia resti ad assistere la compagna, […] E perchè lo scroscio d’immensa pioggia seguito all’apparso nembo minaccioso fece [19v] rallentare la peste, vi rimase esso pure. […] Ma, cessando ormai dovunque il flagello della peste, sortono da Lazzaretto; e la compagna si offre a scortarli alla loro terra.»
Quindi, secondo l’Epilogo, Fermo se ne sta al Lazzaretto, aspettando non solo che spiova ma anche che si esaurisca la peste.
Dopo di che, passata la quarantena, con la sua Lucia e con la nuova amica di questa se ne vanno tutti e tre a Lecco, per il matrimonio, ecc.
Ci sarebbe da farsi una risata e mollarla lì ma dobbiamo andare fino in fondo!
Come appare anche al lettore più distratto, l’Epilogo si è qui mosso come quei falsari che, appositamente, producono banconote con imperfezioni evidenti, al fine di fruire di uno sconto di pena in caso di arresto.
Manzoni ovviamente la racconta in modo totalmente differente e anche con implicazioni etiche non irrilevanti.
È in questo snodo della narrazione che Manzoni presenta infatti, in sintesi e in modo molto discorsivo, la propria idea di Provvidenza attraverso i pensieri e gli atteggiamenti di Fermo/Renzo che, lasciato il Lazzaretto e Milano, sotto la pioggia battente cammina verso Lecco (anche saltellando come un ragazzino tra le tante pozze d’acqua che costellando il suo cammino — nella Ventisettana Manzoni lo paragona a un cane barbone che si scuote), in una più che trasparente metafora di un mutamento radicale di vita, più consapevole e più maturo.
Ci sarebbero ovviamente molte altre cose da dire ma qui è sufficiente avere rilevato questa pacchiana e ultima difformità tra Epilogo e “Prima Minuta”.
Utile anche a chiedere ai vari Prof. che si sono accodati alla audace invenzione critica della loro collega Paola Italia: ma che ne dite di queste due dozzine di insanabili dicotomie tra Epilogo del «Manoscritto Lecco 170» e “Prima Minuta” di Manzoni?
Tutto regolare?
Ringraziamenti.
Per questa sezione, dedicata anche al trattamento cinematografico de “I Promessi Sposi”, vogliamo ringraziare il gentilissimo Salvatore Nocita per avere accettato di incontrare chi scrive, nonché il caro amico Giulio Martini, critico cinematografico di lungo corso, che ha reso possibile l’incontro dandovi, come suo solito, un prezioso contributo di idee e di stimoli.
Senza il medesimo amico (anche preparatissimo studioso della intricata algebra teologica) saremmo annegati come gattini ciechi nelle tante questioni dottrinali implicite nel romanzo di Manzoni: grazie ancora per la pazienza e la competenza con cui ha risposto alle tante richieste di chiarimento (alcune sicuramente anche bizzarre) che gli abbiamo rivolto in questi mesi.
Va da sé che Giulio Martini non è in nulla e per nulla responsabile di quanto abbiamo scritto in questa lunga Nota, se non in quanto ci ha dato amichevolmente corda a esprimere quanto avevamo in mente.
15. Per concludere.
Non avendo ancora potuto analizzare dal vivo il «Manoscritto Lecco 170» e non avendo il riscontro di serie analisi strumentali, tese quanto meno a indicare non trattarsi di un volgare pseudo-documento, confezionato da qualche furbone a metà del secolo scorso, con la Nota che abbiamo sopra presentato, ci eravamo prefissi pochi e ben circoscritti obiettivi:
a / Dimostrare la inconsistenza della “trascrizione diplomatica” del «Manoscritto Lecco 170», proposta dalla Professoressa Paola Italia e viziata da inescusabili cecità e dilettantesca superficialità.
b/ Evidenziare la nullità della dichiarata coerenza di trama tra l’Epilogo “Gli Sposi Promessi” e “Prima Minuta” di Manzoni, ossia del presupposto su cui è stata costruita la operazione “Gli Sposi promessi su Internet”.
c/ Indicare la vacuità dell’attribuzione “a occhio” della supposta autografia manzoniana delle sei parole « di trovare, che quelle opinioni vi — » alla carta 47r, ossia la “prova forte” con cui dare credibilità alla medesima operazione.
Ci sembra che sui due primi argomenti nessuno possa avere da dire circa le nostre conclusioni — sono elementi oggettivi sui quali c’è poco da discettare.
Circa la sbandierata “autografia manzoniana” di quella insulsa frasetta di sei parole alla carta 47r, abbiamo indicato il carattere puramente favolistico della attribuzione a Manzoni da parte di Paola Italia e presentato invece una nostra vera perizia forense che indica come “altamente improbabile” che la frasetta sia di mano di Manzoni.
Circa questo ultimo elemento, non avendo il nostro perito Dottoressa Iarussi potuto operare sul manoscritto originale, la analisi ha dovuto necessariamente rimanere limitata ad alcuni aspetti, trascurandone altri — molto importanti — riscontrabili solo ad una analisi diretta del documento.
Saremo ovviamente ben lieti di potere completare anche questa parte della perizia.
Riteniamo così di avere creato i presupposti perché, in una prossima Nota già in preparazione, si possa affrontare il tema realmente interessante, ossia il passaggio dalla “Prima Minuta” a “I promessi Sposi” da un punto di vista etico e non solo artistico o linguistico.
Per chiudere vorremmo però richiamare l’attenzione del lettore su un aspetto importante.
Ma che valore ha il controllo della comunità scientifica?
A conclusione di questa Nota, incentrata soprattutto sulla “diplomatica colabrodo”, poniamo un problema di carattere generale.
I due studi di Paola Italia sono stati infatti pubblicati (nel 2018 e nel 2019) sulla rivista “Annali Manzoniani” edita dal Centro Nazionale Studi Manzoniani.
La quale rivista ha una politica editoriale esposta con chiarezza (vedi qui) e in apparenza piuttosto rigorosa:
Per la selezione dei contributi è prevista la seguente procedura:
— L’autore invia il suo contributo.
— Il testo viene valutato in forma anonima, secondo il sistema double blind, da due revisori (referees), un esterno e un componente del Comitato Scientifico, che avranno due mesi di tempo per formulare la loro valutazione.
— La rivista comunica all’autore la risposta finale, che contiene la valutazione anonima dei revisori.
E questo è quanto previsto per il Processo di revisione (Peer-review process):
«La rivista, che ha cadenza annuale, adotta il sistema di revisione del doppio cieco (double blind peer review process). I contributi proposti vengono trasmessi ai revisori anonimi solo dopo essere stati approvati da almeno due componenti del Comitato Scientifico.»
A proposito di “Comitato Scientifico” può essere utile conoscerne i componenti: Mario Barenghi (Università di Milano Bicocca, direttore responsabile), Giuseppe Antonelli (Università di Cassino), Mariarosa Bricchi, María de las Nieves Muñiz Muñiz (Università di Barcellona), Paola Italia (Università di Bologna), Salvatore Silvano Nigro (Università di Zurigo), Mauro Novelli (Università Statale di Milano), Giulia Raboni (Università di Parma), Angelo Stella (Università di Pavia, presidente del Centro Nazionale Studi Manzoniani).
_______
Sarebbe interessante, per i due studi della Professoressa Italia, conoscere la “valutazione anonima” sia dei membri del “Comitato Scientifico” (di cui fa parte l’autrice Professoressa Paola Italia) sia degli “esterni” che hanno dato il via libera alla loro pubblicazione.
Viene infatti spontaneo chiedersi: ma con quali criteri / strumenti hanno valutato quel colabrodo di “trascrizione diplomatica” del manoscritto conservato a Lecco?
E con quali strumenti hanno giudicato attendibile l’attribuzione delle sei parole alla scrittura autografa di Manzoni?
Detto altrimenti: se il Centro Nazionale Studi Manzoniani, deputato dal 1937 alla conservazione della memoria e della figura di Manzoni, non è in grado di intercettare almeno queste evidenti castronate, a chi deve affidarsi il cittadino che voglia avere una informazione puntuale sull’autore de “I Promessi Sposi” — possibilmente senza ingenuità da matricole alle prime armi?
Giriamo la domanda soprattutto ai responsabili della cultura manzoniana della città di Lecco, invitandoli — una volta ancora — a non affidarsi come pecorelle smarrite alle direttive / suggestioni di questo o quell’organismo più o meno deputato alla conservazione e valorizzazione della memoria di Manzoni ma a sviluppare una propria capacità di analisi e di verifica: ben vengano i contributi esterni ma il Museo Manzoniano di Lecco deve essere in grado almeno di separare la pula dal grano!
Fabio Stoppani